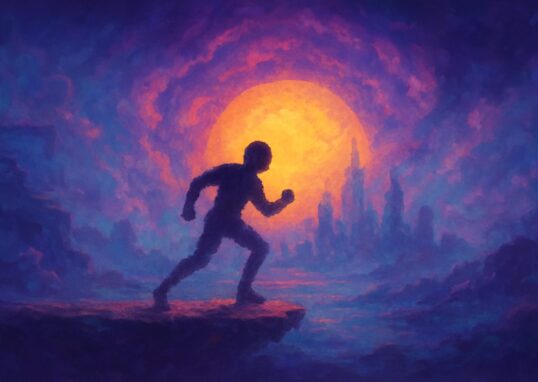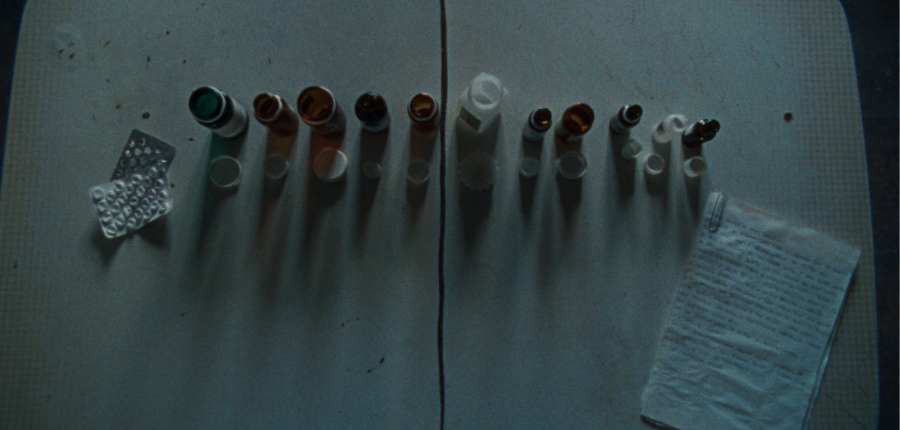“Il significato deve essere incorporato in una storia, deve concretizzarsi all’interno di essa. Quando qualcuno chiede di cosa parla una storia, l’unica risposta appropriata è consigliargli di leggerla. Nella narrativa, il significato non è astratto, ma vissuto”.
Flannery O’Connor
[con più di qualche spoiler]
Era così riuscita la prima stagione di The Last of Us e così a fuoco – senza falsa modestia – ciò che ne avevo scritto all’epoca, che adesso faccio molta fatica a scrivere della seconda stagione appena terminata. Sempre senza falsa modestia, e con quell’inelegante tocco di autoreferenzialità che caratterizza il nostro vivere online, mi autocito: “Restituendo complessità e pluralità di voci ai suoi personaggi, la prima stagione di The Last of Us è riuscita a diventare in parte anche altro da sé, dal suo materiale originale. Lo ha fatto con coraggio e personalità, tanto da rappresentare, per molti critici, un nuovo punto di riferimento per la serialità televisiva”. Allora proviamoci: cos’è andato storto con questa seconda stagione?
Ma davvero, preferirei non farlo. Preferirei non scrivere della seconda stagione di The Last of Us, principalmente per il legame emotivo che soffro rispetto al secondo capitolo della serie videoludica. A volte penso che chi ha giocato Part 1 e Part 2 dovrebbe tacere, quando si parla dell’adattamento televisivo: stiamo tutti lì col ditino puntato a dire “eh ma qui non è come nell’originale”, “oh ma questa Ellie non funziona mica”, eccetera, senza considerare il fatto che finora la serie ha coperto solo la prima metà del secondo capitolo. Ciononostante, sento l’urgenza di dire alcune cose, e di provare a dirle meglio di quello che leggo in giro, perché il guaio della seconda stagione di The Last of Us è che resta un buon prodotto seriale. Allo stesso tempo, porta il senso del secondo capitolo videoludico da un’altra parte: il che andrebbe pure bene. Il problema è come lo fa.
Partiamo da un presupposto: entrambe, sia la serie che il videogioco, nel secondo capitolo si sbarazzano subito dal modello narrativo de La Strada di Cormac McCarthy. Uccidere Joel serve, simbolicamente, proprio a questo: basta adulto + ragazzina in viaggio per un mondo finito, raccontiamo un’altra storia. Che diventa un superbo racconto morale di ossessione e vendetta cieca e infinita (e inutile). Chi ha giocato il videogioco ha impiegato diverse ore (circa 30) per comprenderlo e ne è uscito devastato. Credo che un po’ tutte e tutti siamo arrivati al punto, negli ultimi minuti del gioco, di non voler premere i tasti del pad, implorando Ellie di farla finita. E già qualche ora prima ci eravamo trovati a pregarla di tornare indietro, di smetterla con questa storia di vendicare Joel a tutti i costi. Maledicendo nel frattempo Abby, e poi imparando a conoscerla e a empatizzare con lei perché obbligati a farlo – essendo costretti a essere lei più o meno a partire da metà del gioco.
Per molte persone che hanno giocato Part 1 e Part 2, questi videogiochi rappresentano un trauma. Penso che tradurre quel trauma in sostanza filmica fosse un’impresa ai limiti dell’impossibile, soprattutto per Part 2. Se Part 1 ha una storia tutto sommato lineare, che concede diversi spazi per l’adattamento, la riscrittura e anche l’ampliamento del materiale di partenza, Part 2 ha una serie di elementi che richiedono l’interazione per poter arrivare a colpire a fondo, e soprattutto un alternarsi di punti di vista e piani temporali che sono difficilmente gestibili in una stagione televisiva di sole sette puntate (da nemmeno un’ora ciascuna, peraltro). Il fatto che ci saranno altre stagioni non aiuta. Nel frattempo, tra l’uscita di una stagione e l’altra, l’intensità del racconto rischierà di andare perduta – almeno è quello che temo: nel videogioco, il passaggio tra i punti di vista delle protagoniste non era un semplice twist narrativo, ma un vero e proprio shock immediatamente funzionale a un racconto continuo, senza alcuna interruzione.
Inoltre, mentre è impegnata a fare del necessario worldbuilding (chiedo venia), dando spazio alla vita all’interno di Jackson e al conflitto tra Washington Liberation Front e Serafiti a Seattle, la serie si trova a recuperare minutaggio a scapito degli eventi che rendono tragica – infinitamente tragica – la storia di Ellie e di Abby. Le parti action si succedono velocemente, senza il tempo necessario a impattare psicologicamente sui personaggi e sullo spettatore. Nel finale dell’ultima puntata vediamo Ellie affrontare un naufragio, subire un tentativo di impiccagione, provocare un triplice e particolarmente drammatico omicidio – con una sola pallottola – prima di scontrarsi con Abby al teatro. Tutto nel giro di pochissimi minuti (su circa tre quarti d’ora di durata).
Ci sono poi parti più lente, in cui i personaggi dialogano approfondendo le loro relazioni, che però offrono lo stesso didascalismo che affligge oggi molta scrittura, per cui si tende a far parlare un character molto più del necessario. Un esempio su tutti è il confronto tra Joel e Ellie sotto la veranda nella sesta puntata, quando la ragazza chiede, per l’ultima volta, tutta la verità sui fatti di Salt Lake City. A quel punto Joel vuota il sacco (sì, sto parlando come in una serie americana) fino a pronunciare il frasone sull’essere genitori migliori dei propri genitori. È una battuta che sta lì giusto per rimare con quanto detto dal padre di Joel al figlio nel 1983, cioè nel flashback di inizio puntata – ed è una cosa totalmente inutile, che nulla aggiunge al personaggio di Joel o al suo rapporto con Ellie, rischiando di banalizzare i temi della serie (la genitorialità su tutti).
Questo didascalismo è figlio di un eccesso di scrittura: buona scrittura, immagino, dal punto di vista di autori e sceneggiatori; una scrittura piuttosto autocompiaciuta, invece, dal mio. Un po’ come per il monologo sulle padelle di Isaac: è un bel sentire, certo, ma è puramente estetico e anche in questo caso non aggiunge nulla al personaggio, già caratterizzato a sufficienza dalla successiva scena di tortura, come da quella in cui fa fuori un’intera squadra della FEDRA per passare nei ranghi del nascente WLF. Questo eccesso di scrittura, molto spesso letterale (se n’è parlato in un articolo del Post), è probabilmente un modo per venire incontro al pubblico, per essere più chiari e fare sì che nulla vada perso per strada, cancellando di conseguenza ogni possibile ambiguità. Ma l’ambiguità è fondamentale perché una storia risuoni pienamente in chi la riceve. Proprio l’assenza di ambiguità e una certa edulcorazione credo siano il problema alla base della riscrittura del personaggio di Ellie in questa seconda stagione.
Sempre a proposito della prima stagione, scrivevo: “A questa ferma e rispettosa distanza partecipa anche la riscrittura, minima, dei protagonisti Joel e Ellie: sono gli stessi di Part I, ma sono anche diversi, grazie soprattutto al lavoro degli attori che li interpretano. Il Joel di Pedro Pascal sembra più vulnerabile e ammaccato rispetto a quello del gioco […], mentre la Ellie di Bella Ramsey è un po’ come… il Chisciotte riscritto parola per parola da Pierre Menard secondo Borges: è lei, ma non è lei. Però è lei, più di lei, anche se non può essere lei. Come spiegarlo diversamente?”
Ecco, tuttora non saprei spiegare cosa rendeva interessante la riscrittura di Ellie nella prima stagione di The Last of Us (possibile risposta: sì, alla fine è stato per lo più merito di Bella Ramsey). Ma intuisco come possono essere andate le cose in questa seconda stagione. Riscrivere un personaggio per dargli una nuova vita e una seconda chance è una cosa che ogni autore vorrebbe fare, sempre che per qualche strana ragione non abbia in antipatia i personaggi che ha creato. È il caso di Bill e Frank, che nella prima stagione hanno potuto vivere una storia d’amore che nel gioco era solo accennata, quasi nascosta, riscattandosi. Ho l’impressione che, al di là di come evolveranno le cose in futuro, con Ellie sia andata allo stesso modo: un eccesso di compassione prematura nei suoi riguardi, che si è ritenuto fosse fondamentale per non scuotere troppo il pubblico, l’ha salvaguardata, per il momento, dal rappresentarla per quello che è nel videogame già nel corso degli avvenimenti mostrati anche nella stagione appena conclusa. E cioè il villain.
Nel gioco c’è almeno un momento in cui Ellie interpreta questo ruolo in maniera esplicita – lo scontro con Abby in teatro, rivissuto però attraverso Abby –, momento che contribuisce a quell’inversione dei punti di vista (e dei cliché videoludici, oltre che narrativi) con cui Neil Druckmann e Naughty Dog hanno destabilizzato i videogiocatori fino a traumatizzarli. Più volte mi sono chiesto se la brutalità delle situazioni in cui viene calato il videogiocatore in Part 2 non fosse gratuita, se non si trattasse insomma di puro sadismo da parte autori e sviluppatori. Ma ogni volta sono arrivato alla conclusione che no, il punto è che semplicemente non mi era mai capitato di maneggiare del materiale narrativo di tale intensità, rafforzata peraltro dall’interazione col mondo di gioco, con i suoi protagonisti. Vivere Ellie come personaggio completamente rotto, malato, ossessionato, seguire la sua follia vendicativa fino al punto di non ritorno era funzionale al senso del racconto. Arrivare a odiarla, a pregarla di fermarsi, e poi passare a fronteggiarla dal punto di vista della sua nemesi, e solo alla fine compatirla e provare il suo stesso dolore come una liberazione… è stato un esercizio di umanità che non mi sarei mai aspettato di poter sperimentare in un videogioco. Tutto questo nell’adattamento televisivo non c’è: almeno fin qui, Ellie è un personaggio cui viene sempre offerto un appiglio, una possibilità di assoluzione, se non di redenzione. Ellie resta tra i buoni, ma in The Last of Us non ci sono buoni. È questo il punto antihollywoodiano della serie videoludica.
Ora, può essere gli autori abbiano optato per una sorta di gradualità, per cui arriverà il momento in cui Ellie si rivelerà il mostro che abbiamo visto in azione nel videogioco; può darsi che le cose stiano in questo modo e che alla fine la serie farà persino più male della storia originale. D’altronde ho amato così tanto la prima stagione da non poter certo rischiare di essere inserito in quella schiera di rancorosi che non vedevano l’ora che la serie fallisse per poter riaffermare la superiorità di The Last of Us in quanto videogame – probabilmente gli stessi gatekeeper che reagirono con rabbia e indignazione di fronte alla morte di Joel e all’introduzione di Abby quando uscì Part 2, in quell’afoso e indimenticabile giugno pandemico del 2020.
Insomma, non mi interessa stare qui a sostenere che il materiale di partenza è sacro e intoccabile (è come dire “era meglio il libro”: dio ce ne scampi, come se tutti i libri fossero Il Libro). È il classico atteggiamento fondamentalista verso cui proprio The Last of Us dovrebbe rappresentare un antidoto. Ma non questo The Last of Us depotenziato. Proprio perché non sono un fondamentalista e sono sempre disposto a cambiare idea, guarderò le prossime stagioni della serie, ma le guarderò in un unico blocco una volta che saranno uscite: allora sarà forse più chiaro dove Craig Mazin e Nel Druckmann intendevano portare la versione televisiva di Part 2. C’è ancora tempo per fare completamente a pezzi Ellie (e con lei il pubblico), c’è ancora tempo per ricostruirla in maniera più credibile. In ogni caso, con l’aiuto di Abby.
_
I miei pezzi su The Last of Us usciti su minima&moralia
- Essere lì, essere gli altri: dentro The Last of Us
- The Last of Us Part 2: odiare non serve a niente
- Il cervo di The Last of Us
Marco Montanaro (1982) vive in Puglia, dove si occupa di scritture e comunicazione. La sua newsletter si chiama Sobrietà.