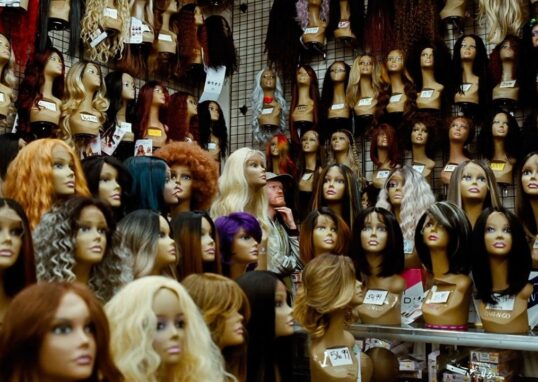di Marco Arienti
After the hunt: dopo la caccia, al fondo della pulsione di dominio totalizzante che la muove, che cosa rimane? Film dopo film Guadagnino prosegue la sua indagine per arrivare alle radici ultime del desiderio, oltre la superficie di corpi, oggetti, immagini. E come ogni indagine che si rispetti, anche questa non può che essere condotta con gli strumenti propri del thriller, genere che il regista frequenta anche quando meno sembrerebbe, nella cura dei dettagli (lì dove si dice si nasconda il diavolo) e delle atmosfere, per cercare di scoprire che cosa passa per la testa di un amato dall’aria indecifrabile (Queer) o dove va per tutto il tempo che passa lontano dalla casa condivisa con lui (Chiamami col tuo nome), oppure chi vincerà una partita di tennis che sa di resa dei conti affettiva (Challengers). Nel nuovo film, due bicchieri semivuoti abbandonati su un tavolo sono evidenza che il fatto – l’incontro notturno denunciato dalla dottoranda Maggie – ha veramente avuto luogo; quello che resta da stabilire è il valore di questo fatto rispetto a un ideale auspicato di relazioni libere e paritarie, non umilianti né contaminate da dinamiche di potere e privilegio.
Ma in un mondo come quello accademico, che si pretende astratto dalle tensioni del reale e obbliga i suoi membri a subordinare l’irriducibilità del proprio vissuto al mantenimento di standard e apparenze, è molto difficile ricomporre i diversi punti di vista, coniugare ricostruzione dei meri fatti e messa in luce dei loro significati profondi. Lo è ancora di più per la professoressa di etica Alma Imhoff, che per i suoi studi dovrebbe avere una certa familiarità con le questioni valoriali; non fosse però che il suo giudizio e le sue azioni sono ostaggio, da una parte, della caparbietà con cui lotta per mandare avanti la propria carriera e, dall’altra, di un pesante represso che sotto forma di dolore cronico preme insistentemente per tornare a galla.
Con questi presupposti, cade subito l’illusione tribunalizia di poter accertare se “il limite sia stato oltrepassato” e se ci sia stata o meno molestia da parte dell’affascinante maschio bianco etero cis Hank. Così, quello che resta in scena è una rete intricata di conflitti, tesa tra spazi presunti sicuri, poiché eleganti e impeccabili (appartamenti borghesi, studi di docenti e consulenti) o neutri e di servizio (atri, bagni, parcheggi), ma che finiscono presto per mostrarsi sotto una luce più torbida (il pied à terre di Alma sul molo); un teatro di piccole gestualità rivelatrici, ingigantite dalla regia che vi si sofferma nelle inquadrature in dettaglio, caricandole di una drammatizzazione e una tensione da cinema classico.
Proprio al noir degli anni Cinquanta si richiama su FilmTv Roberto Silvestri (sempre acutissimo nell’individuare le categorie giuste per capire Guadagnino), quando suggerisce di vedere Alma e Maggie come dark ladies, capaci di usare il loro essere donne come arma per raggiungere i propri obiettivi; altro che vittime succubi delle altrui volontà predatorie. E in effetti, nella fitta cortina di ambiguità in cui procede la vicenda, le due si sbarazzano quasi subito del maschio, per continuare a giocare tra di loro l’unica partita che veramente conta, quella per conquistare o riconquistare il loro sé autentico. È la loro relazione l’asse portante del film, il loro desiderio a esserne il centro – non certo quello narcisista del compiaciuto ma in fin dei conti ingenuo Hank. Rispetto al loro confronto, la roboante musica di fondo del patriarcato (quella che il marito di Alma ascolta in casa a tutto volume) è un rumore di disturbo dalle cui esplosioni occasionali non bisogna farsi distrarre. Dopotutto, per Maggie, alla ricerca di un modello su cui costruire la propria persona, denunciare un’aggressione sessuale non rappresenta anche un modo per avvicinarsi un po’ di più alla mentore adorata (che imita persino nel modo di vestire), per condividere qualcosa del misterioso passato di lei? E la ritrosia di Alma a questa condivisione non è forse la riluttanza di chi, per senso di colpa, si rifiuta di tornare sulle zone grigie del desiderio, le più problematiche moralmente?
Nessuna assoluzione o condanna è mai definitiva in After the hunt, che in questo è specchio fedelissimo della società dello spettacolo post-MeToo: si tratta, appunto, solo di gesti, performance provvisorie, mosse di un continuo gioco al massacro a cui nessuno può pretendersi estraneo. In questa guerra governata dallo schema oggettivante cacciatore-preda, dove il desiderio è degradato, la liberazione deve arrivare anch’essa da un gesto, che sia però (qui come già lo era in Challengers) di resa, di consegna e abbandono all’Altro: una via d’uscita da cercare nel dialogo, nel raccontare la propria storia, per quanto parziale o “sbagliata” possa essere, nel filtrarla attraverso l’espressione artistica.
È l’idea alla base del passo di Hannah Arendt sul “paradosso di Ulisse”, discusso a lezione da Alma con i suoi studenti, in cui si ragiona su come nell’Odissea l’eroe arrivi ad assumere pienamente e palesare ai Feaci la propria identità solo riconoscendola nella narrazione delle proprie gesta, da parte dell’aedo cieco Demodoco. Ma soprattutto è anche la prospettiva che dà forma al finale del film: dopo aver chiuso sul denaro, sull’argent bressoniano (forse è questo a tenere i fili dietro alla caccia, “se volti il foglio”, come scriveva Edoardo Sanguineti), Guadagnino ci porta fuori dal campo di battaglia entrandoci lui stesso da regista, con la propria voce, per dire a tutti che possiamo smettere di recitare e di combattere contro noi stessi.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente