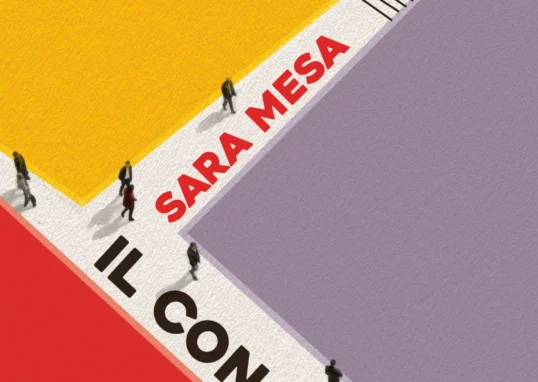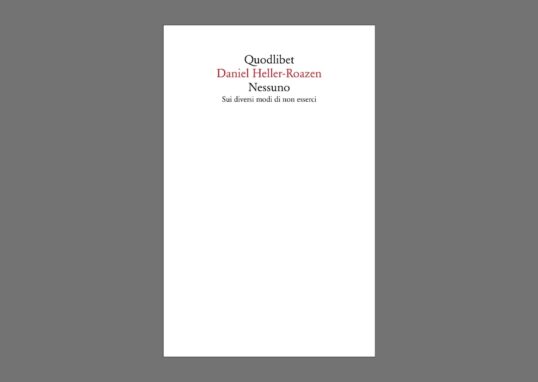“Perché temi il tuo ultimo giorno? Esso non contribuisce alla tua morte più di ciascuno degli altri”. Questo scriveva Michel de Montaigne, di professione scettico, quando insisteva sull’osservazione ordinaria, ma sempre troppo trascurata, secondo la quale cominciamo a morire dal momento esatto in cui veniamo al mondo. Detto altrimenti, ogni minuto che passa è un minuto in meno al momento della nostra dipartita. Considerazione più che consolatoria, ad avviso del filosofo francese, perché capace di renderci meno gravoso l’ultimo di questi minuti, cui perlopiù gli esseri umani tendono invece a riservare solenni rituali e sovrabbondanza di dolore collettivo. In effetti, per una sorta di lapsus emotivo, tutta l’esistenza umana sembra ruotare attorno a quegli ultimi momenti, quasi in essi potesse ricapitolarsi un’intera vita e persino sintetizzarsi una storia collettiva, come si racconta nel recente libro di Georgi Gospodinov, Il giardiniere e la morte, pubblicato da Voland.
Poeta e scrittore, Gospodinov è uno degli autori bulgari contemporanei più apprezzati, la cui cifra stilistica è una carica allegorica dove lo spunto filosofico incontra l’ironia, finanche la più nera. Il fortunatissimo Cronorifugio, pubblicato sempre da Voland nel 2021 e vincitore dell’International Booker prize, ruotava attorno al geriatra Gaustìn, ideatore di cliniche per pazienti affetti da malattie neurodegenerative. In queste, ogni piano appronta la ricostruzione minuziosa di un decennio del passato – dagli anni Sessanta agli anni Ottanta – completo di arredi autentici, abiti, musica e giornali dell’epoca, così da offrire ai pazienti appunto “un rifugio nel tempo”, in cui la loro memoria possa ancora ritrovarsi e riconoscersi. Il narratore, alter ego gospodinoviano, dapprima è osservatore curioso, per poi farsi compagno di progetto in questa sorta di utopia terapeutica. Via via però il confine tra nosocomio e società si dissolve, cosicché l’esperimento utopico non resta circoscritto ai singoli pazienti, ma si allarga fino a farsi allegoria politica. Interi popoli, disorientati dall’incertezza del presente e avvinti dal timore del futuro, rivendicano il diritto di rintanarsi in un passato idealizzato.
Insomma, Cronorifugio combinava la memoria individuale con quella collettiva, un’identità colma di nostalgia con un nostalgismo spiccatamente identitario, in un quadro in cui la malattia individuale si presenta come l’altro volto del male sociale, mentre il tempo che passa segna una dirittura indesiderata, che non offre vie di fuga, se non idealizzate e dunque vane. Il giardiniere e la morte utilizza gli stessi materiali, ma li dispone secondo un ordine diverso. La chiave, che, come si dirà, getta un’ipoteca pesante sulla recente impresa letteraria di Gospodinov, è la biografia dell’autore – rinnovando così quel male, non penserei neurodegenerativo, che ormai da troppo affanna la letteratura contemporanea.
“Mio padre era un giardiniere. Ora è un giardino”: questo l’incipit un po’ scolastico, che pare messo lì perché ogni scritto intorno al libro da lì possa partire. E da lì il romanzo si snoda come racconto intimo, impressionistico, frammentario. Il registro stilistico è a metà tra l’apodissi e l’aforisma. L’autore utilizza infatti un tono che trasmette il senso dell’indubitabile e del vero – perché l’esperienza individuale è per sua natura ingiudicabile – con il contegno asciutto di pochi e veloci frasi ad effetto. Questa costruzione prosastica, piuttosto agile, che in alcuni momenti vira però sul lirico, permette a Gospodinov di comporre i capitoli come brevi vignette, poste in una sequenza né cronologica né di senso. Il romanzo, dunque, non è un romanzo. In esso non si cerchi né trama né ordito, perché si troverà piuttosto un mosaico composto di vicende, sensazioni, memorie e considerazioni.
Si comincia dall’atroce notizia sullo stato avanzato della malattia del padre, caratterizzata da un linguaggio troppo alieno a quello degli affetti per essere tollerato da chi lo ama: “Neoformazione maligna di incerta localizzazione”, “lesione aghiforme di 30 millimetri nel lobo superiore del polmone sinistro. La formazione mostra un’attività metabolica molto elevata fino a SUV 15.1”. A partire dalla diagnosi, si offrono cenni su un uomo esposto alle costitutive debolezze della natura umana davanti alla malattia terminale. Del padre cominciano ad affiorare le debolezze, scarnificato via via dal cancro, reso così meno uomo, benché mai meno padre. Ha sempre più bisogno che si badi a lui per le attività quotidiane e infine smette di occuparsi del suo giardino, che quasi ne costituiva la controparte vegetale. Tutto questo, tuttavia, con una dignità che lo rende ammirevole agli occhi del lettore, invitato a provare empatia per chi si dimostra all’altezza dell’evento ultimo, senza neppure troppa retorica – “Non ci sono state ultime parole. Voleva solo che gli aprissimo la finestra e ha fatto un cenno con la mano”.
Con fare sempre frammentario, pagina dopo pagina, compaiono i molti protagonisti dell’assemblaggio affettivo del narratore: la madre, la figlia, il fratello, lo zio, gli amici, i conoscenti. La tecnica con cui Gospodinov affresca questo suo assemblaggio è reminiscente dell’espressionismo astratto di Jackson Pollock e della sua tecnica del dripping, per cui il colore gocciola sulla tela stesa a terra, con gesto che si è affrancato dall’obbligo della posizione frontale. Come Pollock, Gospodinov lascia colare i suoi colori, li fa man mano calare attraverso bastoncini e spatole, così da dar vita a strutture tra loro indipendenti, ma che pure formano un tutto impresso sulla superficie della pagina. In questa sfavillante combinazione d’immagini, che sempre oscilla tra linguaggio comune e fraseologia poetica, il libro si addentra progressivamente nella morte del padre, che somiglia a tutte le altre morti, eppure da ogni altra si distingue per i piccoli particolari di cui Gospodinov dà conto con il gusto dell’etnografo amatoriale.
Non si creda però che ogni frammento di questo amalgama musivo rappresenti un tassello del ritratto di un padre morente, perché si sbaglierebbe. Di contro, più si procede nella lettura, più ci si accorge che il libro non sa parlare che del figlio. Il punto focale non è dato dai momenti finali di chi trapassa, né dai ripetuti flashback nel passato di questi, bensì dalle sensazioni, dalle esperienze e dalle considerazioni del narratore. Il libro, in altre parole, non esce mai dalla trappola dell’io. All’opposto, vi si rintana con studiata compiacenza, come se al giorno d’oggi non si potesse che guardare il mondo da quell’angusto spioncino.
Adottiamo a mo’ di chiave interpretativa un’asserzione del capitolo 28: “Raccontare una morte non è più facile che viverla”. In questa dichiarazione, quasi tesa a scolpire un assunto metodologico, l’io che parla e vive sembra rivendicare per sé stesso un dolore pari a quello dell’io che tace e muore – dolore costellato di tutte le sofferenze tipiche della malattia terminale. A partire da questa asserzione, Gospodinov prende a meditare sulle proprie modalità narrative, fino a chiedersi in forma un poco ombelicale perché faccia quel che sta facendo a riguardo della morte del padre e che ruolo questi ha da sempre nella sua opera. Di lì, torna sempre più spesso su quanto i suoi genitori siano presenti nei suoi romanzi, su quanto la propria voce sia la loro voce, su quanto i suoi amici e lettori trovino il padre in ogni sua pagina (da giardino a cellulosa il passo è in fondo piuttosto breve). Racconta nel capitolo 31 di come ha già descritto la morte del padre in Cronorifugio. Di quest’ultimo commenta persinola dedica, sempre ai genitori, che ovviamente al tempo erano vivi e poi se li ritrova morti e quindi oggi andrebbe un poco emendata (per la precisione nell’avverbio di tempo “ancora”, che implica l’esistenza in vita: “A mia madre e a mio padre, che ancora puliscono dalle erbacce gli eterni campi di fragole dell’infanzia”. Un poco ovvio, lo si ammetterà, se non tecnicamente lapalissiano).
A fianco di questi ampi carotaggi nell’io – benché un io mascherato da altre figure – risaltano alcune propensioni per le frasi a effetto, che non sempre risultano felici. Ad esempio, “il telefono dopo la morte è fonte di terrore metafisico” – e vien da chiedersi cosa sia “metafisico” rispetto al terrore e cosa detto aggettivo possa aggiungere all’esperienza del terrore se non che questo ha a che fare con la morte, quindi con qualcosa che si teme o si spera vada oltre la vita materiale? Oppure: “Finché c’è lavoro da fare nel giardino, rimani in una zona protetta. Godi di una qualche immortalità stagionale” – e vien da chiedersi cosa sia una “immortalità stagionale” e perché si sia impermeabili alla morte quando in primavera si rastrella per eliminare muschio e feltro. Per giungere infine alla chiusura del libro, impiantata sull’anafora stilosa del “non so cosa fare”, seguita poi dalle molte cose su cui l’autore non sa raccapezzarsi dopo la morte del padre, in un catalogo di cose, però, che potrebbe essere più asciutta oppure, all’opposto, continuare all’infinito, senza lasciar intuire un criterio sul perché quelle cose e non altre (quantomeno, proprio in un passaggio di quel catalogo trapela, benché furtivamente, la confessione che Il giardiniere e la morte in fin dei conti parla soprattutto del narratore).
A rafforzare il carattere impressionistico del libro, che appunto non segue il filo di un racconto ma associa ricordi liberi a sovrane considerazioni, gravano alcuni capitoli di cui si stenta a capire il senso – se non quello puramente soggettivo dello scrittore che quel passaggio avrà ritenuto necessario, quando non indispensabile. Come singolo esempio valga il capitolo 52, dall’eloquente titolo “Storie divertenti per ogni evenienza”, in cui si dà breve conto di alcuni fatterelli raccontati dal padre, che certo acquistano importanza per il solo fatto di esser stati riportati da lui, ma che intensificano nel lettore il retrogusto del rapsodico, trasfuso lungo tutta l’opera. Lo stesso può dirsi per i molti rimandi al sapere colto, talora indovinati ma sempre accidentali, con riferimenti a Auden, Fellini, Munch, Sontag e così via.
In questa intelaiatura discontinua, Gospodinov introduce elementi della storia politica e sociale della Bulgaria, tentando, come appunto in altri suoi libri, di riannodare i fili delle biografie individuali con le sorti di un’intera collettività, per spingersi sino alle atmosfere rarefatte della psicologia sociale: “Il padre, sembra, è la figura mancante nel cristianesimo e nel socialismo”. E se per il cristianesimo potrà dirsi che il Padre, presentato sempre come architrave, è comunque residuale rispetto all’indubbio protagonismo del Figlio, il rischio è che il padre de Il giardiniere e la morte sia esposto alla stessa sorte per la stessa vistosa centralità di chi narra. Un “chi” che per meglio mascherarsi ardisce farsi velo della dissimulazione, dando a intendere, già dall’esergo, che il racconto è comunque un impasto di verità e finzione: “Ogni storia, perfino se è avvenuta ed è personale, una volta passata attraverso la lingua, quando si è rivestita di parole, non ci appartiene più, fa già parte sia dell’ordine della realtà che di quello della finzione”.
La domanda, allora, è se la letteratura del presente non possa fare a meno di questa doppia pesantissima ipoteca, ossia quella del biografismo (qui persino gravato dall’aneddotica) e del sempre meno digeribile miscuglio di realtà e finzione – vale a dire, una finzione che deve macularsi di realtà per destare interesse nel lettore e una realtà che dal canto suo si deve scoprire sempre feticcio, ossia un po’ vera un po’ immaginaria, per potersi narrare e, per speculare paradosso, risultare credibile. Se questo è il residuo del postmodernismo in letteratura, credo sia l’ora di riscoprirsi modernisti, anzi, modernisti e conservatori, se non reazionari: tornare a convocare la vecchia categoria del romanzo, quello che sa farsi parte vitale di una storia collettiva semplicemente congegnando una sua storia, senza inscenare il dolore del mondo in forme toccanti perché vere e senza richiamare l’esperienza dolente (ma in questo caso di successo) del più lurido di tutti i pronomi, il pidocchio del pensiero, come scriveva Gadda, cioè di quell’io che si bea della propria confinata individualità.
Beninteso, la lettura de Il giardiniere e la morte non è tempo gettato interamente via. Gospodinov s’impegna per trasporre in chiave lirica il fatto inesorabile della morte, un fatto che interessa tutti, già dal primo istante della nascita di ciascuno: già solo questo è un tentativo che merita il nostro plauso. Ma lo fa con strumenti che forse è il tempo di ripensare. Ed è probabile che troppa parte della letteratura contemporanea, nella voce di troppi dei suoi protagonismi, proprio come il narratore de Il giardiniere e la morte subito dopo l’incipit di cui sopra, rispetto a questo ingentissimo problema non sappia che asserire: “Non so da dove cominciare”.
Mariano Croce insegna Filosofia politica presso Sapienza Università di Roma. Si occupa di critica sociale, postcritica, battaglie LGBTIAQ+ e politiche della trasformazione sociale.