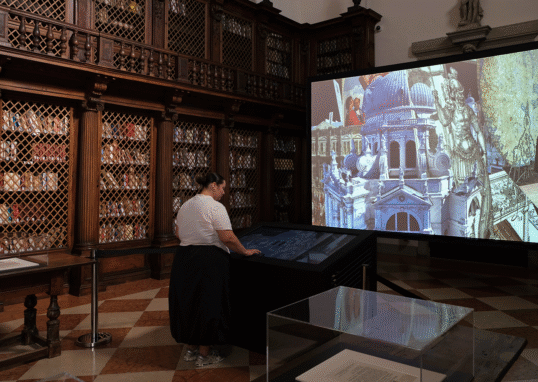Pubblichiamo un pezzo uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
Quindici anni fa, poiché stavo attraversando il Messico, chiesi a Attilio Giordano, direttore del venerdì, se poteva interessargli un reportage da Cuernavaca, sulle tracce di Sotto il vulcano, un libro di cui mi ero ammalato fin da adolescente, una “Divina Commedia ubriaca” secondo la definizione dello stesso autore, Malcolm Lowry, un’epopea capace di infettare l’animo del lettore e portarlo altrove.
Questo altrove doveva in qualche modo essere rintracciabile per le vie polverose della cittadina che nel romanzo ha il nome dell’antico insediamento azteco di Quauhnahuac, così Attila, a sua volta malato del capolavoro di Lowry, non esitò. Certo, le vicende che avevano ispirato il libro risalivano a quasi settant’anni prima e molto doveva essere andato perduto, ma spulciando fra i resoconti di altri appassionati, mi pareva che si potesse avere fiducia. Così saltai su una corriera e in poco meno di due ore coprimmo i novanta chilometri che dividono il centro dell’immensa Città del Messico dallo zócalo (la piazza principale) di Cuernavaca.
Sognai tutto il tempo l’arrivo di Yvonne con cui si apre il secondo capitolo di Sotto il vulcano, il vero inizio della storia. La cantina ombrosa e umida, mentre fuori il sole è accecante; il Console Geoffrey Firmin, protagonista del libro e alter ego di Lowry, chino sul banco, ubriaco; e la sua Yvonne che dopo un anno ricompare scendendo da una corriera. Sapevo tutto di come erano andate le cose per lo scrittore. Dietro Yvonne si nascondeva Jan Gabrial, la prima moglie che con lui aveva vissuto a Cuernavaca nel 1936, un intero anno per poi lasciarlo lì a schiantarsi di rimpianto nell’ubriachezza costante. Quel dolore era il centro della storia che Lowry iniziò a scrivere proprio nel 1937 con l’idea di farne un racconto breve che invece, dopo dieci anni e infinite riscritture, divenne uno dei caposaldi letterari del Novecento.
A Cuernavaca però mi parve che ritrovare Lowry fosse molto più difficile di quanto avessi immaginato. C’era sì l’aria sonnacchiosa e scalcinata delle strade che mi avevano imprigionato dalle pagine del libro e tuttavia i principali luoghi erano scomparsi. Il Casino de la Selva in cui si apre il romanzo era stato sostituito da un centro commerciale e il Farolito dove il romanzo si chiude non esisteva affatto: capii che doveva essere stato creato dalla fantasia dell’autore, mescolando – come spesso si fa per dare realtà romanzesca a un mondo – varie cantine e bar messicani. Per due giorni mi sentii perduto. Non si torna mai indietro, mi ripetevo. Fu questa sensazione malinconica che mi spinse a indagare ciò che era capitato a Lowry quando rientrò in Messico nel dicembre del 1945.
Cosa aveva ritrovato? Non c’era più Jan al suo fianco, ma Margerie Bonner, la seconda moglie che lo aveva aiutato a chiudere il romanzo e gli aveva offerto un’isola di sicurezza durante gli anni trascorsi in Canada. Per un uomo tormentato dai deliri filosofici sempre intrecciati ai deliri alcolici, per uno che non aveva mai imparato a farsi la barba e allacciarsi le scarpe, capace invece di bere una lozione di dopobarba pur di assumere alcol quando ogni bottiglia gli era stata nascosta, per uno così Margerie fu davvero una salvezza. Portarla a Cuernavaca però non doveva essere stato semplice.
Pensavo al terrore che aveva perseguitato Lowry aggirandosi per i giardini Borda dove sperava e temeva di ritrovare la corteccia su cui aveva inciso Jan and Malcolm. Margerie non doveva vederla, quella promessa di amore, eppure lui, non trovandola più, si sentiva sfinito. Non si torna mai a casa, mi ripetevo. Poi improvvisamente capii. Bighellonando per la cittadina e dimenticandomi dei vulcani che cercavo nel cielo velato dalla calura all’orizzonte, mentre seguivo l’odore di pollo arrosto che doveva provenire da una specie di magazzino in legno rossastro, superai il canyon che attraversa la città, guardai giù nel fondo di terra e arbusti che crescevano fra i rifiuti e ogni cosa senza preavviso s’illuminò.
Eccola, la barranca, la spaccatura, la lacerazione della terra che ritorna costantemente nel libro come l’abisso, il ricettacolo della materia informe, una specie di Tartaro. Eccolo, il principale simbolo di Sotto il vulcano. Come ogni vero simbolo, la barranca non sarebbe mai scomparsa da Cuernavaca, nessuno avrebbe mai potuto arginare la divaricazione, nessuna cicatrice avrebbe mai saldato i lembi scomposti dalla faglia. E il dolore d’amore che sentiamo pulsare in quel romanzo maestoso avrebbe sempre continuato a seguire gli argini di quella spaccatura. Iniziai così a immaginare quale tipo di lacerazione dovesse aver vissuto Lowry nel suo ritorno a Cuernavaca e scoprii quel che gli era accaduto: due fatti notevoli e complicati che lo spinsero a scrivere di nuovo e che generarono due romanzi incompiuti, uno dei quali esce finalmente anche in Italia dando sostanza al progetto di Feltrinelli di pubblicare tutta l’opera di Lowry.
La mordida (traduzione di M. Rossari, pp. 405, euro 29) è un testo che farà felici gli appassionati e che spingerà i nuovi lettori a spostare un poco più in alto l’asticella della loro conoscenza di questo scrittore sublime. I fatti che lo ispirano girano attorno alla situazione kafkiana in cui si ritrovarono Malcolm e Margerie per via di questioni legate a visti, multe che si suppone non fossero state pagate dieci anni prima, deliri burocratici dell’ufficio immigrazione e un incubo da cui sembra impossibile uscire e in cui, pure, nessuno sarebbe entrato se subito fosse stata sborsata una piccola mordida, la classica bustarella che mette a tacere tutti gli scricchiolii più devastanti di ogni calvario burocratico. Hanno forme molto diverse e diverso grado di intensità le pagine in cui Lowry riplasma letterariamente quel che gli capitò (e che nel volume è riportato fedelmente in una lunga nota introduttiva, vergata dall’autore per fini legali, rievocando minuziosamente i passaggi della vicenda: una dichiarazione in cui ci si sente soffocare, si boccheggia e si ha l’impressione che il Kafka del Processo sia dietro l’angolo). Nella scrittura variegata che compone la storia troviamo progetti dettagliati di scene da costruire, dialoghi già scritti, descrizioni minuziose e vertiginose in cui ogni amante del Vulcano sentirà echeggiare lo spirito quasi diabolico di uno scrittore perduto nella famosa “selva di simboli” baudelairiana e in cerca del suono, del significante che da ogni parola apre un mondo altrimenti indicibile e in realtà ineffabile.
Come ogni opera incompiuta, anche La mordida può lasciare il lettore interdetto. Ma a leggere la bella introduzione di Tommaso Pincio, lo sforzo da fare è un altro. A chi gli domandava perché fosse tornato in Messico, Lowry, infatti, rispondeva sempre, fedele alla sua autoironia tipicamente britannica, “per scrivere un libro intitolato Sotto sotto il vulcano”. Molte strade si aprono cercando il senso di quella reduplicazione del “sotto”. Più in basso; più a fondo; all’ombra; meno riuscito; più ubriaco ancora… Ognuno deve seguire la sua via interpretativa. Certo il successo del Vulcano pesò su quel che Lowry tentò di scrivere dopo. E certo lo sforzo titanico di fare i conti con le ombre più imprendibili della sua psiche (uno sforzo che lo aveva perseguitato per dieci anni spesso portandolo a sognare che tutto potesse andare perduto) dopo il successo del libro divenne una dannazione rispetto a qualsiasi cosa avrebbe potuto scrivere in seguito.
“La mordida è un proseguimento di Sotto il vulcano in forma di spettro, un Sotto sotto il vulcano” scrive Pincio, convinto che l’incompiutezza è la dimensione naturale di questo libro perché “inseparabile dalla persona dello scrittore” e “manifestazione del suo stare al mondo”, dunque “In perpetuo svolgimento, almeno fintanto che lo scrittore resta in vita”. Niente di più vero. La mordida appare incompiuto solo ai nostri occhi. Ma anche per noi può diventare ciò che è quando guardiamo giù nel fondo della barranca che taglia in due Cuernavaca. Un abisso, un Tartaro, un inferno. La ferita necessaria creata da Eros proprio come aveva detto quasi tremila anni prima Esiodo, spiegando che ogni cosa, in questa vita, prende forma a partire dal Chaos, e cioè non il disordine come siamo abituati a interpretare noi oggi il la parola “caos”, bensì la spaccatura, la divaricazione nella Terra, un abisso che spinge verso le profondità del Tartaro, un vuoto in cui si getta Eros, la passione più potente, capace di dare vita e morte assieme. Un’idea che i lettori del Vulcano conoscono bene e che, fuori dalla barranca, ritroviamo incisa sul muro della casa in cui viveva il francese con cui Yvonne aveva tradito il Console, una frase talmente semplice eppure inafferrabile che finisce per perseguitare il Console come tutti noi. No se puede vivir sin amar.
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it