
Pubblichiamo un pezzo apparso su Linus, che ringraziamo.
Pinocchio nasce inquieto, come un’immagine in movimento.
Sfugge alla penna di Collodi a fine ottocento, quasi in sincrono con l’avvento del cinema.
Coincidenza forse non casuale, per la favola della metamorfosi perenne. Pinocchio è, nello stesso tempo, bambino, burattino, e asino: la natura umana, la struttura meccanica, e la condizione bestiale si avvicendando di continuo.
Sospesa tra neorealismo e surrealtà, la storia dell’ultima grande maschera italiana si presenta subito visionaria. Così ambigua, eppure così evidente, nella sua plasticità; piena di archetipi riconoscibili, per quanto misteriosi.
Tra i campi miseri del Granducato di Toscana, il cristianesimo rurale si mescola al paganesimo, la menzogna risuscita la verità, il legno si fa carne, i vivi si confondono con i morti. Gli esseri umani sembrano l’evoluzione di chissà quali bestie, e gli animali antropomorfi presentano tare umane, troppo umane. Eppure tutto è in equilibrio, e continua oscuramente a riguardarci.
Inorganico, eppure sempre vivo, il burattino è l’infanzia eterna, ed universale. Pur rimanendo profondamente italiano, intarsiato com’è di sentimentalismo, falsa coscienza e devozione ad una provvidenza più o meno fatata. Pezzo di legno artigianale, diventa automa per magia, connettendo commedia dell’arte e intelligenza artificiale, diventando bacino inesauribile per il cinema d’animazione di tutto il mondo. Eppure, nei film con attori in carne ed ossa, ha forse trovato la sua rappresentazione più sottile. Soprattutto in Italia, fin dai tempi del muto: l’esordio sul grande schermo risale al 1911. A vestirsi di carta da zucchero e mollica di pane, è Ferdinand Guillaume, in arte Polidor, francese naturalizzato italiano, corredato di una biografia quasi collodiana. Con epilogo fatalmente felliniano: si ritroverà a fare il clown, con tromba e palloncini, in una sequenza de La dolce vita.
Nato da circensi di nobili origini, con avi scappati dalla Francia della rivoluzione e delle ghigliottine, cresce in un tendone itinerante, diventando acrobata, giocoliere, cavallerizzo e clown. Il suo eclettismo attira il cinema: diventa il grande Tontolini. Dopo cento comiche a rotta di collo, girate nello spazio di un anno, è pronto a trasformarsi in Pinocchio. Si addobba filologicamente, come da illustrazione di Attilio Mussino, per consegnarsi alle inquadrature del regista Giulio Antamoro, composte e dinamiche come illustrazioni ottocentesche. Il plot omaggia l’esotismo del tempo, contaminando Collodi con i “Viaggi straordinarissimi di Saturnino Farandola”, dello scrittore francese Albert Robida.
Evaso dal carcere della città di Acchiappa-Citrulli, il burattino sfugge ad una tribù di nativi americani, e finisce tra la fauci di una balena, che ha già deglutito Geppetto. I guerrieri dai cappelli piumati ammazzano il cetaceo, e poi catturano il burattino e il falegname. Pinocchio, forse per la sua natura lignea, viene adorato come un totem dall’intera tribù. Approfitta del suo status per scappare col padre. Inseguito dai suoi nuovi fedeli, si imbatte in una truppa dell’esercito canadese, che stermina la tribù e rispedisce Pinocchio nel mondo collodiano d’origine. Il burattino sorvola il mare a bordo di una palla di cannone, come il Barone di Münchhausen, ritrovandosi prima nel teatro dei Burattini di Mangiafuoco, poi alle prese con Lucignolo e il Paese dei balocchi.
La fine è nota: la Fata Turchina trasforma Pinocchio in un bambino vero. Dopo un po’ di soffitta, il burattino ritorna sugli schermi italiani nel 1947, in un’Italia che sembra un borgo collodiano, ancora martoriato dai segni della guerra. La sceneggiatura, curiosamente, è opera di Giancarlo Fusco, il più lucignolesco degli scrittori italiani, affabulatore e inventore di mondi più o meno immaginari. Sedicente habituè di uno dei paesi dei balocchi più torbidi dell’epoca: la toscana pineta di Tombolo, meta di soldati afroamericani della divisione Buffalo, segnorine, ladri, contrabbandieri e prigionieri tedeschi in fuga. Tutti a ballare il boogie-woogie fino all’alba. Il film, tuttavia, non è troppo perturbante. Si segnala l’apparizione di un aitante Vittorio Gassman quasi adamitico, barba e capelli da naufrago e tendenze cannibali. E’ il Pescatore Verde, deciso ad arrostire il povero Pinocchio. Il look del giovanissimo protagonista, Alessandro Tommei, è ispirato alle illustrazioni di Mazzanti e Chiostri.
Passa solo una manciata d’anni, ed ecco sbucare di nuovo all’orizzonte il naso puntuto di Pinocchio, in un cinema italiano alle prese con i primi esperimenti cromatici. E’ il 1952: anche Totò, diretto da Steno, diventa a colori. Cappello a cono, vestitino a pois, braghe corte, balla disarticolato come una marionetta, in una sequenza dai verdi e rossi allucinatori. Il corpo ossuto, asciugato dall’antica fame, si muove a scatti geometrici, sulle note di Parade of the Wooden Soldiers, suggerendo fili inesistenti. Totò porta sul grande schermo un cavallo di battaglia delle sue riviste, il talento esibito delle articolazioni snodabili, la singolarità del suo corpo ibrido, un po’uomo un po’ marionetta. Con irriverenza da pazzariello, il banditore di strada partenopeo, gioca da fenomeno da baraccone per sopravvivere, quasi come se fosse davvero Pinocchio, nel teatro di Mangiafuoco: nel film, la sua trasformazione in burattino è uno stratagemma per sfuggire alle coltellate assassine.
All’alba degli anni sessanta il naso di legno spunta sul volto da impunito di un ragazzaccio venuto dal Salento. Il suo nome è Carmelo Bene, ed è forse il primo ad avventurarsi nel lato oscuro di Collodi. Ha fondato il suo teatrino in una Trastevere ancora patibolare, molto collodiana. Attira sui suoi spettacoli la stima di gente come Arbasino, Flaiano e Pasolini, ma anche il dileggio della critica più tradizionale. Si registra anche qualche contatto ravvicinato con i gendarmi, con i pennacchi e con le armi, per aver pisciato addosso all’ambasciatore argentino, seduto in platea con la moglie. In uno spettacolo in cui recitava da Cristo crocifisso, per giunta. Pinocchio lo accompagnerà come un’ombra, fino al suo ultimo respiro scenico. E’ la sua infanzia permanente, il segno della fame, di cultura e gloria artistica, di un meridionale arrivato a Roma da ragazzo.
Deciso a specchiarsi solo in cattivi maestri, sempre incline a smarrire la strada, per sottrarsi all’inculturazione omologante. Dedito all’indisciplina rigorosa dello studium, sinonimo di amore passionale. Il mondo collodiano che ricrea è un’allegoria corale di incubi molto familiari, incarnati dai mascheroni dell’artista Salvatore Vendittelli. La Fatina è un tipo molto diffuso di madre italiana dell’epoca. Forse un po’ estremizzato: quasi violenta Pinocchio sul palcoscenico, soffocandolo di lagnanze e morbosità. Gatto e Volpe, con cilindro da banchiere e tunica cardinalizia, rappresentano pelosamente finanza e chiesa, nelle rispettive, malcelate crudeltà. Mangiafuoco è l’imbonitore della rappresentazione governativa. e del pensiero dominante. Bene anima il suo Pinocchio con spasmi e gesti legnosi, in falsetto toscaneggiante, in sfregio alla dizione di maniera. Quando Geppetto gli porge l’abbecedario, comprato dopo aver venduto la casacca, nonostante il gelo, il figlio di legno ne premia il sacrificio ricattatorio, sputandogli in faccia. A volte, la saliva piove anche in platea.
Nel finale, in un tripudio di bandiere italiane, cretino come una festa nazionale, Pinocchio perde il naso, senza salvare sé stesso. Smette di essere un burattino e diventa un italiano medio, conformista e furbetto, imbevuto di tabù e ideali edificanti a buon mercato. Perdendo per sempre la magia onnipotente della vita bambina. Il copione confluisce in una sceneggiatura cinematografica, scritta da Bene con l’amico Nelo Risi, nel 1966. Scontato il protagonista, si vagliano Brigitte Bardot, Virna Lisi o Claudia Cardinale nella parte della Fatina. La morte del Principe De Curtis, prescelto per il ruolo di Geppetto, stronca il film sul nascere. (Totò, da Pinocchio a padre falegname: lo stesso iter di Roberto Benigni, qualche tempo dopo). Persa la chance del cinema, Bene porta i suoi spettri collodiani in televisione, in un adattamento del suo spettacolo di fine anni novanta.
Tutto si fa più luttuoso, le maschere sono piene di crepe, come bambole irreparabili. C’è un umorismo tetro, alla Masoch: il burattino è incatenato ad un banco scolastico. Mentre la fatina gli riattizza la brace sotto i piedi, lui si delizia delle torture. Si lambisce il cuore nero della favola, quella storia di sevizie e amore, insinuata da Giorgio Manganelli: “Tutti, nel libro, possono cercare di uccidere Pinocchio, ma solo Geppetto e la Fata possono comunicargli l’orrore infantile della disperazione”. La Fatina, per Manganelli, è signora di un bosco magico e di un mondo animale, che odora di morte e seduzione. Una strana Circe, capace di attirare il burattino in un rapporto masochistico molto consenziente. Nel 1972 approda sugli schermi televisivi e cinematografici quella che forse è la visione più profonda e compiuta della favola. Il Pinocchio di Luigi Comencini, scritto dallo stesso regista e da Suso Cecchi d’Amico, va in onda in cinque puntate. Una versione riassuntiva, di 135 minuti, esce nei cinema, dopo la diffusione televisiva.
Comencini sguinzaglia il suo burattino bambino in un paese gelido, di terra e pietra scura, da quadro di Ottone Rosai. Gira in pellicola, creando un mondo di luci e colori invernali, immortalato dalla fotografia di Armando Nannuzzi. Un mondo reso vero e coerente dai cenci espressivi del costumista Piero Gherardi. Pieno di una malinconia accarezzata dai motivi popolari, senza un filo di pittoresco, di Fiorenzo Carpi, puntuale nell’animare anche i lampi di vivacità di Pinocchio.
Nel piccolo borgo senza tempo, la solidarietà latita e regna l’ipocrisia della morale, pronta ad abbattersi su chi ruba per non morire di inedia. Nino Manfredi è un Geppetto che trotterella svagato, con le mani sollevate, quasi a tenersi in equilibrio, sul ghiaccio della strada e tra lo scherno dei compaesani. Intontito dalla povertà, e da una solitudine più fredda del gelo, è un artigiano senza clienti. Per illudersi di scaldarsi e mangiare, dipinge una pentola sul fuoco, sulla parete di casa. E per essere padre, scolpisce un burattino, e lo ama come un bambino, anche sa ha da dargli solo la sua fame. Non riesce nemmeno a proteggerlo da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Gatto e Volpe mai superati. Pupi scalcinati, sfuggiti a qualche cunto siciliano, sono approdati per vie magiche in questa Toscana feroce, legata alla roba come la loro terra d’origine. Hanno maschere da gaglioffi e la sorte segnata, da ladri di galline. Cattivi in fondo quasi solo ipotetici, condannati da una Storia scritta da altri. Così come Mangiafuoco è un orco fallito, come riporta il solito Manganelli, con la commozione facile e il mascherone da pupazzo allegorico di Lionel Stander. Persino la fatina ha poco di metafisico, e molto di terragno. E’ una Gina Lollobrigida ancora odorosa di pane, amore e fantasia campestre. Vive in una strana casa galleggiante, ormeggiata su di un lago, vagamente funebre.
A Vittorio De Sica è affidata una sintesi di tutti gli irresistibili cialtroni in toga interpretati in carriera. Giudice del paese di Acchiappa-citrulli, con un gesto d’indolenza spedisce in galera Pinocchio, reo di essersi lasciato derubare.
E’ questo il mondo paradossale, di ingiustizia beffarda, in cui il burattino, interpretato dal novenne pisano Andrea Balestri dovrebbe diventare un bravo bambino. Biondo come un pulcino, è vittima di una meschinità diffusa, che lo colpisce quasi per inerzia. Riservatagli senza consapevolezza da adulti improbabili, eppure veri come la sua fame.
Lucignolo, che ha la faccia da scugnizzo pasoliniano di Bruno Santoro, viene rispettato da Comencini, nell’innocenza della sua vitalità. Senza diventare un cattivo esempio monodimensionale, da storiella edificante.
Pinocchio alla fine, nel ventre del pescecane, riserverà a lui, al Gatto e alla Volpe una lieve nostalgia. Sciagurati, certo, ma con loro si è divertito, ha fatto esperienza. E’ maturato come individuo, senza bisogno di dottrine né grilli parlanti. Al punto che, nel finale antiretorico di Comencini, prende per mano il vecchio padre, donandogli il coraggio di vivere che gli è sempre mancato.
Portandolo fuori, con un saltello, dalla bocca dentata del mostro marino. A proposito di mostruosità e di linee d’ombra da saltare, nel 2019 il burattino finisce nelle mani di Matteo Garrone. Narratore visionario di mondi ambigui, popolati di figure sinistre, in lotta per la vita. Il burattino, per il regista romano, è un’ossessione antica, trascinata dall’infanzia. Una manìa percepibile in molto suo cinema, nei corpi inquieti dei suoi protagonisti, in attesa di metamorfosi, sognate o reali.
Nei loro guaiti cantilenanti e nelle loro camminate storte, da animali antropomorfi, mostruosi e disperatamente umani. Ghiotti di desideri inappagabili, come il suo nano imbalsamatore. Un Geppetto mellifluo che sa farsi gatto volpe e Mangiafuoco, pur di sedurre, a colpi di zecchini, un Pinocchio troppo bello per lui.
O il pescivendolo di Reality, in mistica attesa della chiamata al Paese dei balocchi del Grande fratello. E persino i due ragazzini di Gomorra, lucignoli che giocano a fare i camorristi, in un mondo troppo feroce per la loro quasi innocente demenza.
Forse la sua figura più collodiana è il Dogman Marcello Fonte, un Pinocchio asinino nei tratti, come se il sortilegio dell’Omino di burro si fosse fermato a metà. Prigioniero di un Paese dei balocchi eretto sul litorale domizio all’apice del boom, e ridotto dall’incuria criminale ad un avanzato stato di decomposizione, abitato da superstiti dispensatori di paradisi da discount: il gestore della sala giochi, l’oste, e l’avido compratore d’oro. Lì il canaro calabro strappa alla miseria piccoli sogni, da regalare alla figlia, una Fatina bionda come una Madonna, unica presenza a squarciare di luce il grigiore del Villaggio Coppola.
Quel burattino fragile, soggiogato dal Lucignolo brutale che lo atterrisce e lo seduce, sembra indicare come questa favola abbia rappresentato, per Garrone, il romanzo di deformazione prediletto. Una farsa tragica e solare, interpretabile variabilmente come viaggio nel Regno dei morti, allegoria di un percorso cristologico, o trasformazione alchemica, per via delle presunte frequentazioni massoniche di Collodi. Particolarmente congeniale ad un regista già immerso nei cunti sanguinosi di Giambattista Basile, in storie scellerate alla Sergio Citti. Favole amorali riemerse da un’oralità antica per continuare a non insegnare nulla, se non a riempire di piacere la paura, esorcizzando una vita troppo amara.
Garrone ha guizzi visionari da realista magico, abile nel tratteggiare grottesche figure istituzionali come i giudici scimmieschi, i maestri incarogniti e i carabinieri ottusamente spietati. Roberto Benigni torna qui come Geppetto, dopo essere stato a sua volta Pinocchio. Più che nel suo adattamento collodiano del 2002, un po’ troppo irrigidito nella calligrafia da kolossal, Benigni era Pinocchio in tanta vita precedente, fuori e dentro i set. Quando, da sottoproletario frenetico, protagonista di “Berlinguer ti voglio bene”sembrava davvero un burattino punk. Era il 1977: squassato da tic e coprolalìa, turbava schermi cinematografici e televisivi. Un blasfemo sdrucito, col cuore in mano e le bestemmie in bocca, urlate come preghiere rovesciate in campi dei Miracoli che non moltiplicano mai i pochi zecchini in tasca. Nel frattempo Alida Valli, sua Fatina e madre degenere, si concedeva al truce Mangiafuoco Carlo Monni.
Se Federico Fellini lo scarabocchiava di continuo nei panni del burattino, Garrone promuove Benigni Geppetto bonario, avvolgendolo nella luce congelata di una Toscana miserabile, senza tempo. Massimo Ceccherini è una volpe contemporanea, segnata da vizi metropolitani : anche sceneggiatore della linea comica del film, viene affiancato dal gatto meridionale Rocco Papaleo. La topografia collodiana viene riscritta: i poggi toscani si confondono con la murgia pugliese, le coste garganiche e il Salento si affollano di voci e volti napoletani. E’ come se l’Italia rurale, metastorica di Collodi fosse accomunata dalla stessa ferocia, da un darwinismo sociale che incarognisce tutti, a ogni latitudine.
Quasi come in un film di Tod Browning, i ruoli dei burattini sono affidati a dei nani, dolcissimi e raggelanti. Affondati nelle maschere, come il grillo piagnucoloso.
La fatina Marine Vacth è una figurina di bellissima anemia, mentre Pinocchio interpretato dal piccolo Federico Ielapi, è intrappolato una maschera lignea che ne lascia solo intuire i cambi d’umore. Ma Pinocchio è destinato a liberarsi. Promette sempre nuove incarnazioni, e su questo non mente mai. In fondo, come nel bel finale di Benigni, il burattino è un’ombra che si stacca una volta di più dal suo destino di bambino, per tornare a correre dietro una farfalla.
Per giocare ancora a spaventarsi, in eterno, tra le seducenti insidie del mondo. Cercando un equilibrio impossibile, come suggeriva Cesare Garboli, tra “l’universo del piacere e il mondo degli adulti, tra l’attrattiva dell’infanzia e il principio della realtà”.
Giuseppe Sansonna (1977) è autore di cortometraggi e documentari, fra cui, oltre al fortunato Zemanlandia, Frammenti di Nairobi (su una bidonville kenyana), A perdifiato (su Michele Lacerenza, il trombettista dei western di Sergio Leone) e Lo sceicco di Castellaneta (sul mito di Rodolfo Valentino).



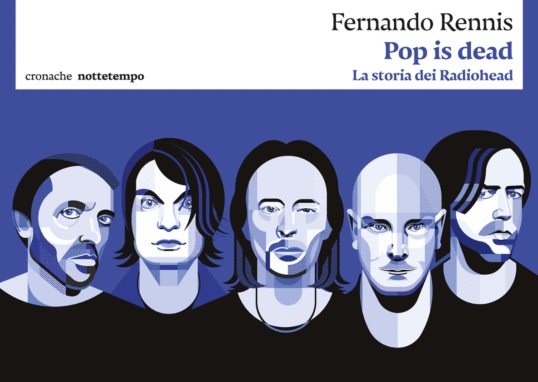



A complemento di questo interessante articolo, consiglio le numerose riflessioni collodiane contenute nel Diario del Novecento di Piergiorgio Bellocchio: fulminanti.
Grazie, me lo procurerò