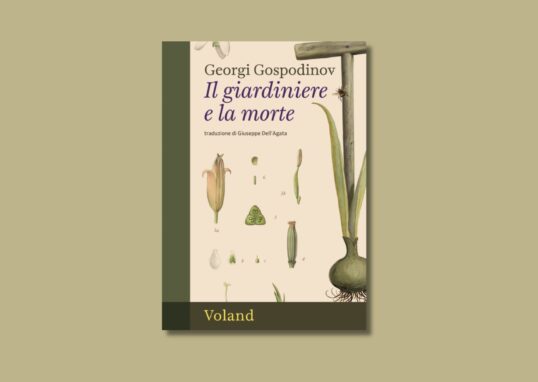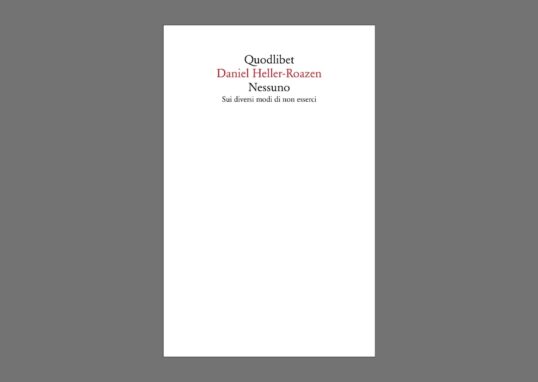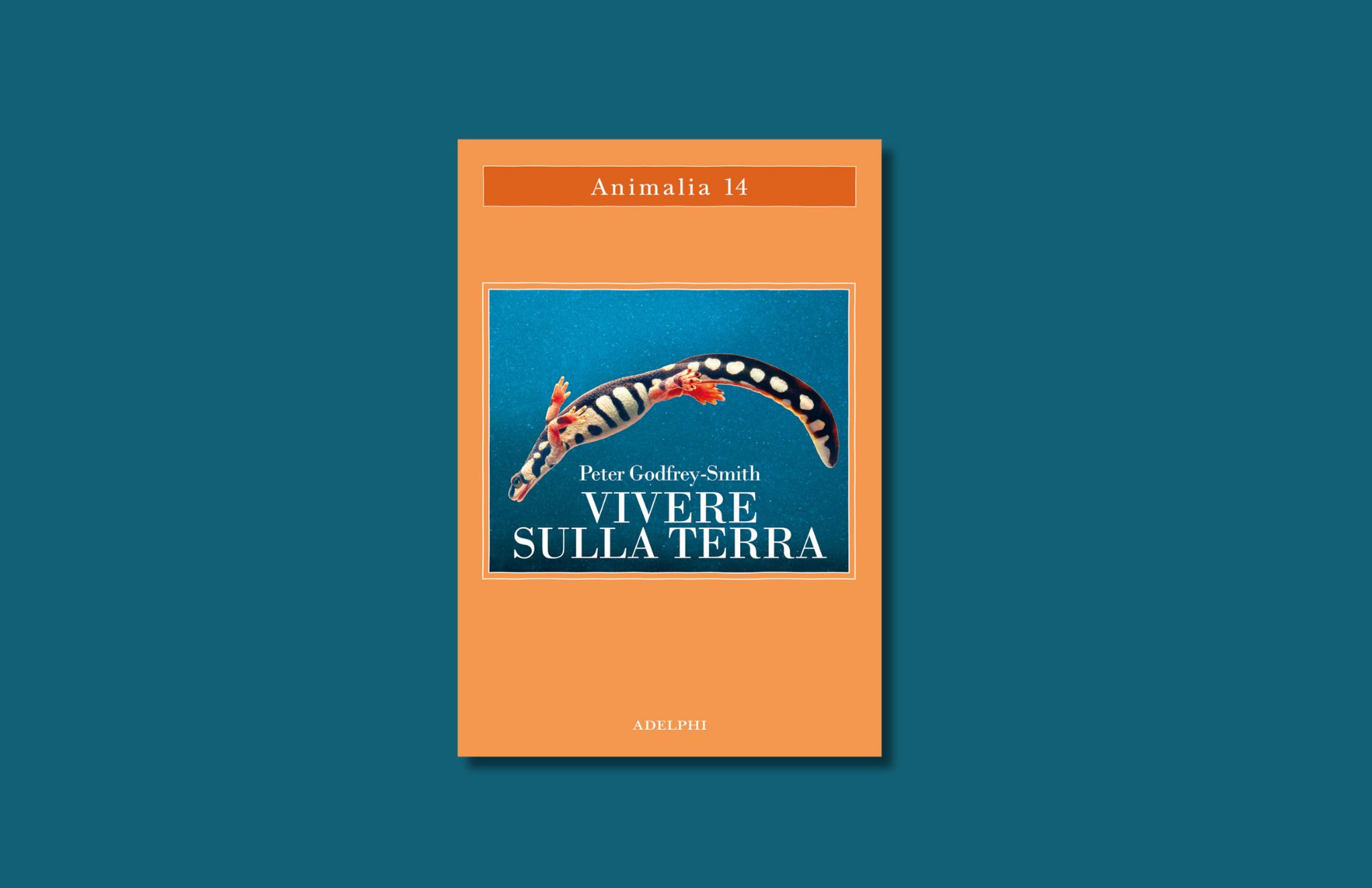
di Stella Margoni
Atomi: schegge, perle cieche, scintille ottuse di materia; minuscoli numi senza culto, che si urtano, si frantumano, si ricompongono e si disfano in un silenzio assoluto, da eoni ripetuto, ostinato, indifferente. Sul fondo dell’oceano, dove la crosta s’apre e sbuffa calore, si spalancano le bocche idrotermali, fumarole sulfuree che riversano acque sature di minerali, di residui incandescenti. In quei gorgoglii metallici l’idrogeno s’offre allo zolfo, il ferro al carbonio: cicli di ossidoriduzione che non sono ancora vita, ma già insistenza, già ostinazione ritmica, come un tamburo primordiale che prepara, più che l’ordine, l’abbozzo d’un respiro.
Poi il salto, il balzo funambolico: molecole che ricordano, catene di RNA che si replicano e copiano sé stesse. Ma il ricordo, nudo, sfilaccia; occorre un guscio, un orlo di grassi anfibi che si chiudono in bolla, membrana-soffio: dentro/fuori, confine tremulo eppure fondativo. Così la cellula: involucro che custodisce informazione e regola energia, prima figura del vivente.
E con i cianobatteri — minuscoli procarioti — si apre un’altra epoca. Essi imparano a rubare la luce al Sole, a spezzare l’acqua, a liberare ossigeno: uno scarto chimico che diventa dono planetario. «Grazie a questo processo la Terra ha potuto produrre molti più abitanti, e in molti più ambienti, permettendo alla vita animale di prosperare». E allora le rocce si ossidano, l’atmosfera si arricchisce, il carbonio si sotterra nei sedimenti: il cosiddetto «grande evento ossidativo» cambia per sempre la chimica del pianeta e spalanca la via alla complessità e a noi, in fondo, tardivi fruitori di quella festa ossidante.
Filosofo della scienza, docente alla University of Sydney, Peter Godfrey-Smith — già autore di quell’ Altre menti dove il polpo, cefalopode denso di enigmi e di tentacolare saggezza, veniva innalzato a controcanto dell’umano, e poi di Metazoa, ulteriore scorreria entro i corridoi del vivente, dalle spugne contemplative ai vertebrati balbettanti coscienza — possiede un raro, rarissimo talento: non gli riesce tanto di spiegare, ridurre, etichettare, quanto piuttosto di trasmutare, alchemicamente, i processi naturali in paesaggi, in scenari di narrazione, in un’epopea terrestre che è insieme cronaca e visione. Così Vivere sulla Terra, il suo libro più ampio e stratificato, si presenta come un atlante che non si piega all’inaridito gergo tecnico, né si abbassa al disciplinato manuale scolastico, ma procede a quadri, a stazioni, a epifanie: la Shark’s Bay con i suoi stromatoliti, reliquie viventi, semafori di un tempo che non conosce testimoni; le gole bluastre delle Blue Mountains, fenditure dove la geologia si fa canto e abisso; le foreste del Cretaceo, divenute teatro d’ombre vegetali e di vertebrati remoti; le montagne sommerse di Raja Ampat, vertigini coralline, guglie e bastioni sottomarini, là dove la vita appare come un’immensa e ininterrotta processione.
Se mai l’intera istoria terrestre — col suo magma primigenio, le sue acque vaporose, i suoi continenti che si sbrecciano, si ricompongono come in un lento minuetto tettonico — venisse compressa (fantasia da geologo immaginifico, o da calendario medievale miniato) entro lo spazio di un solo anno, allora, scrive Godfrey, la nostra specie — sì, l’Homo sapiens, borioso, fabbricante di utensili e di rovine, chiacchierone metafisico e contabile di sé stesso — entrerebbe in scena appena negli ultimi trenta minuti: comparsa tardiva, marionetta di fine spettacolo. Ma basta un rovesciamento d’ottica, uno sguardo che non si fissi sulla nostra effigie ma sul grande tessuto della vita, ed ecco che la figura si fa capovolta: la vita, con i suoi tre virgola sette miliardi d’anni di paziente proliferazione, accompagna la Terra fin dai suoi vagiti incandescenti, presenza non transitoria ma fissa, inquilina ostinata, inflessibile, che occupa e decora, infetta e santifica ogni anfratto dell’universo conosciuto. Allora l’uomo arretra, si restringe, scolora, ridotto a silhouette provvisoria su uno sfondo sterminato. La vita lo eccede, lo inonda, lo tracima; attorno a lui, attorno a noi, il pullulare smisurato degli enti viventi: polipi tentacolari e fiori effimeri, radici infossate e piume effervescenti, sino alle rocce stesse, granitiche e supposte inerti, che rivelano al microscopio il loro brulichio di batteri, cori invisibili, rumori di fondo, un’orgia di voci plurime in cui l’umano, povero solista stonato, non detiene più né la prima parte né il podio della direzione. Come annota Uexküll, osservando la zecca, «l’intero, ricco mondo che la circonda si contrae su sé stesso per ridursi a una struttura elementare, che consiste ormai essenzialmente di tre sole marche percettive e tre sole marche operative: il suo ambiente». Così ogni creatura, nel suo universo compatto, finito e sufficiente, contribuisce, con voce propria, alla sterminata orchestra del vivente.
Il filo conduttore — semplice nella formulazione, abissale nelle conseguenze — è che la vita non è contorno ma forza geologica, demiurgo nascosto, che ha inciso nel pianeta non meno di vulcani e maree. «La vita sulla Terra ha cambiato praticamente tutto»: non si è limitata a colonizzare il globo, lo ha scolpito, increspato, piegato.
Si prenda la foresta, epitome e laboratorio di tale potenza. Con l’apparizione delle piante a fiore, in quel Cretaceo febbrile e pullulante, la vicenda terrestre subisce una metamorfosi silenziosa e radicale: gli insetti — già veterani della storia, antichi di centinaia di milioni d’anni — diventano corrieri di polline, messaggeri che collegano individui lontani; gli uccelli, alati complici, trasportano semi, disseminano geni, trapuntando l’aria di migrazioni invisibili. La foresta, da semplice collezione di tronchi, si rivela sistema corale, consorzio multilivello; le radici che trattengono il suolo piegano i fiumi, ne deviano le correnti; gli animali che rimescolano terra e aria, tessono un continuo movimento. «Le piante generano le sponde fluviali; le sponde convogliano l’acqua; l’acqua scava valli e montagne»: è la vita che (ri)disegna, con mano invisibile, la geografia.
E questa scrittura, che pare di paesaggio, è in realtà scrittura di molecole: ciò che l’occhio percepisce come albero, valle, respiro, è il risultato di un teatro invisibile, di reazioni biochimiche che lavorano senza tregua. Nelle foglie agisce il ciclo di Calvin, coreografia minuziosa che cattura la luce e imprigiona carbonio; al suo centro la clorofilla, gemella divergente dell’emoglobina, con cui condivide l’anello porfirinico ma ne differisce per il cuore metallico — magnesio invece di ferro —, distinzione minima e cosmica che separa il verde della linfa dal rosso del sangue. Le piante, lungi dall’essere benefiche macchine per l’uomo, respirano come gli animali: una foresta matura consuma quasi quanto produce, e solo quando una parte della biomassa si sottrae al ciclo — sepolta, fossilizzata, trattenuta nel ventre della Terra — l’ossigeno si accumula nell’aria. La foresta respira per sé, indifferente alla nostra sopravvivenza: e proprio in questo respiro autonomo, non rivolto a noi ma al proprio enigma, muta i cicli globali, piega la Terra al suo ritmo segreto.
Ma la vita, nel racconto di Godfrey-Smith, non si limita a piegare rocce, a riscrivere fiumi, a mutare l’atmosfera: essa intona anche un paesaggio sonoro, una partitura invisibile che vibra nelle gole, nei boschi, nelle giungle marine. Molti animali non si accontentano di comunicare: si esibiscono. Colori, danze, canti non sono meri vettori di informazione, ma domande rivolte a un giudice invisibile: sei attratto? sei colpito? L’evoluzione non procede soltanto sotto il giogo della necessità, ma si lascia trascinare da estetica, piacere, seduzione. Emblema di questa eccedenza è l’uccello lira australiano, che in pochi minuti convoca un’intera enciclopedia acustica: il richiamo del kookaburra, lo schiocco d’un frustino, il ronzio metallico d’una sega elettrica. Riproduce il mondo e lo archivia in un repertorio che non è individuale ma collettivo, che passa di generazione in generazione come un bene ereditario. «Se si scoprisse che questa capacità è antica, potrebbe trattarsi dell’esempio più arcaico di un mezzo di registrazione apparso sulla Terra». Così la vita, oltre a forgiare climi e geografie, genera archivi estetici: danze, ornamenti, repertori che sono insieme esibizione e memoria.
Ed è proprio in questa consapevolezza — la vita ci eccede, ci avvolge, ci riduce a nota in un concerto smisurato — che s’insinua la domanda etica, ineludibile: che ne facciamo, noi, di questa vita che non ci appartiene? Le forme che costringiamo negli allevamenti intensivi rivelano il lato oscuro della nostra potenza: capannoni chiusi come tombe, stagioni cancellate, corpi compressi in geometrie innaturali. Non è solo dolore fisico, è negazione di ogni progetto vitale, monotonia programmata, esistenza ridotta a produzione: «In molti casi, non vale la pena di vivere in un allevamento intensivo… è una combinazione di stress, monotonia e profondo disagio». Non dovrebbe l’uomo, piuttosto, come scrive Gadda, «ricostruire l’intimo e insostituibile dispositivo della organicità», restituire forma—non profanarla? E non è, qui, nell’allevamento, null’altro che sfruttamento, produzione senz’anima, al posto della vita e della forma?
Custodire la natura, allora, non significa imbalsamarla in reliquia da museo, cornice per la nostra nostalgia; significa, al contrario, limitare l’invadenza, lasciare che i processi si dispieghino secondo il loro ritmo autonomo. Non per puro diletto estetico, ma per riconoscenza: perché ciò che eccede il nostro volere merita di continuare. «Il nostro obiettivo può essere – segnala Godfrey – tenere sotto controllo la maggior parte delle influenze umane lasciando, al contempo, che le cose procedano come farebbero senza di noi».
L’ultima scena si consuma sott’acqua, in quell’immenso teatro liquido di Raja Ampat, dove una montagna s’innalza dal blu profondo — Blue Magic, nome che pare incantesimo, favola marina — e attorno danzano le mante oceaniche, enormi ombre alate, e i banchi d’argento, sciami tremolanti come specchi mobili, come monete di luce. Ma sotto la festa cromatica serpeggia un monito: la vita terrestre, per quanto ostinata, porta in sé la propria data di scadenza. Tra cinquecento milioni e un miliardo d’anni — cifra che schiaccia l’immaginazione — l’aumento della furia solare soffocherà la fotosintesi, prosciugherà gli oceani, e infine il Sole, gonfiato a mostruosa sfera rossa, divorerà la Terra intera, restituendola al fuoco da cui era emersa.
Eppure, molto prima che si compia quest’apocalisse stellare, potrebbe toccare a noi — piccoli, arroganti, ciechi — precipitare la fine. Saremmo allora, nella cronaca universale delle azioni viventi, non i custodi né i cantori, ma i cattivi: gli artefici della distruzione, gli scribi della rovina, coloro che avranno scritto anzitempo la parola fine sul libro smisurato della vita sulla Terra.
Vivere sulla Terra si legge come un atlante del vivente. Non manuale divulgativo, non catechismo morale: ma geografia poetica della vita — che non coincide, si badi, con l’uomo (questo primate in giacca e cravatta, arrivato tardi a banchetto quasi finito, e subito persuaso di dover presiedere il convito), bensì con la grande vicenda del vivente. La vera protagonista è lei, la vita, in tutte le sue metamorfosi. Godfrey-Smith ci rammenta che ciò che respiriamo, ciò che pestiamo col piede tronfio e urbano, è il risultato di un’azione collettiva che dura da miliardi di anni e che, con buona pace del nostro narcisismo, continuerà anche senza di noi.
Forse allora il compito, come ci ricorda Anna Maria Ortese — vigile sempre alle minime creature, ai dettagli trascurati — non è soltanto custodire, ma comprendere: accettare che «segreto è il mondo, per quanto si scavi; e ha dolore, ma anche gioie indicibili; e forse si può ancora salvare con qualche sforzo, o arrestarne la fine. Ma ciò che conta non è questo. È comprenderne il senso, finalmente, preparare in noi – di esso, di questo mondo – una memoria non abbietta; riprendere in noi tutto l’interrotto discorso della Legge -Vita morale».
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente