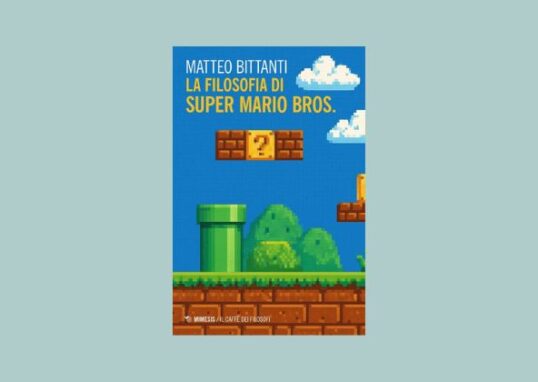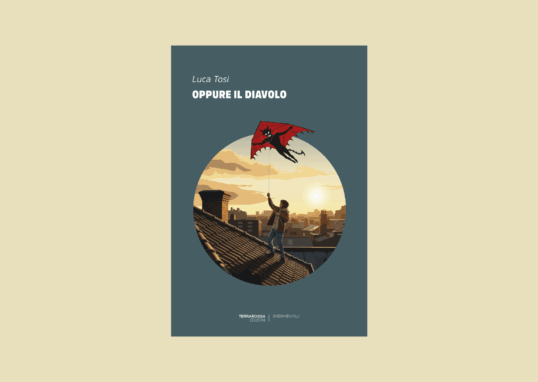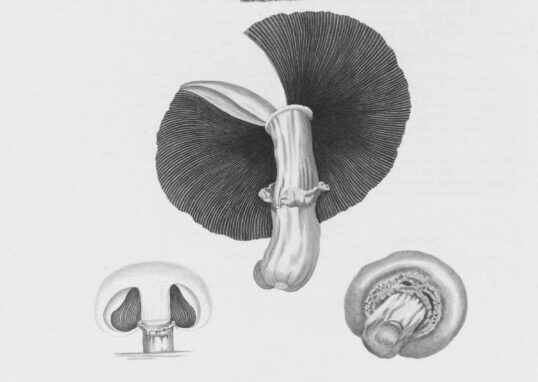Pubblichiamo un testo dello scrittore e musicista Willy Vlautin sul suo ultimo romanzo, Il cavallo, uscito per Jimenez.
Ho sempre avuto una lista di argomenti di cui avrei voluto scrivere. La cosa strana è che la musica non è mai stata in cima a quell’elenco. La verità è che è entrata a malapena nella lista, anche se ho fatto parte di band in tour per trent’anni e ho scritto centinaia e centinaia di canzoni da quando avevo undici anni. I miei libri menzionano appena la musica e in essi i musicisti sono più simili a santi che a suonatori. Willie Nelson (Motel Life) perché volevo che proteggesse i fratelli Flannigan e Amália Rodrigues (The Free) perché se una voce potesse salvarvi sarebbe la sua.
Otto anni fa mi trovavo in una strada sterrata nel centro del Nevada con un vecchio amico, Brian Foster. Eravamo a cinquanta chilometri da Tonopah e si avvicinava il crepuscolo quando ci imbattemmo in un cavallo selvaggio nel bel mezzo del deserto. Era una cosa talmente strana vedere un cavallo nel deserto che ci fermammo e uscimmo dal pick-up. Non c’era acqua, né erba, né ombra per chilometri e il cavallo era immobile, sembrava una statua. Appena ci avvicinammo, notammo che era cieco. Entrambi gli occhi erano gonfi e da una delle orbite pendeva un rametto d’artemisia. È la cosa più triste che abbia visto in vita mia. L’idea che si possa vivere tutta una vita per poi ritrovarsi cieco e solo in mezzo al deserto mi ha paralizzato.
Quella notte ci siamo accampati e siamo tornati in città la mattina dopo. Abbiamo contattato l’ufficio per la gestione del territorio di Tonopah e sono andati a prendere il cavallo. Cosa gli sia successo dopo, non lo so. Ma le notti seguenti non riuscivo a dormire. Durante il giorno tutto ciò di cui parlavamo era il cavallo. Guidavamo, ascoltavamo musica, bevevamo e parlavamo. Quando arrivammo a un vecchio sito minerario, ancora più lontano, e vedemmo una baracca di legno con una sola stanza, un ufficio del saggiatore abbandonato, dissi al mio amico che era lì che avrei voluto vivere il resto della mia vita.
Dico un sacco di stronzate, ma quella volta non stavo scherzando. Gli ho detto che non ero più tagliato per la brutalità e lo strazio della vita. Che non ero mai stato abbastanza forte e che con l’età mi ero sempre più abbattuto, per giunta. La mia pelle era diventata più sottile, non più spessa. Mi conosce da trentacinque anni ed è sempre stata la stessa storia con me: musica, scrittura, alcol, tenebre e fuga. Gli ho detto che avrei vissuto da solo e che così facendo avrei abbandonato la mia lotta con l’alcol, con la scrittura di canzoni, con i romanzi e con la mia incapacità di fermare cose come un cavallo cieco nel mezzo del deserto.
Il mio amico ha semplicemente riso. «Sei sempre il solito vecchio figlio di puttana. In una settimana finiresti le scorte di tequila e birra, ti mancherebbero tua moglie e le tue colonne sonore da spaghetti western, e Criterion Channel. Finiresti per trovare lavoro a Las Vegas, per cercare di rimetterti in sesto e sistemare le cose con tua moglie, rivorresti indietro la tua chitarra e la possibilità di comprare una bottiglia di tequila decente. E una volta ottenuto tutto questo, vorresti un posto dignitoso in cui vivere, una macchina e un cane. Ricomincerebbe tutto daccapo.»
Ho avuto a che fare con autori di canzoni per gran parte della mia vita. Solo un paio ci hanno guadagnato da vivere. E allora perché tutti loro continuano a farlo? Perché Al Ward scrive canzoni sapendo che nessuno le ascolterà mai? Tutto ciò che posso dire è che c’è una specie di sollievo che arriva quando finisci per la prima volta una canzone che pensi sia buona. Una canzone che nessun altro ha sentito. C’è della speranza. È come essere innamorati ma essere gli unici a sapere come ci si sente. O forse è proprio come un drink, come quel momentaneo sentore di paradiso, cavolo se è difficile da abbandonare. Ma come con un drink, l’euforia per una nuova canzone se ne va non appena te ne accorgi, e tutto ciò che puoi fare è cercare di inciampare in un’altra per sentirti di nuovo così.
Al Ward ha vissuto la sua vita sul filo del rasoio, sempre in bilico e, purtroppo, sempre nel tentativo di riprendere fiato. Ma non ha mai mollato, e lo amo per questo. E proprio perché non ha mai mollato, ha salvato il cavallo e, con lui, ha salvato se stesso. So che il libro è solo frutto dei miei sogni, ma mi rincuora pensare che il cavallo stia bene, almeno in qualche mondo. Nel mio, è al sicuro con Lonnie, in un pascolo con altri cavalli. Può vedere quanto basta per andare avanti, e non è solo.
***
C’è una malinconia che vive in questo libro, come una canzone triste che sta sempre in sottofondo. In qualche modo, il libro stesso è come una canzone. Al Ward ha attraversato la sua vita scomparendo nella musica, così Amy Baker e io abbiamo messo insieme un elenco di artisti, gruppi e canzoni che compaiono nel libro. Alcuni sono brani che Al ha dovuto suonare nei casinò, altri sono quelli che lo hanno ispirato e altri ancora danno un’idea del suo stile come autore, dagli inizi come musicista da casinò con Bobbi Blue and the Bonnevilles fino agli anni del cowpunk con i Sanchez Brothers. Speriamo che queste canzoni aiutino a descrivere il mondo della musica all’interno di Il cavallo.
(la traduzione è di Valentina Zucca)
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente