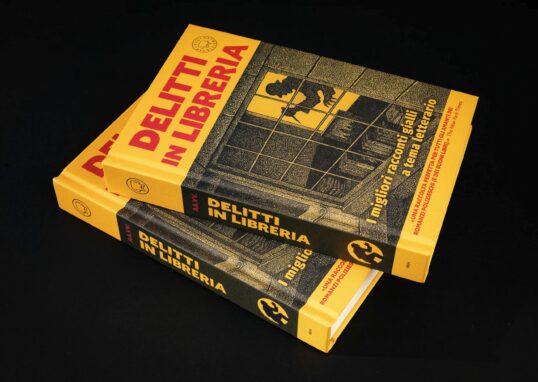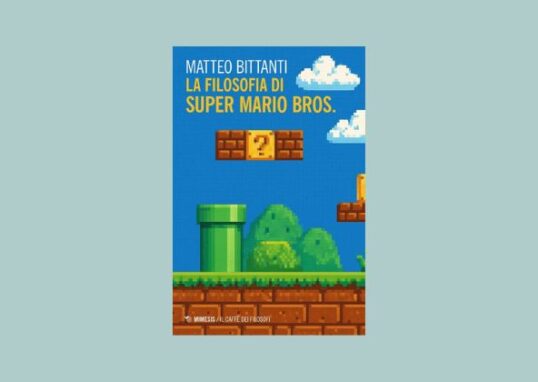È in libreria Il cuore è un cane senza nome, romanzo d’esordio di Giuseppe Zucco (minimum fax): pubblichiamo un estratto e vi segnaliamo che domani, mercoledì 7 giugno, alle 19.30 l’autore presenta il libro da Giufà a Roma con Antonio Pascale.
Lei lo aveva lasciato, e lui aveva continuato come nulla fosse. La mattina andava a lavorare, la sera tornando a casa comprava il pane, la notte dava due giri di chiave alla porta prima di spegnere le luci. Era tutto sotto controllo, diceva, e sgranava i denti davanti ai quattro amici che gli avevano dato appuntamento in centro, per una birra, cercando di capire come stava. Una volta, mentre riempiva la lavatrice, avevano suonato alla porta. Era il postino, aveva una busta per lei. Senza scomporsi, lui disse che lei non abitava più lì, né sapeva dove potesse raggiungerla. Con la stessa cortesia, attese che l’uomo appuntasse l’informazione su un block-notes, e poi lo salutò. Ma una mattina, mentre lavava i denti, tirando su la testa davanti allo specchio, scoprì che guaiva. Non lo aveva mai notato prima, né sapeva quando aveva cominciato, ma adesso, con gli occhi dilatati per la sorpresa, era perfettamente cosciente del lamento che gli sfuggiva dalle labbra.
Era una nota che partiva bassa, e durava qualche secondo prima di prodursi in uno strazio più acuto – e lui, da quel momento, facendoci caso, ebbe presto la certezza che non guaiva solo la mattina, davanti allo specchio ricoperto di goccioline, ma anche mentre guidava controluce sulla tangenziale, o quando scorreva le email sperando di trovare un suo messaggio, uno qualsiasi.
Focalizzando l’attenzione su quel fenomeno, ma staccandolo dalla sua persona, come se lui e la sua laringe non ne avessero responsabilità, lui notò che i guaiti si presentavano nel corso della giornata senza alcuna regolarità evidente. A volte erano secchi, concisi e appena percettibili, altre molto più articolati e paradossalmente armoniosi – cosa che, sulle prime, lo disorientò.
Aveva sempre creduto che il dolore, quello vero, si manifestasse in forme scomposte e slabbrate, la frattura delle ossa era la tipica figura del dolore, pensava, la carne tutta sfrangiata, mentre adesso la sua consapevolezza aveva allargato il cerchio, dato che il guaito, quel dolore, in quel momento, amplificato nel guscio vuoto di un ascensore in salita, gli risaliva le labbra con una melodia, cioè un giro di note, un vero e proprio sistema ordinato. Era anche vero che lui non sapeva se le persone che gli stavano intorno avessero dimestichezza con quei lamenti. Poteva anche darsi che non li avvertissero o che invece, usandogli pietà e comprensione – erano stati tutti coinvolti in una relazione impossibile, almeno una volta nella vita – irrigidissero la schiena facendo finta di niente. Ciononostante, se era al lavoro, circondato dai colleghi, e il guaito era appena percettibile, lui, portando una mano alla bocca e premendo l’altra sul petto, dava un gran colpo di tosse. Al contrario, se il guaito era articolato, e non aveva dubbi sul fatto che stesse per sfuggirgli dalle che stesse per sfuggirgli dalle labbra sbiancate per lo sforzo di contenerlo, lui correva in bagno, chiudeva la porta e davanti ai graffiti di carattere sessuale tracciati sul retro della porta e seguiti da numeri di telefono – uno di questi era stato addirittura il suo e aveva dovuto raschiarlo via con un coltello sottratto alla mensa aziendale – dava libero sfogo al guaito, tirando l’acqua più volte, fermando poi gli occhi su quella figurina ormai familiare disegnata sulla porta. Una donna nuda, incisa con la punta di una penna rossa, le gambe divaricate e accoglienti.
La cosa strana, pensava, era che i guaiti non colmavano l’aria quando ritrovava uno dei suoi vestitini nell’armadio, o un reggiseno nei cassetti, o un paio di orecchini nel portapenne sulla scrivania, o l’enorme valigia che nella loro intimità chiamavano la bara e che lei si portava dietro strapiena anche se partiva per pochi giorni e che la polvere, stendendosi con uniformità, aveva reso di un blu opaco – quegli incontri erano la norma, lui non aveva toccato nulla, se lei fosse tornata avrebbe trovato ogni cosa nello stesso posto. I guaiti sgorgavano con una modalità tutta loro, un tempo loro, una tabella di marcia a cui lui non aveva accesso, come se la parte più straziata di se stesso gli lavorasse dentro in completa autonomia.
Così lui guaiva mentre faceva benzina, o provava un paio di scarpe nuove, o compilava il modulo di un bonifico bancario per spese odontoiatriche, o ingoiava l’insalata di riso presa in offerta al supermercato. Se proprio voleva tracciare una statistica, guaiva più di giorno che di notte. Ma di questo non era sicuro. Per averne certezza, avrebbe dovuto ricordare tutti i momenti in cui gli veniva da guaire, e il perché guaiva, soprattutto quello, quando in realtà aveva solo voglia di dimenticare tutto, di annullare tutto, di resettare la memoria fino a un livello prenatale, trattenendo solo il ricordo di uno spazio vuoto e infinito e nerissimo e benigno in cui le sue cellule si erano moltiplicate e avevano preso forma, uno spazio da cui traevano origine tutte le religioni, e per riuscire in quell’impresa adottava dei piani disperati per tenersi occupato e non pensarci, non pensarla, non visualizzare la curvatura morbida delle sue labbra, non farsi invadere dalla risacca livida dei ricordi di lei che rincasava alla fine di una corsa lungo le strade del quartiere, le guance così rosa e tese e lucide come dopo che avevano fatto l’amore – e una volta aveva svitato le lampadine, stanza per stanza le aveva svitate sostituendole con quelle a basso consumo, anche se le nuove ci mettevano poco più del normale per scaldarsi e accendersi, e quelle frazioni di secondo tra il momento in cui schiacciava l’interruttore e il momento in cui il globo incandescente tornava a instaurare il consueto sistema solare lo lasciavano preda dei ricordi, e questo non era affatto un bene, questa era un’altra piccola morte a cui non trovava rimedio.
Ripensandoci, però, lui prese la decisione di non dimenticare. Non voleva dimenticare. Non voleva dare l’eutanasia ai propri ricordi. La considerava una forma di tradimento. Tradimento verso di lei e verso se stesso – e più che altro verso la parte di se stesso che amava, che amava senza condizioni, che avrebbe dato seguito a qualsiasi cosa lei gli avesse chiesto, perfino entrare in una cellula terroristica, perfino vivere per decenni in clandestinità cambiando domicilio appena il presentimento che qualcuno li stesse pedinando li avesse costretti schiena alla parete e armi in pugno, arrivando a sperimentare sulla propria pelle che l’amore non era il bene, l’amore, per quanto ne sapeva lui, in quel momento, era solo un corridoio senza uscite infestato da presenze autoritarie, e forse, o a ragione, era questa la causa se anche dopo mesi dalla sua dipartita lui stagnava in quelle condizioni e guaiva, guaiva senza controllo.
Che non stesse proprio in forma, se ne erano accorti soprattutto al lavoro. Lui, dimagrito, non pranzava neanche in mensa. Portava da casa certi piccoli recipienti di plastica trasparente colmi di insalata di riso, e una confezione di grissini, se proprio aveva ancora fame. Rifiutava gli inviti a pranzo. La compagnia era uno degli amuleti per scongiurare il male, dicevano i colleghi – ma lui se ne stava per i fatti suoi, davanti al computer, declinando qualsiasi offerta di aiuto con un’espressione mite che, almeno per pochi istanti, come un’improvvisa crepa di luce sulla grafite del cielo rannuvolato, si avvicendava a una maschera cupa e dai lineamenti incavati. Durante le ore di lavoro, del resto, non faceva altro che tossire o correre in bagno, e dal bagno erano soliti arrivare certi suoni che lasciavano i presenti visibilmente scossi, anche se qualcuno, per calmare gli animi e rompere la crosta ghiacciata di un silenzio che si era diffuso sulle superfici delle scrivanie, diceva che quei rumori dovevano venire da un giro di tubature difettose.
E anche se una sera lui era uscito con una donna conosciuta da poco – una carina, con un vestitino corto ed eccezionalmente sfidanzata, quanto di più vicino al lusso, dato che la loro era un’età in cui la maggioranza era sfibrata dai preparativi di un matrimonio o dall’attesa del primogenito – e avevano parlato ininterrottamente senza sfiorare argomenti impegnativi, e camminando in centro si erano fermati in una piazza per vedere lo spettacolo improvvisato da alcuni mangiatori di fuoco, e lui aveva detto che quelle fiamme erano dovute all’alito particolarmente cattivo dei mangiatori di fuoco, scatenando la vittoria assoluta di una piccola risata femminile tutta piena di dentini, e in presenza di quella deliziosa compagnia non aveva guaito neppure una volta, la situazione era ormai più o meno quella.
Più guaiva, più per il timore che qualcuno scoprisse e divulgasse quella debolezza si isolava. E poiché negli ultimi tempi i guaiti si erano moltiplicati, la solitudine, come un roveto fitto di spine, aveva iniziato ad accerchiarlo su tutti i lati. Per uscire da quella trappola, lui avrebbe voluto parlarne con qualcuno. Dire apertamente, e senza pericoli, in cima a un divano, guarda, io guaisco. Ma poi lo coglievano quelle paure – la paura di sentirsi ridicolo, o di sentirsi commiserato, o cosa ancora più terribile di sentir liquidare la disperazione che gli covava dentro con qualche battutina di circostanza e quell’umiliante teoria del tempo che curava l’amore, cioè il male, a questo punto, come se quello che lui provava potesse avere una data di scadenza e riuscisse a disincagliarsi dalla doppia elica del suo dna dove le particelle più resistenti, intanto, erano diventate genetica, caratteri ereditari e destino.
Ci fu anche il momento in cui gli amici, non vedendolo in giro né sentendolo al cellulare, andarono a trovarlo a casa. E quando lui con la pelle bianca e opalescente aprì la porta del suo appartamento, loro non trovarono quanto avevano previsto. Non c’erano pile di piatti sporchi in cucina, né lattine schiacciate sul tappeto parzialmente ammuffito in soggiorno, né specchi sfigurati dal lancio di un bicchiere, né la carta da parati tirata via a larghe strisce, né la cenere delle fotografie date alle fiamme, né la chiazza fetida del liquido che gli aveva risalito le labbra dopo l’ultima telefonata. Seguendolo oltre la porta, gli amici avevano preso atto che la casa era tremendamente pulita e ordinata. Il pavimento brillava.
I quadri erano allineati sullo stesso orizzonte. C’era solo quell’odore, dicevano gli amici, sorridendo, come da sala d’attesa – e, in effetti, la casa era diventata quello, una macchina che produceva attesa, che incamerava attesa, che la distribuiva in parti uguali nelle stanze vuote. Una macchina che, nell’esatta disposizione degli oggetti che lui aveva stabilito, i romanzi appaiati nella libreria, gli asciugamani ripiegati, le tazze schierate dietro la vetrina, prefigurava l’arrivo di una sola persona con i capelli lunghi e le labbra disegnate dal dio dei giusti, prima che tutto smottasse e digradasse nel disordine della vita di ogni giorno. Gli amici si sedettero, incrociarono le dita delle mani. Non aveva nulla da offrire, il frigo era vuoto. Si accomodò anche lui e attese in silenzio. Fino a quando uno dei quattro non disse se lui ricordava l’estate, quell’estate, l’arroventata estate del campeggio sul mare – le tende, le birre calde, la ragazza con le tette piccole. Erano ragazzi perduti, allora. Erano arrivati al mare con una serie di passaggi fortunosi, avevano mangiato per giorni tonno e pomodori, e avevano perso a turno la verginità sudando sulla stessa ragazza. Era stata quell’occasione a legarli definitivamente. Le ragazze passavano, loro sarebbero rimasti, qualsiasi cosa fosse capitata.
A quelle parole – parole che in altri casi, e con maggiore presenza di spirito, avrebbe definito materialismo storico – lui era corso in bagno. I quattro sentirono quei suoni, e sebbene gli si ghiacciasse il sangue, uno disse che dovevano appartenere a un cane di medie dimensioni, un cane né tenero né addomesticato, un cane che sicuramente aveva raccolto per strada e di cui si vergognava, altrimenti glielo avrebbe presentato invece di tenerlo chiuso in bagno – e la sola idea che lui avesse rimpiazzato una donna con un cane li riempì di un entusiasmo adolescenziale.
Ma poi la solitudine venne a riprenderselo. Dopo il lavoro filava a casa – e questa volta ci era tornato con una bruciatura di sigaretta sul braccio sinistro. Seduto sul divano, davanti al televisore spento, lui guaiva, guaiva a più non posso, e trattenendo il respiro per calmarsi poi guaiva ancora, e la vicina del piano di sopra iniziò a battere con il legno della scopa sul pavimento, maledicendo con un solo svuotarsi di polmoni chiunque tenesse i cani nella gabbia asfissiante di un appartamento chiuso.
Distratto com’era, interessato più che altro alle crepe sull’asfalto, passando vicino a una collega che fumava per strada in pausa pranzo, aveva toccato la brace della sigaretta, e per quanto avesse ritratto il braccio, ora aveva quel cerchietto rosso – e tra un guaito e l’altro, guardando la pelle bruciata, e sprofondando più giù, tra i confini del cerchietto, ricordò che lei fumava, non sempre, fumava soprattutto prima di partire. Lei viaggiava per lavoro, partiva e arrivava di continuo. Lui l’accompagnava ogni volta che poteva. Niente lo faceva sentire un essere umano come l’odore delle stazioni, diceva lui. Quel misto di contenitori carichi di escrementi, frizione dei freni, ferraglia rovente, sudore, grandi speranze. Quando lei diceva che non c’era motivo, poteva andare anche da sola, lui diceva che aveva capito male. Non era per lei che correva con le valigie in stazione, aggirando in volata ladri e spacciatori, era puro egoismo. Ne aveva un bisogno fisico, diceva, cercando di dissimulare la schiavitù nei confronti delle sue labbra. Con un tono a metà tra scherno e verità assoluta, a volte confessava che tornava in stazione anche se non doveva accompagnare nessuno. E la cosa era puntualmente successa – dopo che lei lo aveva lasciato, si era confuso tra la folla delle partenze, sperando di incrociarla, e solo lo stridore dei freni di un treno in arrivo aveva poi coperto le evoluzioni di un guaito lunghissimo.
Sulle sponde del cerchietto slabbrato, tornando a galla e immergendosi ancora, come se il suo corpo fosse l’erede di Sharazad e contenesse in ogni punto della sua estensione tutte le storie, lui ricordava che erano sempre di corsa. Avevano rischiato una quantità spaventosa di volte di perdere il treno, ma lei, infine, riusciva a salire e salutare con la mano dietro il vetro caliginoso del vagone in movimento. Una volta, sulla banchina, una di quelle rarissime volte in cui erano in vantaggio rispetto alla partenza del treno, un evento irripetibile, diceva lui, pura e semplice congiunzione benigna degli astri, diceva, quando in realtà aveva barato sull’orario e l’aveva costretta a uscire prima di casa, lei fumava e lui aveva detto che avrebbero dovuto sposarsi in stazione, tra i treni che andavano e venivano, tanto passavano lì parte della loro vita, precipitandosi al binario giusto. I capitreno avrebbero indossato il cappello con la visiera e soffiato nel fischietto tutti nello stesso istante. Lei, già contrariata dal fatto che lui avesse mentito sull’orario, disse che doveva metterselo bene in testa, non si sarebbe sposata né ora né mai, e schiacciando la sigaretta con due giri di punta, era salita sul treno voltandogli le spalle. Il treno partì – e lui, adesso, affiorando definitivamente dal cerchietto di pelle bruciata, constatò che intanto l’oscurità si era depositata su ogni cosa, il braccio, il divano, il televisore, e solo i fari delle macchine giù in strada, filando di tanto in tanto sul soffitto, gli restituirono il sentimento del tempo.
Il giorno dopo compì gli anni. E se era riuscito a sfuggire una cena di gruppo con quei sorrisi temporanei e instabili come la fiamma sulla punta delle candeline, dichiarando i lunghi strascichi di una febbre che lo tormentava da giorni, dovette rispondere a quelle telefonate. Lo chiamarono più o meno tutti, compresi i parenti che abitavano in un altro continente, e lui si dimostrò grato, e ricambiò quell’affetto dicendo che stava bene, mai stato così bene, non accennando neanche per un attimo alla vita segreta di certe parti del suo corpo dove i nervi, schioccando di colpo, rivelavano il loro tracciato reticolare e sotterraneo. Solo una volta, quando gli chiesero di lei, se l’aveva più sentita, se l’aveva vista, se c’era un’infinitesimale probabilità che tornassero insieme, lui schiacciò le mani sulla bocca aperta, evitando che il rintocco lugubre di un guaito infestasse il giorno e la notte di una vecchia zia.
Non avendo preso impegni, con un solo pensiero fisso, scese in strada. Camminò sul viale, e poi ne imboccò un altro, e tirò dritto fino a quando gli ressero le forze. In alcuni punti della strada accelerò il passo – lì era dove l’aveva baciata la prima volta, lì era dove avevano giocato un pomeriggio a nascondino, lì era dove lei gli aveva sorretto la testa mentre vomitava in seguito a un’intossicazione alimentare non specificata. La concretezza spettrale del passato lo assaliva senza scampo.
E per un attimo, anche se ormai la praticava sempre meno, si rifugiò in quell’ironia disperata – e immaginò che il mestiere più richiesto del futuro sarebbe stato quello della Disinfestazione Sentimentale, e che lui, forte di curriculum, sbaragliando una squadra agguerrita di candidati, avrebbe speso il resto della vita a risucchiare nel ventre cieco di un aspiratore i fantasmi amorosi che nel tempo, conservando un fondo inattaccabile di squallore e rimpianto, si erano annidati ovunque, dietro i monumenti o tra gli alberi nei parchi o negli spazi anonimi pieni di preservativi usati, i, calze rotte e frasi sgrammaticate scritte sui muri. Arrivò in centro, si sedette su uno scalino di marmo per prendere fiato. Aveva quella chiesa davanti, e ripercorrendone le linee nella luce dorata, entrando in intimità con la facciata cariata dai secoli e dalla cattiva manutenzione, desiderò essere posseduto dall’amore disincarnato e completo dei santi e dei cherubini. Sospirando ancora, si alzò. Scosse con le mani la parte posteriore dei jeans, e filò alla fermata degli autobus. Aspettò il suo. Ma aspettando e salendo sulla vettura, su cui aveva incredibilmente trovato un posto libero, si accorse che la gente si ritraeva dalla sua vicinanza.
Un bambino gli puntò l’indice contro, la madre lo portò giù. Non stava bene indicare gli sconosciuti, disse. Eppure, non solo il bambino, ma sua madre, e i passeggeri, perfino quelli distratti da una fitta conversazione al cellulare, riportarono a lungo nella memoria le stimmate di quell’uomo seduto sull’autobus, i ciuffetti di peli ispidi che gli spuntavano dalle orecchie, le unghie così lucide da apparire dure e minerali, gli zigomi e la mascella più sporgenti del dovuto. Una volta a casa, stremato, si sdraiò sul letto. Non accese la luce. Non cenò. Altre telefonate di auguri illuminarono lo schermo del cellulare – non rispose. Sfilando le scarpe, i calzini, i jeans, la maglietta, rimase nudo sulle lenzuola.
Nell’oscurità che premeva ai vetri della finestra, invocò il suo nome. Tre volte lo invocò, e non ricavandone sollievo, si concentrò sul ricordo della curvatura delle sue labbra. Suscitandolo, iniziò a toccarsi. Fu una lunga seduta spiritica – più sfregava se stesso, più portava se stesso a compimento, più gli risaliva dalla carne e dalle ossa tutta la teoria vorticosa di quelle figure, la visione lucida e materiale del corpo di lei sopra il suo. I capezzoli di un rosa scuro, le costole sporgenti, i fianchi larghi, il breve nastro di peli neri e croccanti. Gli spiriti lo avvolsero tra le loro spire, e lo morsero, lo graffiarono, lo leccarono, e con interminabile dissipazione e immensa generosità lo trattennero nell’illusione dell’amore promesso e corrisposto, e lui venne da lei e lei venne da lui, e ansimando nell’oscurità e recuperando poco a poco regolarità nel respiro e vacuità lì dove un minuto prima la moltitudine agonizzante delle visioni gli sussurrava in coro tutti gli inattendibili accadimenti della vita futura, lui si girò di lato, guaì e si addormentò.
Fu una notte lunga – e anche se precipitò in un sonno profondo, lui non perse coscienza del suo corpo. Per tutto il tempo ebbe la penosa sensazione che le sue braccia si fossero ridotte, le gambe accorciate, il collo compresso, la mascella allungata, gli occhi ingranditi e il respiro tutto articolato in una serie di piccoli travagli respiratori. Solo ai primi chiarori capì.
Si era trasformato in un cane – e guaendo, guaendo con disperazione, e risultando quel verso del tutto appropriato alla sua nuova corporatura, il quadro si completò.