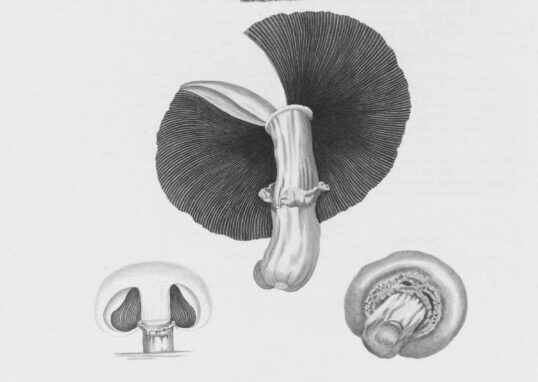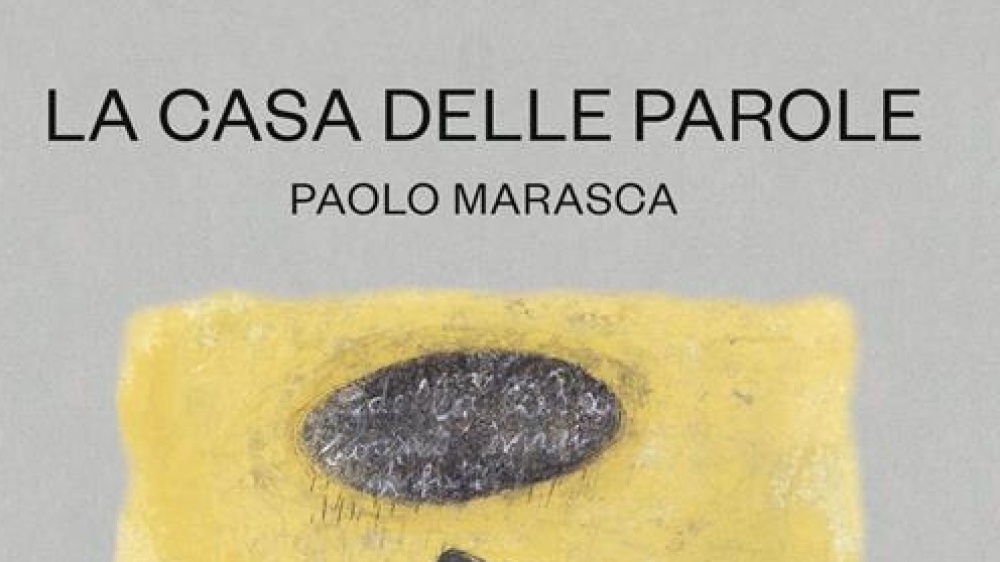
Ci sono cose inseparabili, come un pensatore e le sue parole. Ma cosa succede quando la comunicazione, esercizio di una vita, viene meno? È ciò che accade a Giuseppe, filosofo e psicologo – protagonista de La casa delle parole, romanzo di Paolo Marasca appena uscito per Milieu Edizioni – colpito da un ictus che ha compromesso le sue facoltà. Con una scrittura senza ornamenti, “Pura e dura come un minerale”- come scrive Massimo Recalcati in un suo commento al romanzo – Paolo Marasca ci conduce in una quotidianità senza routine, in una vita improvvisamente diversa da quella costruita per anni. Qui di seguito un estratto.
di Paolo Marasca
Giulia passava ogni minuto della sua giornata a pensare cosa servisse a Giuseppe, di cosa avesse bisogno: pantofole comode, una certa t-shirt, una fetta di torta, le forchette di bambù, la Gazzetta dello sport, l’ultimo libro di Federico Chicchi, federe per i cuscini, ciuffi di lavanda, matite, fotografie, caricabatterie, vino, musica, droghe leggere, del gin, un pettine corto per la barba, uno lungo per i capelli, dei dadi da lanciare sul tavolo. Ogni singolo oggetto che aveva avuto un giorno un ruolo nella loro amicizia, le appariva, ora, indispensabile per lui.
Benedetta gli sedeva accanto, di solito sul bordo del letto. Lo osservava e gli indicava con dolcezza le foglie degli alberi che, come miracoli, spuntavano fuori dal cortile affogato nel cemento del grande ospedale e arrivavano sino all’ultimo piano con le punte verdi e sottili che sfioravano i vetri e l’alluminio delle finestre sempre chiuse con i dadi a vista. Gli teneva spesso la mano.
E, una volta, Marco prese con lui l’ascensore. Scesero fino al pianterreno e finsero di uscire mescolandosi agli altri come due ladri, Giuseppe però quasi ci credette e Marco fu costretto a interrompersi e a richiamarlo: “No, Giuseppe” disse “è un gioco, non possiamo uscire, non puoi uscire” e quello fu un momento triste e lungo. Risalirono all’ultimo piano, Giuseppe tenne una mano sull’altra davanti al bacino e lo sguardo e il naso acuto puntati fissi contro il soffitto bianco dell’ascensore.
Poi, Luna prese a calci la porta del primario, andò a sbattere con l’auto e dormì per tre giorni e tre notti di seguito come a volte faceva lei, prima di parlare inutilmente con tutti i medici che conosceva.
Durante il ricovero, Benedetta andò a trovare Galizio. Galizio era un camionista di centoventi chili rimasto senza camion e senza una gamba. I giornali locali avevano scritto a lungo del suo incidente, e in rete si trovavano ancora le fotografie scattate da chi era rimasto fermo per ore in coda ad aspettare. Il rimorchio si era staccato e la cabina, rovesciata a muso in avanti, aveva strisciato per tre chilometri contro l’asfalto rovente. La lamiera s’era accartocciata sulla carne, l’aveva schiacciata e penetrata, i medici avevano detto che solo il fatto di essere così terribilmente grasso l’aveva salvato.
Galizio accolse Benedetta sulla soglia, era felice di vederla. Si erano conosciuti in ospedale, quando lo avevano deposto come un tricheco ferito sul letto accanto al suo, ricoverata per una frattura. Si era lamentato tutta la notte, e lei tutta la notte lo aveva ascoltato. Nessun altro sa cosa abbia detto, e non ne avevano mai più parlato. Nei giorni seguenti, avvolto dai tubi delle flebo, Galizio giurò che non avrebbe mai più guidato un camion.
Diceva ogni volta: “mi comprerò una barca!”
E gli altri ricoverati a turno: “Una barca?”
E lui: “Sì, una barca! E vi ci porto tutti quanti, ti ci porto Benedetta, amica mia.”
E ridevano tutti i santi giorni di quella barca che non sarebbe mai esistita.
Per la gamba non ci fu niente da fare. I solchi erano profondi, l’infezione estesa, i muscoli, i tendini e il sistema nervoso erano precipitati nell’abisso di un corpo dilaniato. I medici la amputarono. Pochi giorni dopo, Benedetta fu dimessa, Galizio non faceva altro che dormire.
La invitò a sedere al piccolo tavolo della cucina, coperto da una tovaglia a fiori gialli e con al centro un minuscolo vaso ricolmo di margherite.
Benedetta chiese “Come ci si sente?”
“Mi danno una pensione. E mia moglie lavora. Non ce la passiamo male.” Versò il caffè reggendosi senza difficoltà sulla stampella. Benedetta annuì.
“E la gamba?”
“Quale gamba?”
“Stupido.”
“Faccio ancora molta riabilitazione. E palestra, per i muscoli, per non squilibrarmi. Finirei per pendere tutto da un lato, così… Sono andato a corsi assieme ad altre persone senza braccia o gambe, sembrava di stare in quei film sulla guerra del Golfo. Ma è servito anche quello. E gli psicologi. Sono andato da diversi, poi dalla tua amica. Mi hanno prescritto degli antidepressivi. Per un po’. Forse tutto è servito.”
“Ti trovo bene.”
“Credo di sì. Ma come vedi niente barca.”
“Avete una bella casa.”
“Già.”
“Posso chiederti una cosa?”
“Mi fai ridere, Benedetta. Non so mai se ci fai apposta. Con questa timidezza. Chissà cosa ti avrò vomitato addosso quella notte in ospedale, quando non smettevo mai di parlare. Da quella volta tu hai diritto di chiedermi quello che vuoi.”
“È vero quello che si dice? Che quando ti tagliano un braccio, o una gamba, continui a sentirlo?”
Lui le allungò la scatola dei biscotti, aveva della marmellata da qualche parte, lei disse che non importava. Lui scosse la testa:
“Ne abbiamo parlato molto, anche con gli altri. Ma non so cosa risponderti, dicono che è una questione di terminazioni nervose. Ma io poi penso: sentire che significa? Io so che la mia gamba c’era, e se lo so, la sento, ma non è che mi prude, o mi infastidisce, o che magari io creda di potermi appoggiare. Solo, non sta dove dovrebbe stare. Questo è il fatto. E siccome è la mia gamba, non ho altri posti dove cercarla.”
Bevvero il caffè e continuarono a parlare, era una bella giornata di primavera e un sole generoso illuminava la piccola cucina. Quando Benedetta salì in auto, lo salutò attraverso il finestrino. Stava in piedi sulla gamba sulla soglia e sventolò la stampella. Avevano una casetta con il giardino sul davanti e un cancello in legno verniciato di rosso, Benedetta si chiese se le rose che vedeva arrampicarsi lungo un graticcio appeso al muro fossero curate dalla moglie di Galizio o da lui, e lo immaginò ciondolare con l’irrigatore nella mano e le salì un sorriso. Era andata a trovarlo per avere una risposta. Aveva pensato che strappare la parola a Giuseppe fosse come amputare la gamba a Galizio. Ma non era così. Strappare la parola di Giuseppe a lei era come amputare la gamba a Galizio.
La Dissecazione della carotide generò un groviglio di serpi nel nido in cui si producono i concetti.
Mammamamma
Minchia
Dellacasa
e, una volta, Mannaggiaiddio
fu tutto ciò che Giuseppe disse durante i mesi di ricovero.
Benedetta disse a Marco “mi sento come se mi avessero amputato una gamba.”
Marco fu attratto dal nugolo di serpi e propose a Giulia di cercare un modo per dirlo: “Immaginiamo” disse “immaginiamo il punto esatto in cui il linguaggio nasce, o arriva, nella testa di un uomo. Proviamo a dirlo. Come potrebbe essere?”
Immaginarono un pozzo, un gorgo, un vortice inesauribile.
Il nastro trasportatore di un aeroporto.
Una nube carica di pioggia.
La pioggia.
Il cielo stellato che videro una volta assieme.
Un forno, un forno gigantesco costruito in pietra, in acciaio, costruito in ghisa.
Un deserto di sabbia, e la sabbia che si muove nel vento.
Videro anche una serra colma di piante gocciolanti rugiada all’alba.
Secchi calati nel pozzo che avevano immaginato.
Mani nel forno.
Mostri marini.
Notti profonde.
Ma niente era abbastanza. Nulla dava la misura del luogo in cui si genera il linguaggio.
Il lessico medico non fu di aiuto. In quel poco che riuscirono a leggere dei referti, trovarono parole troppo esatte per poter essere anche vere:
NIHSS17
Opacizzazione del circolo intracranico anche controlateralmente.
Vascolarizzazione dell’arteria cerebrale di sinistra.
Grave afasia globale.
Obliterato seno costofrenico laterale di sinistra.
Alterazione iperintensa prevalentemente in T2
Continuarono, così, a immaginare il punto in cui si genera la parola “nella testa di un uomo” “nella testa di Giuseppe”, come un punto che intendevano vuoto, “un punto” disse Marco “con dentro del mistero.” Nei messaggi che si scambiavano lo scrivevano con la maiuscola: il Punto, come fosse un negozio, un’immobiliare, o un dio.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente