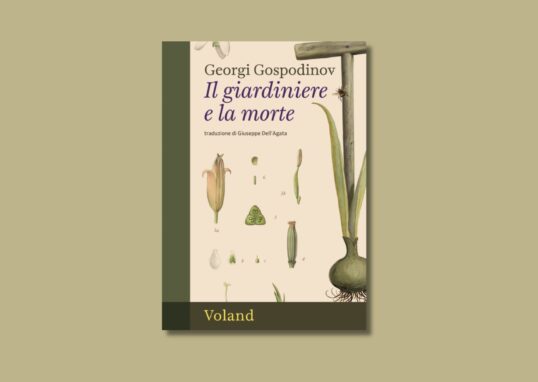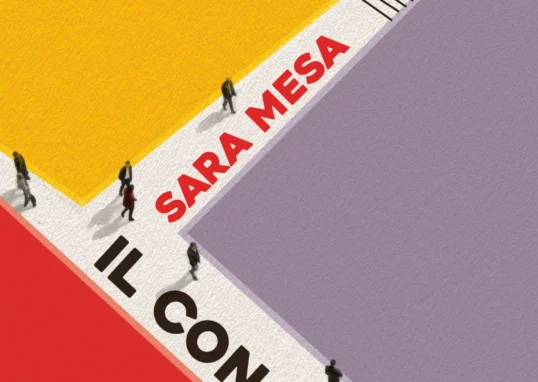Intervento per la Settimana del Libro Italiano, Istituto Italiano di cultura, Rabat 2024
Sono profondamente felice e onorato di essere qui con voi. Portiamo dentro ciò che amiamo ma è vero anche il contrario. Ci riflettevo più volte nelle occasioni passate in cui ho già visitato un paese e degli amici cui devo così tanto, a partire dalla precedente occasione in cui ho avuto il privilegio di -provare a- raccontare Dante Alighieri in alcune sfide e prospettive della letteratura contemporanea all’Istituto di Lingua Italiana di Rabat, in virtù dell’imprescindibile aiuto del prof. Nabil Meda, che fu così gentile da tradurmi in diretta con precisione scrupolosa e straordinaria competenza e con così poco preavviso. Fin nel Morocco e l’isola de sardi, per citare il canto di Ulisse, un verso che mi è tornato in mente più volte mentre guardavo il mare dalla costa ad Agadir, velato di nebbia all’orizzonte dove qualche nave transitava vaga come la sagoma d’ombra di un vascello fantasma, lo stesso di Ulisse magari, che avanzava lungo l’oceano dell’emisfero meridionale, ieri come oggi, traverso le nebbie del tempo.
Dove ti ho portato, Dante vuol sempre dire anche il suo opposto, Guarda dove mi hai portato tu, nella tua fedeltà alla mia vita come presenza costante. È proprio in lui che noi oggi ci incontriamo, nello spazio tracciato dalle sue parole, una casa che ci ospita, giacché come notava già Gian Battista Gelli nel Rinascimento “Non abbiamo un impero così grande che, come i Romani, muova le città soggette a cercare spontaneamente di parlare e onorare la favella di chi le comanda… ed è evidente che molte persone di un certo spirito, in Italia come altrove, si sforzano con molto studio di imparare e parlare quella nostra favella per nessun’altra ragione se non per amore.” Siamo tutti traduttori, conduttori elettrici di una forza che ci attraversa e che cambia mescolandosi alla nostra vita, alle emozioni, al ritmo del respiro. Così è dell’Italiano che condividiamo questa sera, restituito a vicenda. Nei versi del grande australiano Les Murray “Niente è detto finché non è tutto sognato in parole / E niente è vero che solo in parole consista.”
Premessa. Il libro che non si apre
Il problema è appunto come leggere le nostre vite. La sensazione persino dolorosa che il senso autentico vada ricercato tra le righe di quanto riusciamo a scorgervi, persino a contraddire quello che invece parrebbe il loro andamento palese. Neppure l’esplosione del rapporto singolo io-libro nello sconfinamento delle parole dell’era digitale annulla interamente questa tensione sottostante, magari per i lunghi secoli di stratificazione psicologica che portiamo comunque in noi, semmai la spariglia. Come nella scena al pub dell’Ulisse di Joyce in cui Leopold Bloom tenta, come può, di ribattere ai sogni nazionalistici di rivincita dei suoi compari irlandesi, la cui mitologia suprematista partecipa in fondo delle medesime violenze dell’Impero Britannico che li opprime politicamente e socialmente. “Sto parlando dell’ingiustizia, dice Bloom.–Giusto, dice John Wyse. Ma allora opponetevi con la forza, da uomini.[…]–Ma non val la pena, dice. La forza, l’odio, la storia, tutto. Non è vita questa per degli uomini e delle donne, odio e insulti. E tutti sanno che è precisamente il contrario di quel che veramente è la vita.–Cosa? dice Alf.–L’amore, dice Bloom. Voglio dire il contrario dell’odio.”
È uno struggimento frustato, l’esperienza comunque vissuta, patita, e l’incapacità a coglierne compiutamente il significato. Uno dei testi cardine dell’immaginario europeo-occidentale e certamente anche di quello dantesco, ossia l’Apocalisse di Giovanni, lo esprime in questi termini tanto individuali, personalistici, che collettivi. “E vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?». Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo.” Il rotolo sembra restare chiuso, e si piange. Potersi leggere, sapere cosa ne sarà di noi, qual è il significato della mia vita, ossia della mia storia particolare. È il desiderio di un senso complessivo, una lettura integrale, appunto, dell’esistenza che invece costituisce un flusso che si estende e prosegue via via che la vicenda si dipana, aggiungendo verbi, situazioni, paragrafi, virgole, accapo, fino al punto finale oltre il quale lo spazio torna bianco. Il privilegio accordato a ogni libro è che invece resta possibile concluderlo senza che questo implichi la fine della nostra stessa esistenza.
Attraversiamo una intera dinamica narrativa, viviamo tutta una vita, moriamo coi protagonisti restando appunto vivi, gettando uno sguardo comprensivo alla vicenda, una luce che la investe dall’inizio alla fine. Una facoltà che-quanto spesso- vorremmo poter applicare alla nostra stessa vicenda e alle progressive riscritture cui la sottoponiamo via via che nuovi eventi e decisioni si aggiungono ai precedenti fino al punto che viene apposto quando forse non saremo più in grado di leggerla, e quindi interpretare la parabola del nostro significato, del nostro telos, o destino. Il testo scritto e nello specifico il testo scritto di matrice narrativa, prosa o poesia che sia, ha da sempre costituito ben più che una metafora dell’esistenza umana ma una sorta di ipotesi-specchio, microcosmo e microanima al tempo stesso. Ovviamente è impossibile qui ripercorrere l’intero orizzonte immaginativo del libro e come le sue trasformazioni da rotolo a volume abbiano influenzato la psicologia della cultura occidentale e non solo, in passaggi salienti come le opere di Platone, le Confessioni di Agostino o Rousseau, l’opera filologica degli alessandrini su Omero o la Vulgata della Bibbia e poi le edizioni a stampa delle traduzioni di Erasmo o Lutero. Non si possono segnare tracce in quello che, più che un sentiero nel bosco, è un vasto manto di neve onnipresente, o più ancora l’ossigeno respirato in una biosfera.
Mi limito qui a ricordare, tra i tanti studi, Eros il dolceamaro di Anne Carson per la sua capacità di palesare il processo- in parallelo al diffondersi della cultura scritta- di una altrettanto specifica individuazione o messa a fuoco, la delimitazione ed esaltazione dei sentimenti medesimi per come vengono espressi per mezzo dei caratteri alfabetici, una rivoluzione psicologica dalla portata immane. Da prodotto secondario- ancora nella cultura greca platonica e aristotelica- il testo scritto assurge così nella cultura tardo antica e poi medievale e moderna a immagine primaria del senso e della verità, colta sebbene non intrappolata, forse. Tutto questo conduce a quel “simbolismo del libro” di cui scrisse Guido Mazzoni e che già per E. R Curtius ha svolto “un ruolo spirituale essenziale” nella cultura almeno fino al ventesimo secolo. Non è certamente un caso che la Commedia di Dante prenda le mosse proprio da una perifrasi -Nel mezzo del cammin…- e con una perifrasi si concluda- L’Amor che move- in coincidenza col tipo di viaggio percorso dal poeta pellegrino medesimo, un “altro viaggio” rispetto al tentativo iniziale di scalare verticalmente la collina del sole per sfuggire alla selva oscura e alle tre fiere. L’intuizione pura, sganciata dal tempo e dallo spazio, sostituita dal movimento circolare, perifrastico appunto, che comprende tutto il prisma dell’esperienza umana, che va interrogata, auscultata, assunta e riportata come testimonianza. Pronunziata, ascoltata, scritta e letta.
I. Il libro che si scrive mentre lo si scrive
È altrettanto impossibile tratteggiare tutti i volumi, ossia i libri, citati nella sola Commedia. Menzionati espressamente, variati nelle scene e espressioni riprese nelle metafore. Quella che si dispiega davanti a noi è la cultura europea intera, e oltre. Basti pensare- come ha giustamente fatto notare Riccardo Bruscagli- ai Sapienti che compaiono nel Cielo del Sole: Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Graziano, Pietro Lombardo, Paolo Orosio, Sigieri di Brabante, Salomone, Dionigi L’Areopagita, Boezio, Isidoro, Beda, Riccardo di San Vittore, ossia vari Italiani, uno Svevo, un Ebreo, un Greco, Spagnolo, Inglese, due Scozzesi, un Belga. L’Europa appunto, ma nel Limbo assieme ai grandi poeti e filosofi classici troviamo anche i sapienti musulmani Avicenna e Averroé. Tuttavia un elemento più originario ancora è che la Commedia stessa è anzitutto un oggetto concreto che si sviluppa via via e al cui realizzarsi assistiamo, chiamati in causa.
Com’io divenni allor gelato e fioco,
nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,
però ch’ogne parlar sarebbe poco.
Dante ce ne fornisce persino la ricaduta psicosomatica sul suo stesso corpo, che si assottiglia e ingrigisce man mano che le pagine si riempiono di correzioni e aggiunte. Il prezzo che uno stato eccezionale chiede per essere incanalato in una scansione ordinaria di giorni e ore.
Se mai continga che ’l poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m’ha fatto per molti anni macro.
Tuttavia persino un simile procedimento “in presa diretta” partecipa di una più ampia operazione ancora, quella basilare della memoria. E questa la fondamentale pagina bianca su cui si stendono i caratteri dell’esperienza nel suo svolgersi.
“In quella parte del libro de la mia memoria, dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice: “Incipit vita nova“. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d’asemplare in questo libello; e se non tutte, almeno la loro sentenzia.”
E’ il primo paragrafo della Vita Nova, e insieme già una dichiarazione di poetica. Ogni testo delimitato si rivela così una traduzione, una trascrizione di un altro libro ancora, ossia quella che Dante chiama la “mente profonda.” L’esperienza stessa nella sua intensità somma, lo “spirare” di Amore, e la sua resa in poesia vengono espresse nei termini di una dettatura scolastica, come negli scriptoria o in università.
E io a lui: «I’ mi son un che,
quando Amor mi spira, noto,
e a quel modo ch’e’ ditta
dentro vo significando».
Scrivere vuol dire dunque tenersi il più possibile “Stretti al dittatore”, e il fissaggio su carta e in parola di ciò che potrebbe parere così effimero come il momento vissuto, l’emozione ricordata costituisce anche un esercizio interpretativo, un tentativo di penetrarne l’ambiguità. Secondo una analoga riflessione di C. S. Lewis sul potere della memoria di resuscitare il passato, “Ciò che è stato seminato nel momentaneo viene innalzato nel permanente. Ciò che è stato seminato come un divenire sorge come essere. Seminato nella soggettività, si eleva nell’oggettività. Il segreto transitorio… adesso è un accordo nella musica definitiva.” È la stessa prospettiva a cannocchiale rovesciato, ravvisata da T. S. Eliot: “L’atteggiamento di Dante nei confronti dell’esperienza fondamentale della Vita Nuova può essere compreso solo abituandoci a trovare un senso nelle cause finali piuttosto che nelle origini. Non si tratta, a mio avviso, di una descrizione di ciò che egli provò consapevolmente al momento dell’incontro con Beatrice, ma piuttosto di una descrizione di ciò che ciò significò al momento della riflessione matura su di esso.” Tutti questi elementi, la forza primigenia della vocazione artistica e profetica quale ispirazione delle Muse, ossia d’una interpretazione del rapporto col mondo e il trascendente come accoglienza e restituzione che si incarna nel ritmo stesso del respiro-e il contributo della memoria che trattiene ed esprime quanto ricevuto, mettendolo a fuoco come comprensione autentica ed espressione verbale, si fonde nell’altra dichiarazione programmatica, il proemio “spostato” al Canto II dell’Inferno:
O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate
II. Il libro come zattera, mano tesa
Come notava Szymborska, si scrivere poesia per stringere una mano a un ragazzo tra quattrocento anni. Così le nostre parole viaggiano non solo nello spazio-come le mie adesso- ma nel tempo. Persistono nell’incontro possibile. Finché qualcuno non tende a sua volta la mano e le due si stringono. È questo che Dante testimonia con una intensità e una audacia mai raggiunta prima né dopo, perché qualsiasi variante su tale esperienza comunque continua a rifarsi alla sua, nell’aver eletto Virgilio quale sua guida per le prime due Cantiche, un pagano dal quale lo distanziavano il doppio dei secoli che intercorrono tra Dante stesso e noi oggi. Un pagano, sommo rappresentante di quell’intero mondo altro rispetto alla sua cultura e teologia per il quale egli inventa un Limbo che non comprende unicamente i bambini non battezzati ma tutta la scienza e l’arte dell’antichità e anche rappresentanti culturali e politici dei mondi altri rispetto al suo medesimo presente, come i già citati Avicenna e Averroè e il cortese Saladino, creando per essi uno spazio a suo modo autonomo, un tributo necessario dalle coinvolte e interrogative implicazioni universali. Pagano, antico ma soprattutto e fondamentalmente poeta, il “suo” poeta per il quale egli inaugura quella cascata di possessivi e pronomi così intensi che costellano il dipanarsi dei dialoghi e delle interazioni della Commedia, il primo fondamentale “tu” del poema. Ci sono luoghi dentro di noi, regioni di dolore e domande e struggimenti, dove autentica compagnia può esserci fatta talvolta solo da chi abbiamo incontrato in una pagina scritta, quanto remota negli anni e nella geografia. Un’amicizia che si esprime nella ricerca concreta di quel ponte che è il testo medesimo nel quale portare avanti la conversazione silenziosa con chi non ci ha conosciuto mai e invece sentiamo che ci ha visti ed espressi, consegnandoci parole e immagini come ipotesi per camminare nella nostra vicenda e leggerla a sua volta.
“O de li altri poeti onore e lume,
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ ha fatto onore.
Il volume cercato. Cercare, cosa vuol dire. Tanto la prima volta che si è andati a ottenere consultare farsi imprestare il testo mai letto per intero, ancora, incontrandolo per la prima volta, per curiosità, reverenza, presentimento che le infinite volte in cui lo si è ri-cercato, si è tornati ad esso ancora e ancora. Come avrebbe scritto C. S. Lewis, Un piacere è un piacere completo solo nel ricordo. Quello che tu chiami ricordo è l’ultima parte del piacere, come il crah è l’ultima parte di una poesia. Quando noi due ci siamo incontrati, l’incontro, in sé, è durato un attimo, è stato un nulla. Ora, nel nostro ricordo, sta diventando qualcosa. Ma noi ne sappiamo ancora pochissimo. Quello che sarà nel mio ricordo il giorno in cui io mi stenderò a terra per morire, e quello che opera e opererà dentro di me ogni giorno fino ad allora, questo è il vero incontro.
III. La lettura interrotta
Jeanne Winterson fu scoperta da sua madre a leggere un libro proibito. Nella fattispecie era Donne e amanti di D. H. Lawrence, tuttavia la censura della genitrice era ben più estesa rispetto a quell’autore notoriamente scandaloso. “Aveva semplicemente barricato i libri fuori dalla sua vita, ed essi dovevano essere barricati fuori dalle nostre vite. E quando le si chiedeva di giustificarsi, diceva sempre: “Il problema di un libro è che non sai mai cosa c’è dentro finché non è troppo tardi”. È proprio vero.” Potrebbero ripeterlo anche Paolo e Francesca, e in fin dei conti è proprio questo che Dante fa loro raccontare, lei narrandolo e lui piangendo. Secoli prima di Don Chisciotte, sono loro i primi tragici cosplayers, se si vuole, della storia letteraria. I primi a far traboccare nel mondo primario quanto incontrato in quello secondario della finzione. Nel Canto V il libro svolge ben più che la funzione di ponte o specchio rivelatore, ma di vero e proprio terzo personaggio in scena, Galeotto come il mediatore del corteggiamento nell’originale cortese, è in esso e tramite esso che i due scoprono di essere innamorati. Il libro spinge gli occhi, fa impallidire le guance, costringe fisicamente a compiere questo, quel gesto, è esso stesso un agente sotto copertura del potere che tende una trappola insospettata e al quale non ci si può vuole sottrarre.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante.
Lo sfumato dell’ultimo verso, la dissolvenza sulla passione cui i due si abbandonano per non uscirne più, coincide anche con l’interruzione della lettura stessa come atto di scelta dalle conseguenze drammatiche, specchio variato a sua volta delle implicazioni catastrofiche che il bacio aveva comprtato per i due protagonisti del romanzo di bretagna. Nel ciclo arturiano, in seguito allo scatenarsi della guerra e della fine della Tavola Rotonda, i due amanti si ritireranno rispettivamente in convento, ad espiare, suggellando quell’amore così sublime e peccaminoso con un gesto di rilettura finale, purificazione se non rigetto. Tuttavia un libro si può chiudere anche prima di averlo concluso, decidendo cosa non leggervi.
IV. Il libro da chiosare, il libro da salvare
“Se fosse tutto pieno il mio dimando”,
rispuos’io lui, “voi non sareste ancora
de l’umana natura posto in bando;
ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
la cara e buona imagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora
m’insegnavate come l’uom s’etterna:
e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo
convien che ne la mia lingua si scerna.
L’immagine buona e cara. Imago parentis, come l’Anchise che, rammentato da Enea, lo strappa dalle fiamme, lo sprona a proseguire. Brunetto Latini è stato il padre-mentore che ha accompagnato concretamente la formazione e crescita di Dante. camminando insieme, conversando, guardandolo parlare, sentendosi ascoltare, per le vie di Firenze. È anche l’unico al quale egli si rivolge pure all’Inferno con l’appellativo Ser, e per il quale esprime con strazio il desiderio che l’altro, omosessuale, non sia bandito dall’umana natura, privato della vita e della salvezza eterna. Come poteva un simile incontro tra scrittori, gli ultimi consigli del vecchio maestro, il tributo del pupillo, non esprimersi nel linguaggio della scrittura medesima e della glossa, dettatura e appunto, affiancando un libro, quello dei pensieri raccolti e custoditi, a un altro, l’incontro con la stessa Beatrice ritrovata che diventa in questo caso l’integrazione necessaria al primo, disposta accanto sullo scriptorium, come nelle summae medievali basate sul Videtur quod, Sed Contram, Respondeo Dicendum, che appunto non nega il precedente ma lo inscrive in una dinamica di comprensione e rilettura più ampia ancora.
Ciò che narrate di mio corso scrivo,
e serbolo a chiosar con altro testo
a donna che saprà, s’a lei arrivo.
E come sopravvive, in una prospettiva puramente secolare, un umanista? L’eternarsi comunque ottenuto, diverso dalla salvezza metafisica, consegnato alla cura del figlio-discepolo prima di sparire nella tempesta di sabbia. Quale può essere, cosa si può chiedere al futuro ricorrendo al passato. Ancora una volta, condensandolo in soli due versi, Dante già esprime quello che sarà continuamente pensato, espresso, comunque sentito presentito da generazioni di creativi incapaci magari di affidarsi a un credo diverso. Dove si sopravvive. Nell’arte medesima, incarnata in una realtà finita, concreta che si può indicare come a dire Ecco io sono lì… Si fanno libri o figli, avrebbe dichiarato Nietzsche ma è proprio a questo figlio che si paragona a un libro che si copre di scrittura per le parole del maestro venerato che questi affida il libro- che già nel titolo consente un gioco di parole addirittura evangelico- Laddove sarà il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore– come un figlio da accompagnare e proteggere.
Sieti raccomandato il mio Tesoro,
nel qual io vivo ancora, e più non cheggio
V. Il libro riletto
I libri si rileggono, caricandoli di significati ulteriori, riscrivendoli a un certo livello a seconda di ciò che vi immettiamo della nostra vita e di cosa è cambiato in essa. I libri si interrogano con lenti nuove a seconda di proprio ciò che ci è occorso, in essi e al di là di essi. Lo si fa individualmente e lo fanno intere civiltà. I passi nuovi sono compiuti sulla spinta dei passi precedenti, persino non nostri, spinti comunque da essi. È anche questo che avviene in una delle metascene più importanti e commoventi della Commedia, l’incontro con Stazio sulle pendici del Purgatorio, dove il poeta tardo antico espia e si purifica in virtù di una fede cristiana che egli ha scoperto in sé proprio leggendo quel Virgilio pagano che adesso gli è dinanzi e per il quale si butta grato oltre ogni dire in ginocchio.
qual sole o quai candele
ti stenebraron sì, che tu drizzasti
poscia di retro al pescator le vele?”.
Ed elli a lui: “Tu prima m’invïasti
verso Parnaso a ber ne le sue grotte,
e prima appresso Dio m’alluminasti.
Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte,
VI. Il libro volto
Per Dante Dio ha/è un libro. Ha un libro perché Egli possiede già l’intera conoscenza degli eventi passati presenti e futuri, e li giudica, ossia li vede per quello che sono, espone alla luce della sua verità ultima. Qualcuno sa. Non importa quanto oscure siano le circostanze, quanto il potere e la violenza nascondano le tracce delle loro forzature e menzogne, non importa che agli occhi dei più il prestigio, l’onore e la vittoria vedano apparentemente e così facilmente trionfare-ieri come oggi- il cinismo, l’ottusità, la sopraffazione e lo scherno. La parola profetica, come in Isaia, attinge come può a quella Fonte ultima, ne coglie qualcosa che ci giunge al tempo stesso dal passato e dal futuro assieme, nessuno dei due sarebbe bastevole in sé.
Che poran dir li Perse a’ vostri regi,
come vedranno quel volume aperto
nel qual si scrivon tutti suoi dispregi?
Qualcuno sa, e scrive- ossia conserva e intrepreta assieme- con una definitività che un giorno sarà fatta chiara a tutti, che è possibile intravedere laddove ci si sforzi a distinguere non ciò che è visibile, rilevante, influente, ma autorevole.
Grato e lontano digiuno,
tratto leggendo del magno volume
du’ non si muta mai bianco né bruno,
solvuto hai.
Ma Dio è anche un libro, se così si può dire. Perché è proprio la struttura fisica del volumen che permette di esprimere la consistenza in Lui di tutti i fenomeni del cosmo, che ci circondano e assediano in una cascata e alternanza che pare persino contradditoria. Ciò che pare stabile e ciò che invece si spegne effimero, ciò che cresce e ciò che avvizzisce. Una coesistenza che affatica gli occhi come un testo scrutato troppo a lungo e con troppa intensità alla fioca luce di una lampada.
Oh abbondante grazia ond’ io presunsi
ficcar lo viso per la luce etterna,
tanto che la veduta vi consunsi!
Nel suo profondo vidi che s’interna,
legato con amore in un volume,
ciò che per l’universo si squaderna.
Sembra che non vi si centro forse perché ciascuna realtà è al centro, non importa quanto vistosa o minuta, giacché il collante qui, come per la rilegatura dei codici, è l’amore. Che muove e lega insieme, come sa chiunque abbia provato passione per qualcosa o qualcuno. Solo che qui il legame è universale, collettivo, comunitario, getta ponti tra fenomeni e momenti che parrebbero così disparati, contradditori persino, e che invece si dispiegano quali passaggi di un unico flusso narrativo, di una unica immaginazione all’opera che li comprende e supera con una intenzione attiva. La più individuale e personale delle esperienze proiettata a comprendere la pulsazione dell’arteria e le galassie. Per una volta l’apparenza corrisponde al vero, tutto è importante, tutto è centrale. L’amore crea e continua a creare, è un verbo dall’azione in perenne svolgimento.
Chiunque si sia cimentato in un tentativo espressivo- io posso riferirmi, si quid est, come Dante, alla dimensione artistica perché essa costituisce la mia tinta, la mia finestra di affaccio sul mondo-coglie qualcosa di questa vita della mente, di questo alimentarsi silenzioso di realtà che sorgono in noi e alle quali si dedica una attenzione segreta o palese, comunque bruciante che le tiene su, torna ad esse, le fa riemergere dal buio nulla in cui altrimenti ricadrebbero. Per Dante Dio stesso non fa altro che crearci, a un livello di intensità costante che ce lo fa scambiare per Sua assenza, vuoto, e ci conferisce persino quel grado di libertà sufficiente a rifiutarlo o misconoscerLo, se vogliamo.
Personaggi concepiti liberi perché ciò comunque esprime e collabora all’ultima finalità dell’opera stessa, senza che lo sguardo del creatore si distacchi mai da essi. Noi contemplano il cielo notturno e vi pronunciamo promesse di fedeltà e amore alla luce di stelle spente da milioni di anni, come sigarette fumate da amici lontani coi quali scambiamo quattro parole fuori di un caffè, lo stesso calore del sole e la luce che ci fascia adesso che diciamo queste parole ci giunge in ritardo. Siamo accolti ina storia le cui conseguenze e ricadute sono sempre più vaste dell’immediato. Così di ciò che riceviamo in essa, così di ciò che vi aggiungiamo noi stessi.
La forma universal di questo nodo
credo ch’i’ vidi, perché più di largo,
dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.
È una diagnosi a posteriori dalle implicazioni per me vertiginose, se ci soffermiamo a rifletterci, al cui centro esatto sta un credo dove forse la rocciosità del convincimento e lo sfumato del soggettivo non si escludono. Credo che cosa. Di aver visto ciò che tiene assieme quanto incontriamo nella vita perché dicendolo, semplicemente dicendolo, godo. È davvero così anche per noi? Possiamo davvero fidarci che qualcosa sia vero perché dirlo, esprimerlo ci fa sentire profondamente bene, ci commuove? C’è questo potere di relazione tra ciò che diciamo e la verità per come ci è dato di sorprenderla? Immaginare qualcosa che non abbiamo visto ma che ci coinvolge profondamente, ci immette in una tensione profonda, comporta il sapere che quella realtà in qualche modo esiste davvero, proprio per lo spazio che suscita in noi e in cui consente alle nostre emozioni e ai nostri pensieri di muoversi?
C’è un ultimo passo, sempre che lo si possa definire tale. Al quale tutto approda e tutto riprende le mosse. Naturale e sconvolgente.
Dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.
Naturale a un certo livello, se si vuole, perché così credeva la teologia cristiana di Dante. Al centro della perfezione divina, colta in qualche misura nella luminosità di tre cerchi sovrapposti, cioè anche- impossibile a spiegarsi, un volto umano, quello di Cristo. Sconvolgente perché a suo modo ciò vuol dire che l’esperienza limitata e concreta viene assunta dall’eternità stessa. Il tempo e lo spazio non sono preparativi, introduzione a qualcos’altro, ma la condizione del comunicarsi di quella infinità profondità. Ma è la conclusione della terzina che deve catturare la nostra attenzione, specchiando il riflesso quasi inconscio di Dante medesimo.
Dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.
Viso qui è certamente lo sguardo, il visus latino, ma come non cogliervi tutta la voluta ambiguità con cui potrebbe intendere anche la parola faccia, volto? In questo apice di chiusura, tanto atteso, in questo tornado di luce dove le pagine sparse dell’universo si radunano in un unico in-folio, Dante si affissa con tutta l’intensità della sua attenzione su quel volto e, come sempre accade a indugiare su due occhi davanti a noi, si scopre che al centro della pupilla è il nostro stesso volto che incastonato nel nero ci fissa di rimando. Tutto questo può risultare molto lontano da noi, in un’epoca dove la fruizione dei testi e della scrittura si è spalancata in un multifaccia di stimoli e integrazioni, l’interconnessione della rete che però, lo sappiamo già bene, non genera tanto ampliamento o penetrazione quanto un acuirsi ipertrofico della focalizzazione, uno sviluppo asimmetrico dell’emisfero sinistro che gena rigidità conoscitiva, superficialità, tensione perenne, distrazione.
Per Dante invece, e la cultura che egli ci offre in lascito, leggere è sentirsi letti, ossia visti. Concentrazione e allargamento insieme. Solo così è possibile davvero leggersi a nostra volta. Quantomeno questo è quello che Dante stesso ci suggerisce di cogliere al centro di ogni esperienza pura, dove tutto ciò che è stato e quello che sarà ma ancora non sappiamo, il sentito e il presentito e perfino l’irrisolto o il non ricordato è comunque iscritto in una cadenza di senso ultimo, ha valore. In una storia scritta, raccontata, tutto conta, dai passaggi impressi nella memoria alle virgole, fino all’inconcepibile punto finale, per noi, che vorremmo fosse compreso negli occhi di chi ancora si sofferma sul primo paragrafo, come a noi è concesso solo quando abbiamo ultimato l’ultima frase e solo allora leggiamo davvero l’inizio e tutto ciò che c’è in mezzo.
Edoardo Rialti scrive per “L’Indiscreto” e “Il Foglio”. È traduttore per Mondadori delle opere di R. K. Morgan, G. R. R. Martin, J. Abercrombie. Ha curato opere di Shakespeare, Wilde, C. S. Lewis. È autore delle biografie letterarie di C. Hitchens e J. R. R. Tolkien.