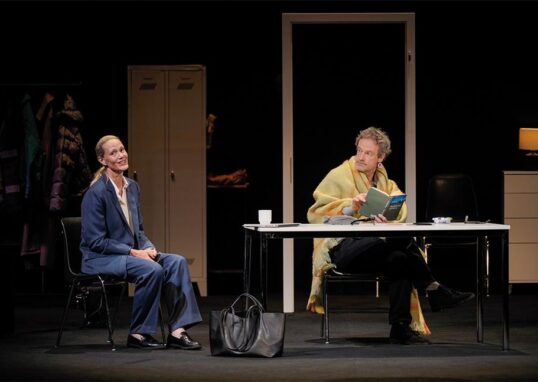Con “La valigia dell’autore” proviamo a creare un racconto e una mappatura della scrittura per il teatro in italia. Drammaturghe e drammaturghi italiani di questo primo quarto di XXI secolo si raccontano, riflettendo attorno al metodo, agli incontri essenziali, all’immaginario che hanno plasmato sul palcoscenico (G.G.).
Puntata n°3 – Sedici domande a Letizia Russo, drammaturga dalla voce affilata ed eclettica, vincitrice di alcuni dei principali riconoscimenti italiani legati alla drammaturgia. Ha iniziato a scrivere giovanissima, forgiando la propria scrittura anche grazie ad esperienze in Inghilterra, il Portogallo e in Brasile. Autrice di testi come “Tomba di cani” e “Binario Morto”, pubblicati da UbuLibri, e riscritture come “Ivan” e “Il maestro e Margherita”, pubblicati dalle edizioni del Morlacchi.
Dove nasce la prima scintilla della tua scrittura teatrale, l’idea di partenza e l’incipit: in sala o sulla scrivania?
Mi sembra che la domanda si riferisca a tre tipi di idee diverse. La prima scintilla, di solito, per me si accende in luoghi che non hanno nulla a che fare né con la scrivania né con la sala. Mi succede soprattutto camminando. Non importa dove, può essere una periferia o una spiaggia, una città nota o un paese diverso, un luogo bello o brutto. Credo dipenda da quello stato di mezzo che è il camminare: il corpo è in allerta, mentre la mente è distratta. Questa, per me, è la condizione migliore per lasciare che una prima scintilla si accenda, o arrivi da chissà dove. Quello che succede poi è che quella prima scintilla raramente sopravvive al tempo più o meno lungo della camminata. A volte resiste per un giorno intero, e poi scompare. Altre, raramente, dopo una settimana è ancora lì. Questo di solito per me è il segno che è un’idea che merita di essere ascoltata, e messa sul banco di lavoro. E il mio banco di lavoro è, appunto, la scrivania. Pian piano, pensando ma anche non pensando, arrivo a un’idea che non è più primordiale. I contorni si fanno più chiari, così come le possibilità di sviluppo. È un lavoro lento, dove la razionalità aiuta ma non basta, e dove l’istinto collabora perché è l’unico vero arbitro attendibile. L’incipit, la prima parola, o la prima immagine, di solito arrivano per ultimi, quando ormai sono abbastanza sicura di quello che sto raccontando. Poi c’è l’ultimo degli inizi, che è anche quello che amo di più: l’arrivo alle prove. Lì per me si apre un altro mondo. Anzi, diversi altri mondi. Cucire pian piano il testo addosso agli attori, riflettere insieme alla regia, difendere, aprire, rinunciare, e tutti insieme raggiungere strato per strato una storia condivisa.
Come funziona la parte di scrittura in solitaria? Dove scrivi? Quante ore al giorno? Hai una routine?
Scrivo principalmente a casa. Si dice che chi scrive ha la fortuna di poterlo fare ovunque, ma per quanto mi riguarda questo è vero solo in parte. Riesco a scrivere in altri luoghi solo quando ho tempo a sufficienza per considerarli casa, anche se temporaneamente. Bar, stazioni, aeroporti, parchi non sono luoghi in cui riesco a scrivere. Mi appassionano come punti di osservazione, come luoghi in cui assistere alla vita mentre si svolge nei suoi conflitti e nelle sue imprevedibilità. Ho bisogno di solitudine per scrivere, e anche di silenzio, e l’isolamento in mezzo ad altre persone non è vera solitudine. Ecco perché scrivo bene a casa. Di solito riesco a scrivere tre giorni di seguito con un giorno di pausa. Mentre mi è impossibile scrivere quattro, cinque, o sei giorni di seguito. Dopo tre, ho un giorno di vuoto, in cui so che è inutile insistere. Scrivo durante il giorno intero, ma la mattina è più fertile per le idee, e il pomeriggio per la scrittura vera e propria. Dal crepuscolo sento che tutto scorre in maniera più organica. Ma non sono mai riuscita a scrivere a notte fonda. So che ci sono alcuni gradini di stanchezza, nell’arco di una giornata, che è necessario superare, senza cedere alla voglia di mandare tutto all’aria, o, peggio, di rimandare al giorno dopo. Sono dei veri e propri scalini “di sfinimento”. Passato il primo, il secondo, il terzo, è come se una parete cadesse, e lasciasse a personaggi, circostanze e storia di camminare sulle proprie gambe. Poi ci sono giorni in cui nulla funziona, nulla si sblocca, nulla sembra aver senso. Allora so che è di nuovo arrivato il momento di camminare a lungo, senza la pretesa di risolvere niente.
Come funziona la revisione dei tuoi testi? Sono influenzati dal lavoro in sala? Riscrivi scene che vengono provate?
Non ho mai considerato un testo per il teatro come un manufatto narrativo che si chiude quando in fondo all’ultima pagina scrivo Sipario o Fine. Non c’è mai nulla di chiuso per me e quindi sì, quando ho la possibilità di lavorare con le compagnie, metto sempre mano al testo, se riconosco la sensatezza o la necessità di una modifica, o di un lavoro di cesello, o di ripensamento. Questo non significa che nel cento percento delle occasioni io riscriva in minima o in larga parte i testi. Ma cerco di trattarli come una materia viva, che trova la propria strada attraverso altri esseri viventi, e attraverso lo sguardo di chi si prende la responsabilità di avere una visione altra, registica, sul testo. Ho un profondo rispetto per il lavoro di chi sale sul palco, di chi si espone col proprio corpo per restituire qualcosa a un pubblico. Ma non sono nemmeno così ingenua da accettare qualsiasi opinione o richiesta esterna. Anzi, la difesa del testo (quando serve) è parte del processo stesso. Ed è fondamentale.
Carta o computer? Che differenza c’è per te? Il mezzo influenza la scrittura?
Uso sempre entrambi. Ma non è sempre stato così. Per molto tempo ho scritto solo a mano, per poi ricopiare al pc. La ricopiatura diventava una prima revisione, seguita da altre. Ora posso anche scrivere la parola numero uno su un file. Ma so che arriva sempre il momento in cui ho bisogno di scrivere a mano. Soprattutto per poter rileggere ciò che cancello. Tiro una riga su quello che escludo, ma quello che escludo rimane lì. E a volte, ritorna.
Hai dei rituali per la tua scrittura? Scaramanzie?
Prima di questa domanda non le avrei definite scaramanzie, ma a pensarci bene forse lo sono: il titolo del testo, sul frontespizio del file, lo scrivo solo alla fine. Mai prima. Mai. Ma non so perché. E quando scrivo a mano, uso dei quaderni a righe spessi, scrivo fitto, e non vado a capo se una battuta occupa solo una parte della riga. Scrivo in maiuscolo il nome dell’altro personaggio, e continuo sulla stessa riga. E via di seguito. Segno sempre il numero di pagina in fondo a destra nelle pagine di destra, e in fondo a sinistra nelle pagine di sinistra, ma solo quando ho riempito la pagina, mai prima. Uso solo la penna nera. Di solito è una penna a inchiostro liquido, non una biro, per intenderci, e sono un po’ contenta quando per sbaglio mi cade dell’acqua o del caffè sulle pagine scritte. Mi dirai: se l’inchiostro della pagina è liquido, si crea un disastro per pagine e pagine. Sì! Ma non è mai del tutto illeggibile.
Qual è il testo teatrale che nella tua carriera ha rappresentato il momento di svolta? E perché?
È stato Tomba di cani. Per diverse ragioni. Il Premio Tondelli è stato un ingresso per nulla scontato nel mondo del teatro, in anni in cui la drammaturgia italiana riceveva non solo attenzione, ma cura. Quel testo poi ha rappresentato per me un incontro molto importante: quello con Cristina Pezzoli. Lei, all’epoca, era direttrice del teatro di Pistoia e aveva deciso di incentrare la propria direzione proprio sulla drammaturgia italiana contemporanea. Io avevo visto da poco il suo spettacolo L’Annaspo e ne ero rimasta folgorata. Presi coraggio, e glielo mandai. Franco Quadri, che mi aveva dato il premio, non era d’accordo, per ragioni che non mi sono mai state chiare. Cristina decise di metterlo in scena. Isa Danieli era la protagonista. Alcune cose, di quella fine estate del 2002, non le dimenticherò mai. Il modo di Cristina di dirigere e il modo di tutto il cast, ma di Isa Danieli in particolare, di recitare. Quel teatro non c’entrava nulla con “l’esecuzione”, con la re-citazione di parole. Era più potente: accadeva. Era vivo. C’è stato un momento, durante le prove, in cui Isa Danieli ha detto una battuta, non ricordo quale. E io ho capito che non la stava dicendo, l’aveva “pensata”, l’aveva pensata come l’avrebbe pensata il personaggio, e quindi l’aveva detta perché era necessaria, inevitabile, autentica. Sono stata una persona fortunata.
A quale dei tuoi testi sei più affezionata? E perché?
Sono una “madre” degenere: non provo un attaccamento vero verso nulla di ciò che scrivo. È strano, ma quando tutto è finito (il testo, le prove, le repliche), per me tutto è davvero finito. Non vivo nella saudade dei testi. Spesso non ricordo di aver scritto delle battute, dei monologhi, dei personaggi, dei punti di trama. So che può sembrare un vezzo, ma non lo è. Mi affeziono molto di più ai periodi condivisi con le compagnie. Non tutte, ovviamente. E dopo tutti questi anni so che più che i singoli testi, provo affetto (se così si può dire) per un certo tipo di umanità, che è poi quello che più mi parla attraverso la scrittura. Un’umanità senza potere, imperfetta.
Quale dei tuoi lavori è stato il più difficile? E perché?
Anche a questa domanda darò una risposta che potrebbe sembrare vezzosa, ma che anche stavolta non lo è: il lavoro più difficile per me è sempre quello che sto affrontando. Scrivere significa anche, ogni volta, ricominciare un po’ daccapo. Vivere le stesse paure. Combattere per ogni dettaglio. Scoprire ogni volta che la soluzione a dei problemi è in un regno che sta a metà tra il controllo e lo s-controllo.
La tua scrittura e il tuo metodo sono cambiati nel tempo? Come?
Credo di aver acquisito, negli anni, un maggior controllo dell’immaginazione. Ora, a differenza del passato, credo di riuscire ad accedere con più velocità a un punto più profondo, a un bacino nascosto di immagini, sensazioni. Cose, non parole, che riguardano l’umano. Accedere, non necessariamente riuscire immediatamente a agganciare, trascinare verso la superficie, tradurre, plasmare. In alcuni aspetti (tematici, ad esempio) credo di aver percorso una strada che riconosco ancora come mia. Dal punto di vista del metodo, penso di essere cambiata solo nella gestione dell’ansia. Quello che prima mi appariva come una montagna impossibile da scalare, ora mi appare come una montagna “molto difficile” da scalare, ma non impossibile. Ho imparato a confidare nel tempo. Nella cura quotidiana. E anche nel confronto.
Cos’è per te oggi la drammaturgia? Di cosa deve occuparsi? Cosa la distingue dalla letteratura e dalla scrittura per il cinema?
Nel migliore dei mondi possibili, credo che la drammaturgia dovrebbe occuparsi dell’umano, e non del prodotto. Nel migliore dei mondi possibili, dovrebbe essere in grado di riunire una comunità attorno ai propri dilemmi. Dovrebbe essere in grado di riconoscere la tragedia del proprio tempo, confidando nella capacità del pubblico di esercitare il proprio pensiero, senza imporgliene uno, senza togliergliene un altro. Non credo che la drammaturgia debba salvare nessuno, né formarlo. Il mondo è in un momento di cambiamento profondo. Spirano venti di guerra, rivoluzioni tecnologiche corrono sotto i nostri occhi, e sarebbe — necessario? bello? non so – se il teatro, che è la più viva delle arti, ci mostrasse chi siamo, non chi dovremmo essere.
Mi chiedi cosa distingue il teatro dalla letteratura e dalla scrittura per il cinema. La differenza con la letteratura, per me, sta nella irriducibile apertura del teatro rispetto alla letteratura. Il testo di teatro è più simile a una persona. Non si esaurisce nella sua natura essenziale. Il testo teatrale è un essere a cui non basta l’anima per essere chi è. Quest’anima cambia natura, colore, senso, racconta cose diverse, a volte opposte a quello che dovrebbe raccontare, a volte non racconta nulla, proprio perché è aperto, misterioso, pieno di equivoci. Per quanto riguarda il cinema: non ho una lunga esperienza. Ho scritto finora un solo lungometraggio, che uscirà quest’anno, insieme a Pietro Marcello, che ne è regista, e Guido Silei. Quindi sono una neofita. Ma credo che nella scrittura per il cinema sia fondamentale “immaginare per sottrazione”. Se la scrittura per il teatro è corpo, conflitto, accadimento, quella del cinema è mistero, sottrazione, una lingua pre-razionale. Non so spiegarlo meglio di così, perché ci sto ancora riflettendo.
Quali sono i testi teatrali di “maestri” che ti hanno influenzato o che hai amato di più?
La tragedia greca per la poetica, Antonio Tarantino per la capacità di comprendere l’umanità. Mi hai chiesto i testi, lo so, la risposta è più aperta. Ma so che finché vivrò cercherò in queste due direzioni: la fondatezza e la dignità di tutte le posizioni, e comprensione delle piccole e grandi miserie umane.
Quali sono gli spettacoli importanti della tua vita di spettatrice?
Ce ne sono stati diversi, ma quello che ricordo come “un’esperienza” nel vero senso della parola, irripetibile da certi punti di vista è l’Adelchi di Carmelo Bene. Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Argentina l’8 ottobre del 1997. Io avevo sedici anni e una mamma che amava il teatro, e che mi portava a vedere spettacoli molto diversi ogni volta che poteva. Non so più se siamo andate alla prima, forse no, forse era una pomeridiana di domenica. Mi ricordo però che Bene si incazzò come una bestia per uno spettatore tossicchiante. E che non annullò la replica, anche se aveva minacciato di farlo, prima dell’inizio, in caso di rumori molesti. Dell’Adelchi manzoniano non ricordo niente. Ma per le tre notti successive mi sono svegliata seduta sul letto, nel mezzo di sogni febbrili in cui Bene era a casa mia e profetava cose tremende e profondissime sul destino dell’umanità. Sì, certo, avevo sedici anni, e si sa, l’adolescenza è una terra sconnessa, sismica. Ma mai più nulla mi ha provocato la sensazione di assistere a qualcosa di così profondamente sacro.
Cosa non deve mai fare un’autrice/autore teatrale?
Dimenticare che le persone escono di casa, faticano a cercare parcheggio, pagano un biglietto e prestano la loro attenzione per venire a vedere quello che raccontiamo.
Cosa non può mancare in un testo teatrale che consideri ben fatto?
Per me può mancare tutto: storia, personaggi, parola, relazione, conflitto. Tutto. Ma se manca l’onestà, l’autenticità, è senza futuro. Se è un gingillo per il proprio ego, è senza futuro. Se pensa di dover insegnare qualcosa, è senza futuro.
1Si può davvero insegnare a scrivere un testo teatrale? Fino a che punto?
No, non credo che si possa insegnare a scrivere un testo teatrale. Soprattutto perché è assurdo pensare che ci sia un modo giusto di scrivere. La scrittura per il teatro è una non-scienza, per di più inesatta. Ma è altrettanto vero che esistono alcune domande, alcuni punti di riflessione, e anche alcuni strumenti tremendamente artigianali che possono fare la differenza tra raccontare quello che si vuole e non riuscire a farlo. Come in ogni territorio di esplorazione umana, molto dipende da chi si è. Da che tipo di mondo o di visione si ha, a prescindere da quello che “si pensa”del mondo. E credo che, se è impossibile insegnare a scrivere un testo per il teatro, si può però cercare di trasmettere quello che serve per capire che la fantasia è il più potente strumento di conoscenza.
Vuoi aggiungere una tua riflessione?
No.
Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.