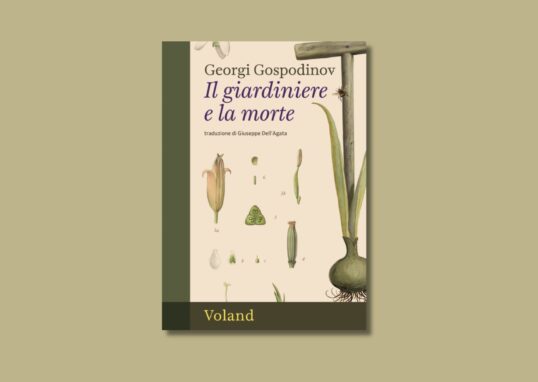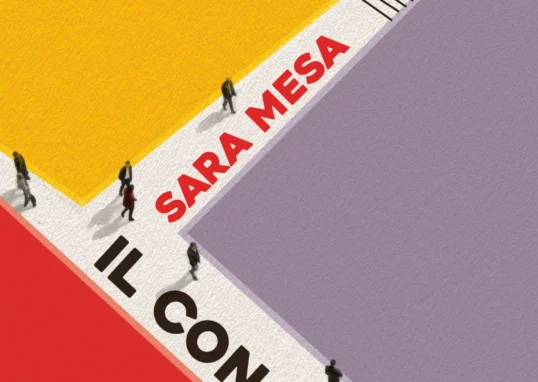Robert Walser ha a più riprese provato a rendere gli itinerari delle sue passeggiate luoghi di germinazioni immaginative, scartando dai reticoli dei sentieri per spostarsi in luoghi altri e diversi. E proprio lungo uno di questi percorsi il delirio che lo aveva abitato per circa trent’anni, il 25 dicembre del 1956, decise di farlo affondare definitivamente: chiuso nella clinica di Herisau fin dal 1933, dopo un soggiorno in un’altra clinica svizzera, l’ultima passeggiata della sua vita si chiuse con un infarto che lo fece accasciare al suolo, solo, tra la neve. Esiste una fotografia, scattata dalla polizia locale, che ritrae Walser senza vita con una parte del corpo ricoperta da un sottile strato di neve fresca: ciò che sorprende di questa immagine è lo spazio che separa gli ultimi passi di Walser dal suo corpo accasciato nella neve, come se, all’ultimo respiro della sua vita, il corpo, con la stessa leggerezza e grazia di cui è sempre stata testimonianza la sua opera, si sia librato in aria per un istante prima di, con una piroetta, stendersi al suolo.
Uno spazio bianco appunto, un vuoto tra la vita e la morte, lo stesso vuoto tra la vita e l’opera che Walser ha provato a riempire attraverso le vie dell’immaginazione. La creazione letteraria assume un valore magico ed evocatorio se per esempio si prendono in considerazione alcune pagine del romanzo I fratelli Tanner, pubblicato nel 1907, in cui viene descritto proprio un corpo senza vita immerso nella neve «morto assiderato, senza alcun dubbio, e doveva giacere lì da molto tempo, sul sentiero». Anche il corpo di Walser sarà ritrovato da due bambini curiosi di capire cos’era quella macchia che vedevano sulla neve. Carl Seelig, amico di Walser ma soprattutto compagno fedele delle sue passeggiate e suo erede letterario, non era con lui il giorno di Natale del 1956, ma descrisse comunque il momento fatale provando a renderne la suprema levità: «A un tratto, ecco il cuore del viandante comincia a interrompere il suo battito. La testa gli gira. È certamente un segno dell’arteriosclerosi da vecchiaia di cui una volta gli aveva parlato il medico, ammonendolo che deve saper usare prudenza nelle passeggiate. Cade di schianto di schiena, porta la mano destra al cuore e rimane immobile. L’immobilità della morte».
Le strade che Walser trasforma in prose tanto lucenti quanto tenui nel tono, simbolo dell’acquiescenza con cui lo scrittore ha deciso di vivere la propria vita e quindi di far respirare la propria opera, si nutrono anche di percorsi metaforici, che non prevedono un cammino fisico ma che segnano invece, in quella maniera sempre leggera di cui sono capaci gli uomini che osservano l’abisso senza venirne risucchiati, la singolarità e la ricerca di un’identità impossibile da stabilizzare. Adelphi pubblica adesso una nuova traduzione di L’assistente ad opera di Cesare De Marchi, romanzo del 1908 e perno centrale di quella trilogia berlinese che vede i capolavori assoluti I fratelli Tanner e Jakob Von Gunten: L’assistente racconta appunto la ricerca di se stesso, che vuol dire anche la rassegnazione a non conoscersi mai, di Joseph Marti, disoccupato che troverà impiego presso la villa di un ingegnere, Tobler, brillante e creativo ma ben poco aderente alla realtà («Un’idea deve trascinare, deve conquistare, altrimenti è ben difficile metterla in pratica» riflette Joseph pensando allo strambo orologio pubblicitario ideato da Tobler, che «ha il vantaggio di combinarsi con la réclame. D’altronde è per questo che è provvisto di un paio, semplice o doppio, di ali d’aquila in finto argento o oro da decorare. E con che altro lo si vorrà decorare se non con gli indirizzi precisi delle ditte che si avvarranno di quelle ali, o campi, come suona il termine tecnico, a scopo di inserzione pubblicitaria?»). In cambio di uno stipendio, che non vedrà mai, di vitto e alloggio, occasione per conoscere la famiglia dell’ingegnere, Joseph accetta di affiancare Tobler che proprio a causa del suo distacco da quelle che sono le dinamiche del mondo borghese, di cui comunque fa parte, scivola inesorabilmente verso il fallimento, in un naufragio che è quello di un’intera classe sociale che sognava un destino diverso, come lo stesso Tobler che considerava solo all’inizio la sua scalata con l’acquisto della grande villa dove vivrà, ospite, Joseph Marti.
La scena che racconta l’ultimo dialogo tra Joseph e Tobler è particolarmente interessante per comprendere il disfacimento dei sogni dell’ingegnere, epifenomeno di ben più ampia rovina, e lo stato d’animo di Joseph, che si erge a chiave universale esulando dall’episodio specifico del romanzo. Avendo capito di dover andare via, Joseph, che «non sapeva bene cosa diceva, aveva solo la precisa consapevolezza della fine», chiede a Tobler lo stipendio pattuito, richiesta che manda «fuori dalla grazia di Dio» il suo datore di lavoro: «Sommerse di insulti Joseph: dapprima violenti, poi sempre più deboli, finché il tono rabbioso si sciolse tutto in quello di un dolore lamentoso. Joseph era ancora lì. Gli pareva di dover avere pietà del mondo intero, un pochino anche di sé, ma soprattutto e profondamente di chi era intorno a lui». Si tratta di un riflessione sul rapporto tra l’uomo e il mondo che lo stesso Walser deve aver sentita sua anche per la rete autobiografica che avvolge questa narrazione. Seelig nelle sue Passeggiate con Robert Walser riporta che lo scrittore svizzero gli disse di come L’assistente fosse un romanzo assolutamente realistico: «Non ho dovuto inventare quasi nulla. La vita l’ha creato per me». E così l’assistente del titolo è Walser stesso che quando aveva poco più di vent’anni, tra il 1903 e il 1904, lavorò come impiegato nella villa di un ingegnere meccanico: c’è da immaginare che lo stesso stato d’animo evanescente del protagonista del romanzo, arrivato nella villa dopo l’indicazione dell’ufficio di collocamento, armato solo di pochi oggetti personali, fosse lo stesso di Walser. Così il saluto alla casa e l’orizzonte di una nuova ricerca rispecchia perfettamente lo sgretolamento che caratterizzerà le sue brevi prose successive, come il racconto La passeggiata che sarà pubblicato nel 1917 e che diventerà simbolo assoluto del movimento perpetuo walseriano e delle ricchezze continue e inaspettate che la visita casuale nel mondo può offrire.
«Lo scrivere è nato dallo scarabocchio e ad esso deve ritornare» scrive Roberto Calasso nello straordinario saggio, Il sonno del calligrafo, che chiude la traduzione italiana del romanzo di Walser Jakob von Gunten, suggerendo come la scrittura di Walser sia un continuo tentativo di andare fuori strada, di allontanarsi frettolosamente da «ogni senso nascosto o evidente», placandosi «solo nell’avvicinarsi alla quiete dell’insignificante». L’esperienza di Joseph Marti, che dà l’impressione di «non essere che un lembo, un’appendice fugace, un nodo stretto solo temporaneamente» o, ancora, «un bottone ciondolante che non ci si dà la briga di riattaccare, ben sapendo che la giacca non la si porterà più per molto tempo», segue un itinerario congeniale a questa continua deviazione della parola che costeggia, suggerisce e addomestica lo sgretolamento di ogni identità e individualità e che invita con naturalezza alla scomparsa.
Claudio Magris, proprio scrivendo a corredo dell’edizione Einaudi di L’assistente, ha sottolineato come «la disarticolazione della totalità e del grande stile classico» facciano bella mostra nelle pagine di Walser che in questo romanzo rovescia nella ricerca di Marti l’intera incertezza che segna l’uomo novecentesco e che si riverbera nella forma romanzesca. Il disfacimento della famiglia a cui assiste Joseph è allora lo specchio di una «disarmonia della vita», come la ha definita Claudio Magris, di cui Walser è stato il disincantato e acuto osservatore, continuatore del suo proposito di «scomparire il più discretamente possibile» credendo solo nell’azione salutare e immaginifica della passeggiata. La sua opera tutta è pervasa da questo voto al silenzio e allo scioglimento che si compie nell’immersione negli spazi che costellavano le sue passeggiate, come nota Joseph Marti nel romanzo riflettendo su quanto tutto, alla fine, rimandi al nulla e alla semplicità: «Tutto è possibile in questo mondo se ci si prende la briga e la passione di rifletterci un poco durante una passeggiata nei prati».
Matteo Moca è dottore di ricerca in italianistica e insegnante. Scrive, tra gli altri, per Il Tascabile, Il Foglio, Domani, L’indice dei libri del mese, Blow Up e il blog di Kobo. Ha pubblicato le monografie “Tra parola e silenzio. Landolfi, Perec, Beckett”, “Figure del surrealismo italiano. Savinio, Delfini, Landolfi” e “Un’esigenza di realtà. Anna Maria Ortese e la dipendenza dal fantastico”