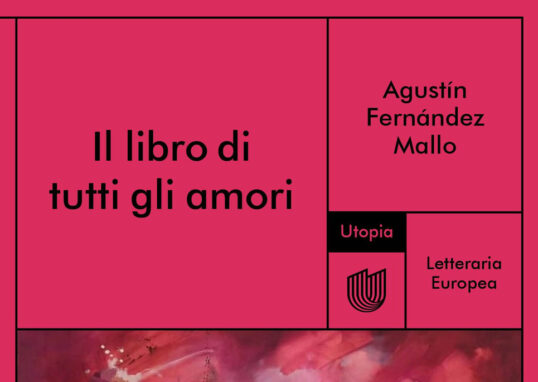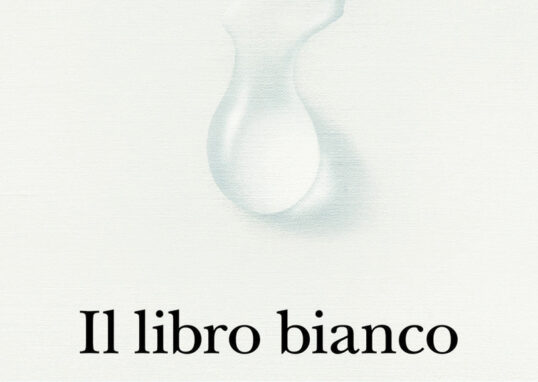Risale a più di settant’anni fa l’origine della vicenda editoriale de I frutti del Congo di Alexandre Vialatte, ritenuto tra i più grandi romanzi francesi del XX secolo. Nel 1951, dopo aver ottenuto il premio Charles Veillon e la pubblicazione per la prestigiosa casa editrice Gallimard, l’opera è candidata al Premio Goncourt, per poi essere scalzata da La riva delle Sirti. Il suo autore, Julien Gracq, rifiuta il premio, in aperta polemica verso i compromessi commerciali legati al mondo editoriale e ai riconoscimenti letterari, generando un acceso dibattito attorno a una circostanza mai occorsa sino a quel momento. Vialatte a sua volta esce profondamente segnato dall’episodio, e anche a causa dell’insuccesso commerciale del volume, non scriverà più altri romanzi.
La straordinaria originalità dell’opera scartata riguarda aspetti formali, stilistici, visioni, sovrapposizioni realistiche su scenari immaginifici. Arriva solo oggi al pubblico italiano (con la pregevole traduzione di Gabriella Bosco) a settantaquattro anni dalla sua prima uscita, grazie alla lungimiranza del progetto editoriale di Prehistorica. La natura eclettica e irriverente della prosa e la cura estrema rivolta alla parola derivano anche dal lavoro di Vialatte come traduttore. È sua la prima traduzione in francese di Kafka. Nel tempo si confronterà anche con le opere di Nietzsche, Goethe, von Hoffmannsthal, Mann, Brecht, che incideranno nella sua poetica. I frutti del Congo è il suo terzo romanzo, dopo l’esordio nel 1928 con Battling il tenebroso, seguito nel 1942 da Il Fedele Berger. La notorietà di Vialatte arriva con le Cronache dalla montagna: pubblicate con cadenza settimanale su “La Montagne”, indagano il senso del vivere attraverso un inno al disequilibrio, e rintracciano nel frammento il mezzo d’elezione per sondare gli enigmi del Novecento con una peculiare capacità di studiare la società e le sue deviazioni.
Definito un grande romanzo di avventure immaginate paragonato a Il grande Meaulnes di Henri Alain-Fournier, I frutti del Congo è un’ode alla poesia del quotidiano, attesta la possibilità di sperimentare la magia della giovinezza nel seguire le vicende di un gruppo di adolescenti in preda a manie, eccentricità, sogni, suggestioni amorose, nostalgie. Un piccolo centro dell’Alvernia diventa lo scenario ideale per narrare crimini inattesi, piccolezze, miserie umane, entro un reticolo urbano reso per epicentri nervosi: la piazza, il liceo, il mercato, la drogheria. In quest’ultimo luogo, nel solaio chiamato emblematicamente i “Piaceri di Corea”, tra specchi, lacca rossa e penombra cinese prendono forma leggende suggestive in un “mistero di miele e d’oro”. Nel rigore del collegio diretto dal bizzarro Monsieur Vantre – una sorta di satrapo soprannominato “Buffalo” – le vicende narrate ruotano attorno a un gruppo di studenti, teppisti, poeti, “tecnici del rancore e della grandiosità”.
Fantasticano su distese sconfinate al di là delle mura del collegio, affascinati dall’illustrazione dell’azienda internazionale di commercio di agrumi che ritrae un’incantevole donna circondata da limoni, simbolo della poesia dell’esistenza. Quell’immagine nasconde tuttavia qualcos’altro, è una pubblicità commerciale trasformata in un manifesto di reclutamento militare. Si tratta di un aspetto centrale perché legato a un’esperienza diretta vissuta dall’autore in un contesto diverso e già sviluppata in precedenza, attraverso un visionario esperimento letterario (Berger, il soldato fedele, trad. René Corona, Prehistorica) che descrive la percezione e il mancato riconoscimento di sé vissuti quando si deve affrontare una guerra.
L’immaginazione di quelle isole infeconde, piatte, nude, bianche, abbacinanti, desolate, considerate “fantasticherie sterili del sole sulla sabbia, un riverbero senza scopo”, traduce il lirismo delle dune, rappresenta l’amore per il deserto, per l’Estremo Oriente, per l’idea di un luogo esotico inaccessibile e inservibile. Le Isole devono il loro fascino anche alla riva che le fronteggia idealmente, che espone sobborghi in rovina dagli angoli lebbrosi e dai caffè abbandonati assimilabili al regno disabitato evocato da Verlaine nel sonetto sulla statua di Velléda “il cui gesso si sfalda all’inizio della via”. Quei luoghi fantastici incarnano il sublime irraggiungibile, la speranza vana, la suggestione, il sogno da preservare nella segreta consapevolezza della sua natura irrealizzabile, concepito sulla scorta dello studio di Baudelaire e Shakespeare.
Noi coltivavamo le stesse tristezze del re Giovanni. Nei sobborghi e nelle Isole conoscemmo cento modi di essere malinconici, cento modi di essere felici di malinconia, i cento contro-modi dell’amarezza.
In tale immaginario si rivela necessario eleggere l’emblema revisionato del canonico amore romantico (Dora); il custode di un segreto indicibile, cantastorie di sofferenze illustri (il cieco); la figura mitica e temibile, prodotto inquietante della penombra, capace di apparire “da vaghi rumori, da ricordi confusi e da necessità poetiche concentrate in una stampa inglese”(Monsieur Panado).
Il protagonista, Frédéric Lamourette, eletto re delle Isole, del Labirinto e del Mulino a Vento, cela un’inquietudine remota. La sua ricerca inesausta è resa nei disegni e nelle visioni, nell’anima di banchine interminabili e vuote, nei misteri celati nell’insegna di una fabbrica di mobili, nelle case piatte e nelle figure femminili sconosciute, associate a racconti di terrore. È stato accolto quando era ancora un bambino dall’eccentrico zio, il dottor Peyrolles, a cui finirà per somigliare per l’altezza e per le identiche “precipitazioni” che rompono “l’apatia generale del loro ritmo”. I due sembrano vasi comunicanti, condividono la medesima attitudine al mutismo, ai precetti d’igiene e all’umorismo concordato.
L’uno e l’altro mostravano lo stesso rilassamento dei pantaloni, la stessa resa dei calzini, lo stesso scoraggiamento della cravatta, le stesse calzature meravigliosamente cerate e gli stessi capelli a spazzola. Quei due uomini infatti erano tutti disordine e pulizia, naso immenso, peli duri, fibre e cartilagini.
Frédéric e il narratore si innamorano della giovane incontrata per caso, Dora, affascinati dal mistero che incarna. Un evento drammatico in circostanze anomale segnerà la fine di ogni fantasia, portando poi Frédéric alla decisione di arruolarsi, suggestionato dalla nota locandina.
La scelta di eleggere una figura inquietante che esiste unicamente nel terrore che genera al solo pensiero (Monsieur Panado), si inserisce in senso più ampio in un’analisi sulla necessità di crudeltà nell’infanzia, sull’aspirazione alla violenza del nulla incarnata da una figura inesistente a cui associare professioni disparate e apparizioni inattese. Quello spirito maligno capace di autorizzare “l’anarchia delle sue parole d’ordine”, si rivela uno dei volti del niente. L’autore si chiede se la sua esistenza sia solo in funzione della sua assenza, rimandando a questioni filosofiche affrontate da Nietzsche in particolare, e riprese a decenni di distanza da un altro grande autore francese, Èric Chevillard che con Dino Egger (trad. Gianmaria Finardi, Prehistorica editore, 2022) compie uno studio narrativo sul nulla inteso non come mera assenza ma come “mancanza di cui soffre ogni lucida coscienza, l’abisso che questa contempla”.
Un’accurata analisi di Alain Schaffner (nel volume Chanses du roman, charmes du mythe, Press Sorbona Nouvelle, 2013) riconosce ne I frutti del Congo una significativa ricorrenza del mito di Melusina in combinazione con altri miti nella definizione del personaggio di Dora e nella struttura stessa del romanzo. Vialatte attinge alla mitologia delle creature marine, produce descrizioni di un essere androgino tra acqua e aria, serpente e uccello, dai poteri divinatori. Schaffner evidenzia il passo favolistico del testo, l’instaurazione di un patto legato al proibito, connesso all’anonimato di Dora (chiamata così per convenzione ma che mai rivela il suo nome) e la violazione dell’accordo che porta alla trasformazione e alla scomparsa.
L’opera indaga il senso del vivere colto nell’incertezza, nell’irriverenza della giovinezza, nel risvolto picaresco di imprese influenzate dai precetti studiati a scuola: se Corneille ispira la visione romanzesca del vivere, Kafka rimanda ai fantasmi indocili del passato famigliare, Shakespeare solleva interrogativi sulle forme della malinconia, Baudelaire induce a un desiderio di alienazione, Pascal incalza dubbi sul vero e Nietzsche ricorda di dare un nome all’angustia. La stratificazione di realtà e illusione annulla i contorni del vero, rende indistinguibile quel che appare come necessario e quel che davvero accade nella realtà.
Con una prosa che condensa lirismo e ironia, sconfinamenti fantastici, introspezione, inquietudini e brame, Vialatte esplora un’età dell’esistenza che sintetizza la necessità di ancorarsi alle suggestioni infantili per sovrapporre il fantastico al reale, e lo sguardo sul presente con pagine che tracciano un’urgenza espressiva e di invenzione e che compiono una feroce critica alla società del consumo. L’uso dell’elemento ironico con pacatezza lirica permette di esasperare e annullare i confini del dato tangibile, mostrando una comune matrice malinconica in figuranti grotteschi immersi nel delirio urbano.
I frutti del Congo è una riflessione narrativa sulla perdita – delle suggestioni della giovinezza; della persona amata; delle visioni oniriche; delle verità del giorno e della notte; di spettri incaricati di missioni di fiducia; di mostri e province senza satiri – resa attraverso lo studio delle vecchie cose inanimate, di cuori che si seccano lontano dalle leggende che nutrono slanci avventurosi vitali. La ricerca dei fermenti da riconoscere in un nulla apparente è resa nell’attenzione rivolta alla purezza del cielo, alla finezza dei colori consunti, alle promesse mai mantenute.
Riscoprire Vialatte implica riconoscere nella cifra paradossale e assurda delle sue opere un mezzo necessario per sondare i nuovi volti del vero. La forza dirompente della sua intera produzione letteraria è riconoscibile nella volontà di espugnare una profonda comprensione delle cose in favore dell’adesione al fantastico insita nei profili e nelle storie narrate. In tal senso la vicinanza al mito è riconoscibile nell’incedere narrativo, nella combinazione simbolica definita per dettagli minimi, nell’architettura dei romanzi, nelle scomposizioni di singole scene portatrici di significati cifrati.
L’alterità della voce letteraria di Alexandre Vialatte risiede nella capacità di amplificare le umane incoerenze attraverso ingrandimenti, giochi al contrasto, dialoghi serrati e visioni aeree che celebrano un bizzarro e tetro campionario del vivente. In continuo bilico tra farsa e tragedia, la poetica di Vialatte si nutre dell’incessante e vana ricerca del significato del caso, della felicità, del senso del nulla, della valenza politica dell’esistenza, dell’urgenza di uno stravolgimento radicale dell’individuo.
Il destino passa nelle nostre vite con suole di feltro. Si nasconde senza mascherarsi. Quello che impedisce di identificarlo, sono i gesti quotidiani, l’assenza di mistero e di cerimonia. Lo si riconosce solo una volta passato.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.