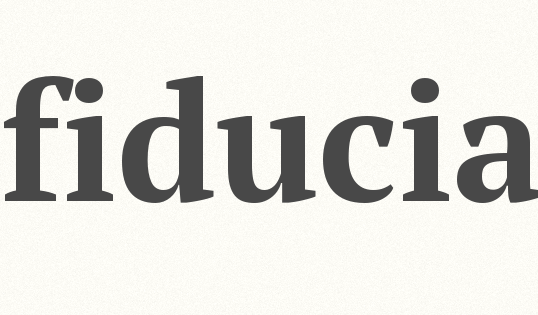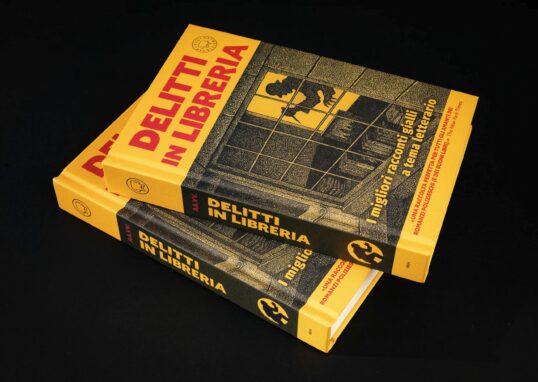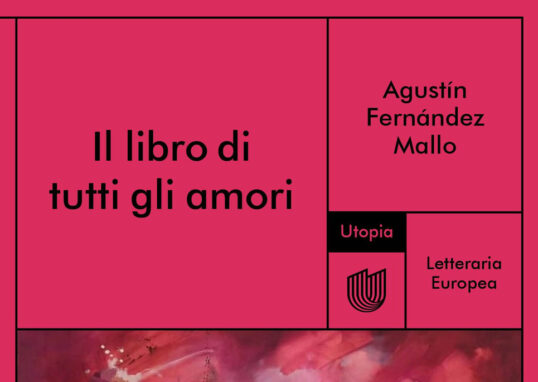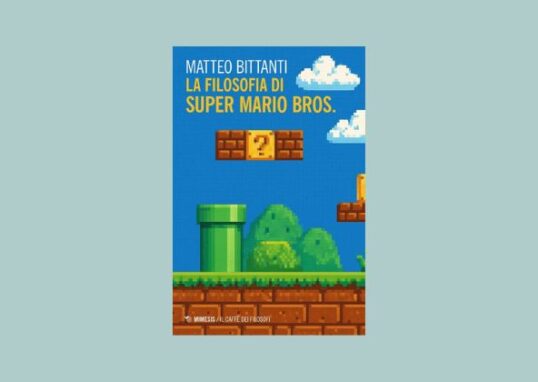Pubblichiamo un estratto dal libro Il massacro del Circeo. 29-30 settembre 1975, in uscita per Tab edizioni. Il libro propone un’indagine corale sul delitto ed è il primo titolo della nuova collana Il giorno prima, dedicata agli eventi che hanno segnato un “prima” e un “dopo” nella storia e nella coscienza collettiva.
di Luca Marchetti
È solo il 2 ottobre quando, con i tempi che impiegano le notizie ad arrivare sulla carta stampata, i giornali di tutta Italia svelano al Paese i dettagli e il contesto di un caso che presto diventa per tutti il massacro del Circeo, con un’attenzione in cui il confine tra il diritto di cronaca e la morbosità voyeuristica si fa fin dall’inizio troppo sottile. A leggere le centinaia di articoli che da quei primi giorni di ottobre cominciano ad attraversare le edizioni dei quotidiani nazionali e locali, alcuni topoi ricorrono continuamente. Oltre all’ovvia e già citata attenzione ai particolari delle violenze perpetuate, al dolore subìto da Rosaria Lopez, la ragazza uccisa, e alla condizione di Donatella Colasanti, lo sguardo della stampa si concentra sui tre assassini, tracciandone un didascalico e spietato profilo sociopsicologico. I giovani, figli di una borghesia romana disattenta e spesso complice, sono presto catalogati e liquidati come neofascisti.
L’elemento politico è quindi il marchio con cui i tre giovani sono da subito segnati, non solo da quotidiani di sinistra come «l’Unità» – che per evidenti motivi di linea editoriale sottolinea la militanza estrema dei tre assassini ma da tutta la stampa che tende a calcare sugli elementi deviati della vicenda e a concentrarsi sull’elemento politico, centrale in decine di editoriali e riflessioni dei tanti intellettuali che decidono di intervenire e commentare: la vicenda, in pochi giorni, monopolizza il dibattito nazionale.
Il massacro, infatti, genera un’accesa querelle giornalistica tra due dei maggiori intellettuali italiani dell’epoca. Italo Calvino, dalle colonne del «Corriere della Sera», e Pier Paolo Pasolini, dalle pagine de «Il Mondo», discutono sui significati sociali della tragedia e sulle responsabilità dei colpevoli. Il dibattito sulle cause sociopolitiche del massacro si inserisce in una lunga diatriba che ha già visto confrontarsi lo scrittore ligure con il poeta bolognese, da sempre con posizioni contrapposte su aspetti politici e artistici.
Calvino inizia l’8 ottobre con l’articolo Delitto in Europa. Lo scrittore parte dal caso del Circeo per esprimere tutto il suo sgomento e il suo orrore verso una violenza fine a sé stessa, libera di riversarsi sui più deboli in modo folle, come espressione politica di un neofascismo che, di fronte alla crisi delle istituzioni democratiche, riesce solo a svelare la sua natura di sopraffazione. Per Calvino gli assassini sono membri perfetti di un’altra società, una comunità di mostri che, nel dimostrare la propria estraneità al consesso civile del nostro Stato, si compie come realtà separata. Un’altra realtà che sopravvive, o meglio vive, con le sue non-regole in un disinteresse che diventa quasi opposizione rispetto alla nostra comunità.
Lo scrittore, se da un lato quasi arriva a gioire del fatto che la stupidità del neofascismo lo renda pericoloso solo per l’incolumità fisica degli individui ma innocuo per qualsiasi proposta politica, dall’altro non può che rimanere turbato di fronte allo stato della nostra classe media, una borghesia «che vive e prospera e prolifera senza il minimo senso di ciò che appartenere a una società significa, come relazione reciproca tra gli interessi personali o di gruppo e quelli della collettività»4. I tre carnefici del Circeo sono il risultato di questa crepa sociale, l’ultimo tassello di un processo che vede
una parte della nostra società, in cui il disprezzo per la donna e per le persone di condizione sociale più modesta, la linea di condotta della sopraffazione del più debole e del disprezzo di ogni senso civico, nel passaggio da una generazione all’altra, entra[re] in corto circuito con le immagini di aggressività dei mass-media che porta a una identificazione senza riserve con tutto ciò che appare intollerabile e disumano.
Per Calvino, Ghira, Izzo e Guido sono “mostri” come mostruosa è la realtà dalla quale provengono, un mondo a parte che va affrontato e chiamato con il suo nome. Solo questa consapevolezza può contribuire, in una corsa contro il tempo, alla costruzione di una società in cui ogni degenerazione, come quella rappresentata dal massacro del Circeo, non fa che rendere il terreno dove edificare sempre più «molle per reggere qualsiasi fondamenta».
All’articolo di Calvino – che lo stesso scrittore ligure non vorrebbe venisse liquidato come le «solite generalizzazioni esagerate dei moralisti» – risponde accorato Pier Paolo Pasolini, che da decenni è un attento osservatore e frequentatore assiduo della società romana, dai suoi circoli intellettuali agli strati più popolari.
Il 30 ottobre 1975, il poeta e cineasta sulle pagine de «Il Mondo» risponde a Calvino con un editoriale che inizia con due parole che sono più un atto d’accusa che una presa di distanza: «Tu dici…». Pasolini entra in aperto conflitto con le tesi dello scrittore ligure, smentendo l’impianto ideologico su cui si basa l’invettiva di Calvino sull’alterità mostruosa dei carnefici del Circeo. Pasolini rivendica di aver parlato per primo delle degenerazioni sociali, solitario, contro un ottuso silenzio (da Pasolini definito «cattolico») che vede anche Calvino complice e partecipe.
Per Pasolini l’operazione fatta dallo scrittore ligure – cioè indicare espressamente dei capri espiatori che sono parte della borghesia, Roma o i neofascisti – è un’operazione assolutamente sbagliata in quanto inefficace nell’individuare i veri responsabili sociali. Per l’intellettuale bolognese non c’è alcuna distinzione tra la violenza dei tre del Circeo e quella perpetuata quotidianamente dai loro coetanei sottoproletari e/o comunisti. Non c’è alcuna distinzione tra quello che fanno i figli dei Parioli o i figli di Torpignattara. La volontà di ravvisare una particolarità nella tragedia del Circeo, secondo Pasolini, nasce prima di tutto da un razzismo mediatico che, considerando i giovani sottoproletari delinquenti a priori, non può che raccontare con eccezionale sgomento la “straordinaria” follia omicida dei figli della borghesia romana. In qualche modo per Pasolini la colpa principale non va individuata in quella mostruosità indicata da Calvino ma in una “degenerazione sociale” guidata dal consumismo.
Un consumismo, un «modo di produzione », che ha portato in Italia una nuova cultura. Le culture precedenti, legate a quella tradizionale borghese e alle varie culture particolaristiche e pluralistiche popolari, infatti, sono ormai state sostituite, completamente perdute. Pasolini, dunque, trova in questa sostituzione sociale, che vede “tutti” i figli coinvolti, la vera causa della violenza del Circeo. Lo sfogo di Calvino, con cui Pasolini sente un’evidente distanza anche personale oltre che ideologica, è quindi fuori fuoco, se non proprio colpevole e fallace.
L’articolo, pubblicato a fine ottobre del 1975, segna uno degli ultimi interventi pubblici del poeta e regista, ritrovato morto solo qualche giorno dopo all’idroscalo di Ostia. Il massacro del Circeo e i suoi protagonisti in qualche modo accompagnano Pasolini fino agli ultimi istanti della sua vita. Il poeta, infatti, sempre più consapevole della portata sociale della tragedia e disgustato dalla narrazione fattane dai media, rimane ancorato al suo discorso, quasi ossessionato. Non a caso i ragazzi del massacro sono ricordati, ancora una volta, anche nell’ultima intervista che Pasolini rilascia al giornalista Furio Colombo solo qualche ora prima di morire:
– Hai fatto il film sulla Repubblica di Salò proprio prima del delitto del Circeo.
– Sì, e adesso mi fa impressione guardarlo, il mio film prima ci pensi come a una intuizione, che per quanto terribile ha la pace e l’armonia delle cose pensate. Poi ci lavori, e il cinema è tecnica, scena dopo scena, un’inquadratura dopo l’altra, e questo lavoro è come una enorme routine, dilata i tempi, ti macina nei dettagli, sei alla catena di montaggio del tuo stesso prodotto. Poi guardi, vedi quello che è successo. Quello che è successo è “anche” quello che ha fatto o voluto. Ma c’è qualcosa che vedi per la prima volta. Io ho sentito disagio e paura.
– Hai fatto il film pensando a “quella” Salò, alla tetra storia di allora, o i tuoi incubi su questa violenza sono in avanti, qualcosa che viene dopo?
– Ma non vedi che gli assassini del Circeo cercavano disperatamente una divisa, un travestimento? Che avrebbero dato chissà che cosa per avere in mano un ordine, una ragione, un’idea che desse un senso al loro massacro? Non lo sapevano, ma erano già travestiti. Travestiti da nuovi assassini.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente