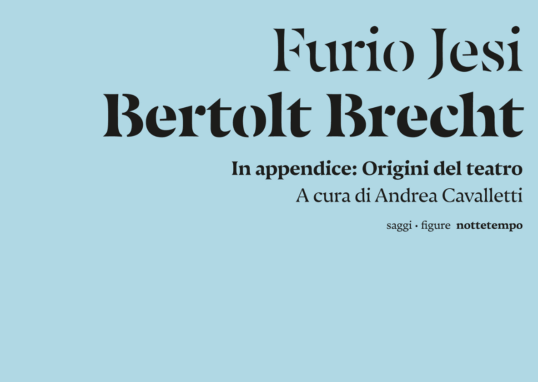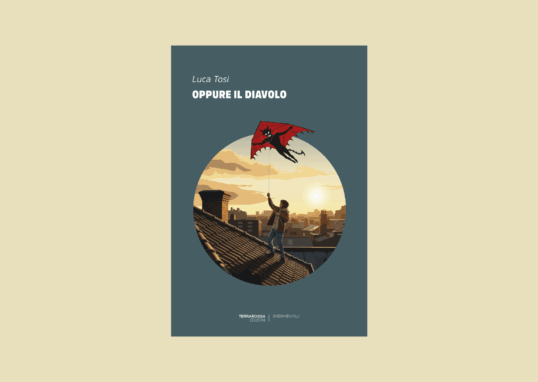Pubblichiamo un articolo uscito su Repubblica – Palermo, che ringraziamo.
La Sicilia è terra di castelli e monasteri, di rocche e di portali sbilenchi. È stata anche terra di ospizi e ricoveri, di reali case dei matti, di sanatori lungo la strada che saliva da Palermo a Monreale. Nel secolo scorso, ogni tanto, da un crinale o un camminamento superstite, si fermava qualcuno, una donna, un pastore, uno scrittore di favole e di dicerie, a fotografare il silenzio, e come a guardia del paesaggio. Un’ombra al margine, intenta a pesare con gli occhi l’erba che cresceva sui balconi, gli scuri in rovina, cosa era rimasto dell’orizzonte dopo il cataclisma della storia o a seguito di un terremoto, quali sentieri o animali o passi umani.
Gesualdo Bufalino era uno di questi custodi. Portava inciso dalla propria giovinezza un tatuaggio segreto, lo stemma del male che gli aveva sconciato anzitempo i polmoni, ma più di questo la vergogna di essere guarito. I suoi erano rimasti i panni di un reduce, il cappotto logoro e verderame di un sottotenente di manifesta inettitudine militare, la smorfia di chi è scampato a una sorte designata e sa che il ritorno da una guerra o da una malattia è sempre un viaggio di espiazione.
Pareva provenire da un tempo senza tempo, essere un testimone millenario del diluvio, avere ricevuto in consegna non il battito del respiro, che scompagina gli oroscopi e i segni del presagio, ma una perenne convalescenza. Non c’è eretico peggiore di quello che disubbidisce alla morte; questa insubordinazione lo aveva lasciato magro come una pianta selvatica, e sempre sull’orlo di qualcosa, di taglio al mondo. Una talpa che sapeva soltanto scavare tane e biblioteche, e sotterrarcisi dentro, perché a nessuno venisse in mente di venirla a cercare e scoprirla ancora viva. Nel suo nascondiglio aveva letto tutti i libri che erano stati scritti dagli uomini, e imparato la lingua degli insetti del buio, quei mostricini che dai tempi di Linneo vengono chiamati “atropi”, come la Moira della mitologia che recide il filo del destino.
Quando una voce di sirena, al telefono, lo aveva snidato fin dentro ai quartieri generali della sua solitudine, di storie ormai ne conosceva tante. Erano tutte visioni di montagne magiche e di altri luoghi di incantesimo, di apprendistati e degenze nei reami delle ombre, di epidemie di Re Tarli e di monaci novizi, di ballerine febbricitanti. Le lasciò libere con un soffio di fiato, in una nuvola gialla e bordata di nero, farfalle dalla testa di morto come quelle che volavano sulla riva del fiume Acheronte. In fondo, per lui le storie somigliavano alle falene. Appartenevano alla stessa leggenda o maldicenza, a una sola fiaba gotica e adulta.
È una di queste farfalle, giallastra di ali e addome e con lo stigma di un teschio disegnato sul dorso, che il giovane Dino incontra all’inizio della Favola del Castello senza tempo. Ha una voce “agra e lamentosa di donna” e parla della fattura che la costringe in membra così meschine, e che soltanto chi ha giovinezza, innocenza e coraggio potrà sciogliere. Gli dice del palazzo degli Immortali, delle loro eterne partite di dadi, della sabbia sospesa e immobile dentro le clessidre, di un dio carceriere. Ma anche le sue avventure sono un gioco di specchi ciechi e opachi quanto uno stagno, la messa in abisso di altre menzogne e illusionismi, dalle isole di Gulliver all’Africa di Flaiano, e di chissà quali altre latitudini.
È in questo labirinto di corridoi e di echi che Dino si perde: nella fortezza in cui è penetrato, fatta di anditi vuoti, di cucine, di alcove, lo spazio è sghembo e verticale insieme agli oggetti che lo abitano: i divani, i letti a baldacchino, gli armadi zeppi di cianfrusaglie e pendenti da un fianco. Tutto si sovrappone a tutto, nella coscienza di una stortura universale: i propri malanni alle calamità collettive, l’azzurro incandescente del cielo all’aria recintata dalle mura della gran torre.
Tocca a lui dichiarare a voce alta le tre paroline che possano vincere le sentinelle, e guidare l’evasione della truppa di larve che vi è segregata, sagome di cera, vestite di bianco, intorpidite nel loro ripetuto e periodico andare per le stesse stanze. Tre paroline in dialetto, che suonano come l’inizio di una filastrocca. Cugnu, cutugnu, bacalanzìcula.
Non ci poteva essere più esatto epilogo, per Bufalino, cultore di ossimori, di questo canone a specchio: un’ultima favola che si riallaccia al romanzo d’esordio, la chiusa che riprende l’incipit di una carriera circolare e simmetricamente perfetta. Lo scrittore che era diventato ha potuto così tornare ragazzo, o forse è stato il contrario: le tre paroline hanno spalancato i portali, per far entrare il Tempo, la Memoria, la Morte. La sabbia ha ripreso a scorrere nella clessidra, e anche Dino è stato finalmente libero di alzarsi dal letto e uscire dalla sua camera e dalla Rocca invisibile che lo aveva ospitato per tutta la vita.
Fabio Stassi (Roma 1962) di origini siciliane, vive a Viterbo e lavora a Roma in una biblioteca universitaria. Scrive sui treni.
Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Fumisteria (GBM, premio Vittorini Opera Prima 2007). Per minimum fax: È finito il nostro carnevale (2007), La rivincita di Capablanca (2008), Holden, Lolita, Živago e gli altri (2010) e Il libro dei personaggi letterari (2015). Per Sellerio ha pubblicato L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio), Come un respiro interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria (2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio) e La lettrice scomparsa (2016). Ha inoltre curato l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013).