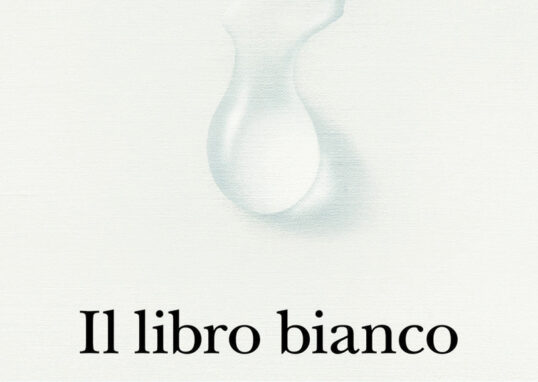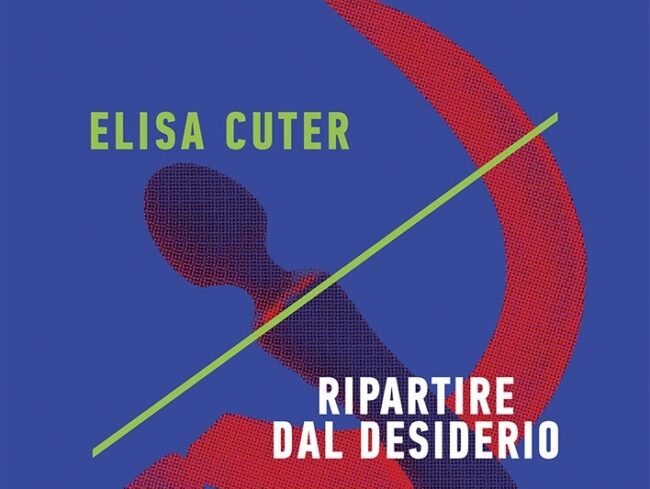
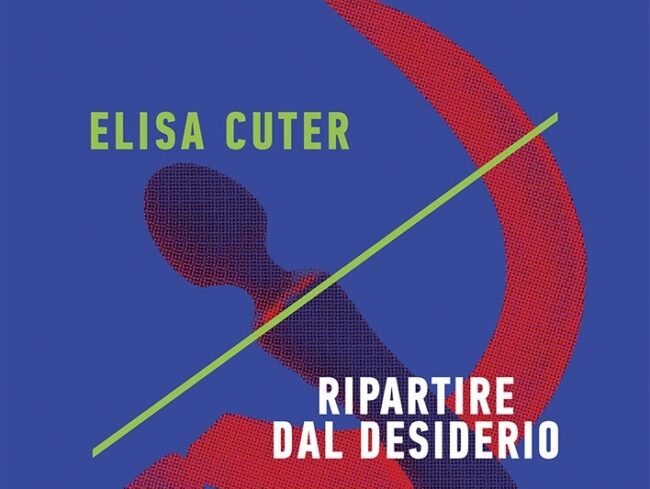
Ho conosciuto Elisa Cuter sui social e nelle cose che scriveva più o meno ai tempi della prima pubblicazione di La guerra dei meme (di cui non casualmente Elisa firma la prefazione alla seconda edizione), quando il dibattito nella mia bolla si concentrava molto sulla questione incel; l’ho conosciuta di persona solo diversi anni dopo: era una serata piovosa, al termine di una giornata di fiera.
A serata inoltrata ci siamo ritrovate a discutere del Racconto dell’Ancella – la serie, non il film – e del fastidio crescente che le varie stagioni avevano provocato in entrambe. Io identificavo il fastidio, ma non ero del tutto capace di circoscriverlo; mi turbava profondamente il fatto che le lotte femministe del periodo, in tutto il mondo, avessero scelto il vestito delle ancelle per le proteste pubbliche, i flash mob e via dicendo. Perché, mi chiedevo, continuare a rappresentarsi così, evidentemente vittime, con la cuffia che impedisce di vedere di lato e i lunghi vestiti rossi della colpa, versione enfatizzata della lettera scarlatta? Quello che mi faceva, e tuttora mi fa impressione, è la sensazione che se la prima volta suonasse come una denuncia, dalla seconda volta in poi fosse avvenuta un’identificazione: ecco, noi siamo questo, non sta a noi cambiare le cose perché ormai siamo già schiave (un’idea che peraltro non è lontana dalla brutta deriva che ha preso la serie dalla seconda stagione in poi).
In Ripartire dal desiderio, primo, densissimo e complesso saggio di Elisa Cuter, l’autrice analizza più a fondo questo ragionamento, arrivando a dimostrare come sia prevaricante un atteggiamento da vittima, appunto. Il libro di Cuter prende le mosse dall’immagine onnipervasiva di Ambra Angiolini in «Non è la Rai» nei primi anni Novanta, passando poi a esaminare il fenomeno della trasmissione, primo e forse tuttora unico caso in cui una quindicenne si trova a essere conduttrice di uno show pomeridiano dallo share altissimo, o meglio, come bene dice Cuter, in cui il reale conduttore, ovvero l’autore della trasmissione, attraverso il microfono costantemente attivo nell’orecchio di Ambra, si incarnava nel corpo di questa giovanissima soubrette, si faceva lei. Si femminilizzava.
Un lato negativo reale della modernità capitalista è proprio questo processo perverso di femminilizzazione, che più che includere le donne in un processo di emancipazione allarga la condizione di subalternità esperita storicamente soprattutto dalle donne a tutta la società.
Il concetto di femminilizzazione della società è una delle basi teoriche di Ripartire dal desiderio, un concetto che all’inizio mi ha creato qualche problema: sono tornata molte volte sui passaggi che ne parlavano per cercare di identificare al meglio una definizione che, contemporaneamente, mi tornava e mi sfuggiva. Cercando di riassumerlo a grandi linee, l’idea di una femminilizzazione in questo senso non ha niente a che vedere con un’idea biologica di genere – che anzi Cuter rinnega, nemmeno troppo sommessamente –, quanto con la sua costruzione storica: la donna, la figura femminile, è sempre stata, storicamente, la persona ai margini, quella costretta a un lavoro invisibile, stressante, abituata a usare il proprio corpo come merce di scambio (da forme più esplicite, come la prostituzione, a forme più lievi, come l’attenzione all’aspetto fisico per essere più appetibile lavorativamente o nel matrimonio): un processo che identifica con la progressiva rinuncia a parti di sé, e d’altra parte una sopravvivenza feroce, veicolata dall’adattabilità alle forme e al mezzo, a un’idea di persona capace di ‘prendersi cura’ (di clienti, di spettatori, di elettori, di familiari) e di ‘fare la cosa giusta’, sempre col sorriso sulle labbra e sempre pronta a reinventarsi, anche con successo, adattandosi tuttavia alle progressive restrizioni illuminate del capitalismo iperaccelerato del presente: diventando insomma sempre più oggetti e sempre meno soggetti, lasciandosi sempre più agire e agendo sempre meno.
Le critiche di Cuter non si risparmiano e, per quanto non concordi del tutto con la sua analisi del fenomeno #metoo, che per me ha significato anche la creazione di una rete e di una consapevolezza più forte, e di un sentimento di alleanza, non posso negare che le narrazioni da esso scaturite tendano a creare un sistema costante di vittimizzazione che non è forse sempre positivo: se non altro per il fatto che questo processo, se estremizzato, impedisce di vedere una via d’uscita. Non è tuttavia questione di dominio sul corpo, è questione di poterlo dominare per via di una struttura, quella patriarcale, che a sua volta è un’emanazione di un sistema di gerarchie di potere portata all’estremo. Quello che Cuter ribadisce continuamente e che è ribadito dalle pochissime righe in quarta di copertina, è che il problema non è il potere maschile, o il patriarcato, ma è il potere che – casualmente, perché gli conviene – lo alimenta, ovverosia il capitalismo.
Quasi contemporaneamente a queste riflessioni, mentre leggevo Ripartire dal desiderio, mi è stato fatto notare che una grandissima parte delle mie visioni serali era incentrata su tematiche di stupri, abusi, situazioni che raccontavano di minoranze oppresse e danneggiate, messe comodamente a mia disposizione dai colossi di streaming in circolazione, a me accessibili con un paio di click. Mi sono resa conto di quanto questo fosse un palliativo per il mio senso di colpa, per la mia condizione di privilegio: guardando storie di white trash abusato (la bella serie Unbelievable), o di persone nere costantemente rimesse al margine dalla società (When they see us), in qualche modo sentivo di aver fatto qualcosa, di aver accresciuto la mia consapevolezza, sentendomi in colpa.
Cuter afferma che tali rappresentazioni servono a far sentire chi guarda ‘migliori ally’, mettendo alla loro portata la capacità di immedesimarsi e soffrire in maniera appunto morbosa, priva di distanza – pornografica, insomma. La domanda successiva è: ma perché ci sono tutte queste storie di presa di coscienza? E perché, appunto, non è una cosa positiva? La risposta è implicita nel paragrafo precedente. I colossi dello streaming mi mettono a disposizione un’ampissima scelta perché cavalcano l’onda di un momento, e lo capitalizzano, rendendolo bulimicamente fruibile da chiunque lo voglia.
Gli esempi più lampanti stanno ovviamente nella pubblicità. Il corpo, la self acceptance, la body positivity e un sacco di altri termini che in inglese suonano meglio sono ormai perfettamente padroneggiati da chi gestisce le grandi campagne pubblicitarie di qualsiasi cosa, specie prodotti per la cura e l’igiene intima: dal ‘perché io valgo’ a ‘rasa il pratino’, dalle vagine canterine (adorabili, per quel che mi riguarda) di Nuvenia a ‘Hair has no gender’ – non mi capacito di come chi ha lavorato al copy non abbia realizzato la totale assurdità di questa affermazione ma evidentemente loro ne sanno più di me, perché la pubblicità di Pantene è stata trending topic per una giornata intera o due, nelle immediate vicinanze del giorno della commemorazione delle persone transgender.
Gli Stati Uniti, da cui la gran parte di queste produzioni provengono, sono il luogo in cui più in assoluto emergono contraddizioni e lacune di un sistema intriso a tal punto di capitalismo che anche le rivendicazioni anticapitaliste offrono la sponda al medesimo meccanismo perverso, trasformandosi in –washing. È dunque possibile lavorare su un femminismo (femminismo inteso come movimento che tenga in sé l’idea di unione e di lotta di tutte le minoranze, e che al contempo non dimentichi le differenze di classe, che dunque possa essere non solo orizzontale ma anche verticale) completamente radicale, che rifiuti il costrutto sociale che ci impregna?
Leggendo il libro di Cuter ho spesso pensato a un altro saggio, letto tempo addietro, che partiva da una base altrettanto critica e altrettanto potenzialmente radicale: Perché non sono femminista di Jessa Crispin, uscito nel 2017, che metteva in luce le medesime evidenti contraddizioni, che mostrava quanto il femminismo fosse depotenziato dal momento in cui i grandi marchi di vestiti a basso costo (il cosiddetto fast-fashion) ricamava le sue magliettine con scritto “girls just wanna have fundamental human rights” e simili: al tempo lo avevo trovato un libro interessante ma tutto sommato superficiale, che non riusciva ad arrivare al fondo della questione e a indagare i rapporti profondi tra il capitalismo e un tipo di femminismo lavato nella medesima corrente, il femminismo del self-care o dell’empowerment.
Ecco, Ripartire dal desiderio, muovendo da una prospettiva più squisitamente materialista e basandosi sull’esperienza dell’autrice, innegabile, di giovane donna bianca europea munita del mio medesimo privilegio, ha la sua forza nella capacità di non negare, di non omettere, di tenere insieme in un discorso complesso ed equilibrato tutte le contraddizioni che popolano la mia, e la sua, generazione. E, soprattutto, è un libro che cerca lucidamente, consciamente, di andare oltre e trovare una soluzione.
È il corpo a essere invocato costantemente dal femminismo come antidoto possibile al dominio del patriarcato, come risorsa, come strumento di liberazione. Peccato che sia proprio un corpo vulnerabile, al limite dell’impotenza. Di cui occorre prendersi cura. Le possibilità sono due: o si trova un principe azzurro che lo faccia per lei, oppure toccherà a lei assumersene la responsabilità. La cura del sé diventa allora una responsabilità a cui bisogna essere educati, e ricorda troppo da vicino la soggettivazione individualista che il sistema capitalista continua a pretendere da noi proprio perché ha smantellato ogni forma di corpo sociale, comune e condiviso.
Non hai più nessuno spazio per piacere agli altri, ti è stato portato via pezzo per pezzo: allora almeno piaci a te, usa il tuo corpo, investi su di esso. Rivendica il diritto ad appropriarti del sesso e sfruttarlo, ma codifica la tua appartenenza, codificane le regole, rendilo chirurgico. È innegabile che esista, nel femminismo contemporaneo, questa tendenza ambigua alla norma: è una questione che mi pongo sempre più frequentemente quando vedo il proliferare di definizioni identitarie nei social, specie su Twitter. La maggior parte di queste utenti (principalmente donne, e molto giovani, quelle che seguo almeno) sono woke, e conoscono meglio di me la terminologia corretta ma, e perdonatemi se rischio di incappare in un maternalismo che non vorrei, a volte mi danno la sensazione di non aver sperimentato i rischi, le frizioni, le attrattive e gli innegabili conflitti di queste così precise identità, di essere già così pacificate da non aver nemmeno il bisogno di sperimentarle, perché non c’è bisogno di confronto conflittuale: la loro esistenza è già legittimata. E se da una parte mi dico vivaddio, e che sono ingiusta e non posso ridurre il mondo al mio punto di vista, dall’altro mi chiedo quanto tutta questa prescrittività, questo positive reinforcement continuo, faccia bene alla relazione tra le persone.
L’incontro che racconto all’inizio era avvenuto subito dopo l’episodio che Cuter racconta nel suo saggio, quello della presentazione del documentario sex positive scritto e realizzato da un gruppo di adolescenti. Mi colpì, e mi ha colpito rileggerlo nel libro, il racconto di questi ragazzi così attenti alla sessualità, così consapevoli e tuttavia così, almeno apparentemente, terrorizzati dall’idea di fare realmente sesso. È un po’ lo stesso effetto che ha fatto a me la visione dei corti femministi di Erika Lust, Dirty Diaries: una visione talmente ideologica e intellettualizzata del sesso, e del corpo, da risultare incapace di eccitare. E se Lust rivendica comunque, a partire dal nome d’arte, il diritto a un godimento, la cosa impressionante del gruppo di lavoro di adolescenti era proprio la rivendicazione di non aver avuto alcun tipo di rapporto sessuale tra di loro, né durante né dopo la realizzazione del documentario, nessun impulso.
A chi sono rivolte, dunque, queste proposte, questa positività sessuale? La risposta che si dà Cuter è: a nessuno se non a sé stessi. Non c’è volontà di dialogo in queste rappresentazioni, c’è solo il bisogno di una rappresentazione (pulita, educata, apolitica) che inizia e finisce con il sé, ed è una prospettiva davvero deprimente.
La potenziale via d’uscita a una situazione di questo tipo la dice il titolo del saggio di Elisa Cuter. Il desiderio, nel senso di impulso cieco, pura volizione. Il sesso è ovviamente l’ambito più immediato per introdurre il tema del desiderio, colonna portante del libro, ma non è l’unico. Desiderio è sia volontà di agire che volontà di annullarsi, di essere oggetto a nostra volta del desiderio altrui senza la certezza di una corrispondenza, e in questo slancio spericolato, sbilanciato, verso l’esterno va ricercato il seme per uscire dalle molteplici pastoie culturali che ci circondano.
È questo quello che io chiamo desiderio: quell’esperienza che crea un conflitto, una cesura tra soggetto e oggetto. Questo rapporto tra soggetto e oggetto e un rapporto che esiste tra persone, tra persone e cose, e soprattutto all’interno delle persone stesse. E il rapporto che intercorre tra il sé e l’altro – laddove anche il sé e molto spesso un altro per noi. Il desiderio, anzi, è proprio quello che ci svela di non essere un tutto conchiuso, un individuo isolato. E quello che ci fa scoprire che ci sono delle cose che non dipendono da noi, che non possiamo decidere a priori. Cose che semplicemente ci accadono, proprio come ci accade di sentirci attratti da qualcuno, di desiderare qualcosa. Si può sperare che questo conflitto resti confinato esclusivamente all’ambito privato dell’esistenza umana? Sarebbe un obiettivo politico utile? O e piuttosto il fatto che questo conflitto esondi dal sessuale, e si riversi anche sulla società tutta, ad avere un valore politico?
Il desiderio, dunque, è politico: una potenziale deflagrazione, perché presuppone un conflitto (con sé, con l’altro) che non può essere prevista, e che per questo viene continuamente ammansita, normata, regolamentata; e tuttavia è un impulso inesauribile (qui viene in aiuto la nota sul titolo: ripartire nel doppio senso di punto di partenza e suddivisione: non si esaurisce il mio desiderio perché lo rivolgo ad altro, semmai si moltiplica e cresce, creando altre piccole potenziali deflagrazioni), e sì, terrorizza anche me, ma se devo cercare il seme di una rivoluzione mi piace pensare che possa stare qua, innescato dentro di me come la matassa nella scapola delle Ragazze elettriche, ma a disposizione di chiunque, e da chiunque riproducibile.
Silvia Costantino (Bari, 1986), è socia e co-direttice editoriale di effequ dal 2018. Si è laureata in Lettere Moderne a Siena, dove ha fondato insime ad altre e altri la rivista online «404: file not found», grazie alla quale ha approfondito la militanza nella letteratura e l’interesse per la piccola e media editoria. Dopo un corso in redazione editoriale e tanti lavori di altro tipo, nel 2017 pubblica con effequ la raccolta di saggi «Di tutti i mondi possibili», poco traduce per l’antologia di Nero «Le Visionarie» il racconto “La regina mangia la torre” di Tanith Lee. Nel tempo libero si tinge i capelli.