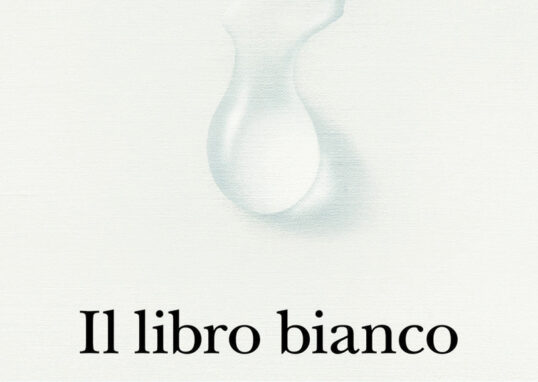«Il silenzio dei morti è differente da quello dei desaparecidos. Il silenzio dei morti è molto più semplice da sopportare».
Quando si parla di teatro, di rappresentazione teatrale, leggiamo (o ascoltiamo) frasi come «mettere in scena» o, per esempio, «portare in scena»; e poi «andiamo in scena» e la sempre efficace ed evocativa «saliamo sul palco». Sono tutte frasi riconducibili a chi di teatro si occupa, a chi il teatro lo fa. Parole del drammaturgo, del regista, delle attrici, degli attori e di nessun altro? Forse no, quei passaggi uditi così tante volte hanno a che fare, ovviamente, anche con il pubblico, competono anche a noi spettatori. È questa una delle meraviglie del teatro, la vicinanza, la sensazione di partecipare attivamente a quello che accade sul palco, fosse anche solo per il silenzio, per lo stare al buio, e da quel buio osservare chi si muove nella scenografia, ascoltare il suono che fa una battuta, detta adesso, detta solo per noi, anche per chi ha trovato posto in fondo; il monologo è per me seduto in ultima fila, nel posto scomodo in cui non posso allungare le gambe, dove soffro un po’ ma sono pure felice perché sono a teatro, e il teatro mi riguarda.
Altre volte, altre incantevoli volte il «portare in scena» è letterale e si riferisce al pubblico pagante che viene invitato a partecipare attivamente, non recitando ma salendo sul palco. È accaduto questo e te lo mostro, qui in questa stanza è successo qualcosa che ti riguarda, guarda bene, guarda vicino, da qui, da questo punto qualcuno è stato portato via, non è più tornato. Succede nel bellissimo testo scritto da Davide Carnevali, Ritratto dell’artista da morto (Einaudi 2022), e il teatro molto alto, sperimentale e tradizionale allo stesso tempo, civile e di ricerca, avviene.
Quando sono entrato per la prima volta nel mio appartamento di Berlino, quello che mi aveva colpito era stato il silenzio. Un silenzio che non conoscevo. Il silenzio delle città tedesche è un silenzio greve, il silenzio di chi non ha le parole per parlare di certe cose. […] Sicuramente conoscerete quel silenzio.
Il teatro di Carnevali è politico, le sue opere attraversano e interrogano la storia, mettono a confronto le questioni identitarie. La storia è indagata dagli oggetti di scena, dal linguaggio, dal modo in cui lo spettatore è coinvolto, da come si muovono i personaggi, dal modo in cui questi ultimi entrano ed escono da loro stessi osservando il palco da fuori, spostando continuamente il punto di vista. Il teatro è linguaggio, Carnevali lo sa e usa tutte le armi che il drammaturgo ha a disposizione, compreso sé stesso.
Ritratto dell’artista da morto è un dramma che racconta di dittatura e di chi scompare senza fare ritorno, di torture occorse senza nominarle, di persone che sanno e che fanno (o hanno fatto) finta di non sapere, dei desaparecidos e della devastante dittatura di Videla, dell’orrore della Germania nazista. Eventi biografici si fondono con la storia del Novecento e – scena dopo scena, battuta dopo battuta – riaprono vecchie ferite mai davvero rimarginate. Carnevali, col suo teatro, ci ricorda che ogni desaparecido ci compete, ogni persona trucidata dai nazisti è uno di noi, ci mostra di nuovo che non si può dimenticare, ma soprattutto che ogni fatto può essere portato in scena in maniera nuova, che la tortura può essere evocata senza essere ripetuta sul palco, che basta il disorientamento o il malore di un attore per farci stringere lo stomaco, basta entrare in una stanza per provare dolore (un po’ come scriveva anche – rispetto ad altre questioni – David Foster Wallace).
Spesso le persone hanno bisogno di dimenticare per continuare a vivere. Soprattutto quelle che portano sul loro corpo i segni delle conseguenze.
Il testo. Dall’Argentina arriva la notizia dell’apertura di un caso giudiziario che riguarda un appartamento a Córdoba, sotto forme di lettera che riceve un giovane attore. Sembra essere lui l’erede di questa casa acquistata da un lontano e sconosciuto parente nel 1978, espropriata a un musicista dalla dittatura della giunta militare argentina. Comincia un viaggio tra Buenos Aires e Córdoba, il protagonista segue la lettera e segue la storia, ma si perde, si ritrova. Se tenti di fare luce su un certo passato è facili che aumenti l’oscurità e con essa l’angoscia, l’incapacità di fare chiarezza. Chi sono i personaggi? Chi è reale e chi è inventato? Chi sa e chi non sa? Perché un appartamento mette così tanta ansia, come se le mura raccontassero, gli oggetti ricordassero. E non è vero forse che le cose ricordano i fatti a cui hanno assistito? Il musicista scomparso stava lavorando su partiture incomplete di un compositore ebreo, sparito a sua volta nel 1941 a Berlino.
Questa è soprattutto un’opera sulla relazione che esiste tra la possibilità di esprimere linguisticamente un fatto e la necessità della sua presenza fisica.
Carnevali introduce il pubblico in un mistero che si amplia a poco a poco, come se ogni cosa scoperta ci conducesse in un angolo cieco, e che da quell’angolo partissero nuovi fili. Non racconteremo qui come sono sviluppate le scene, cosa accade, cosa viene mostrato al pubblico e cosa no, cosa lo spettatore è invitato a osservare e non diremo il finale, perché i finali non esistono. L’opera è andata in scena a Berlino, alla Staatsoper Unter den Linden, le finestre affacciano sulla Bebelplatz, quella del rogo dei libri. Carnevali introduce il testo specificando, tra le altre cose, che è stato pensato per quel luogo preciso. L’augurio è di poter vedere presto quest’opera a teatro, in altro luogo, potendo lo spettatore immaginare, pensare a una finestra di Milano o di Napoli che guardino su Bebelplatz, o su Plaza de Mayo; vedere queste pagine – scritte mirabilmente – cominciare a muoversi.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/