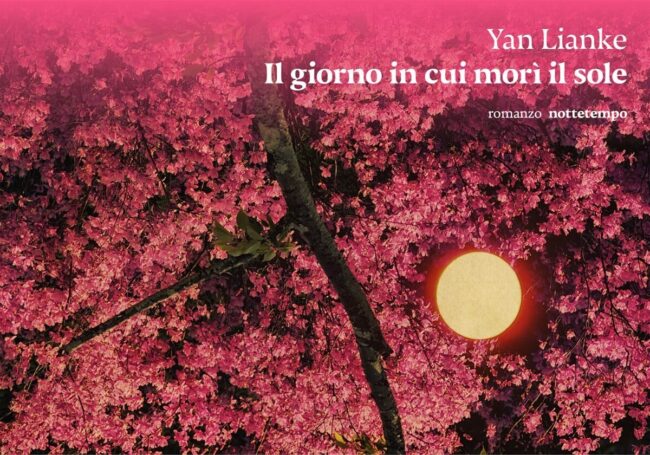
di Danilo Soscia
C’è la Storia, e poi ci sono le storie. Anche se questo non è sempre vero. Nel suo celebre ‘I quattro libri’ (Nottetempo, traduzione di Lucia Regola) il cinese Yan Lianke aveva già messo in scena una tragedia di stampo diverso. C’era la Storia, un campo di lavoro di rieducazione nel bel mezzo del Grande Balzo in Avanti, dove intellettuali di varia estrazione pagavano lo scotto della loro dissidenza vera o presunta. C’era la Nemesi storica, ovvero la conseguente carestia che in due anni avrebbe fatto milioni di morti. C’erano poi le storie, quella del Bambino, dello Scrittore, Dell’Erudito e del Religioso, gli intestatari dei quattro libri che davano, appunto, il titolo dell’opera. E infine c’era, come risultato di una sintesi velenosa, la distorsione prospettica che dava sostanza all’invenzione di Yan: le storie in verità sono la Storia, ma vivono nella condizione precaria di cellula, di esistenza microscopica. Quando sono strappate dal loro corpo maggiore e perdono la relazione con il totale, diventano ambigue, suscettibili di interpretazioni, mostri mutevoli dominati da altre forze che nella Storia non hanno diritto di cittadinanza (almeno non per ora): il sogno, la libido, la condizione umana minima.
Esiste la Storia che, novello Crono, si mangia le storie. La notte dello spirito che stiamo vivendo – almeno secondo la penna di Yan Lianke – è il suo rigurgito peggiore. E se il veleno si concentra appunto sotto la buccia degli eventi, è proprio nel sonno/sogno, ovvero nella sospensione della ragione, intesa come adattamento alla convivenza coatta e ai suoi equilibri, che la verità si riprende la scena. È infatti una storia di sonnambuli quella che viene dipanata nelle pagine di ‘Il giorno in cui morì il sole’, tradotto per la prima volta in italiano da Nottetempo (di nuovo Lucia Regola) dopo quasi sette anni dalla sua prima edizione taiwanese. Quando al sesto giorno del sesto mese del calendario lunare segue una notte interminabile, i villaggi tra i Monti Funiu sono falcidiati da un’epidemia di sonnambulismo durante la quale accade la cosa più semplice che si possa immaginare: messa a tacere l’ordinata disciplina di partito, taciuti il dogmatismo e la fede, diventano egemoni i desideri, gli appetiti, e l’intera risma zoologica dei moti repressi durante il giorno.
Solo uno, Li Niannian, un quasi adolescente, ne resta immune, osservatore e testimone della peste onirica che affligge quella che di giorno era una società tutto sommato ordinata e funzionante. La notte nel ‘nuovo’ romanzo di Yan è una condizione ontologica, dentro e fuori l’uomo, abitata da mostri, non solo. Il sospetto che coglie Li Niannian, e insieme a lui il lettore, è che la cessazione della luce (allegoria esplicita della ragione, del Partito, dello Stato) e il conseguente sonnambulismo siano una condizione naturale per l’essere umano, ancor più: una condizione ideale perché emergano le vere attitudini, la natura autentica di ciascun individuo. Il cittadino e la cittadina, il padre e la madre, il figlio e la figlia sono il frutto di un equilibrio, di una mediazione, tra pulsioni e necessità sociali, come pretende il senso comune. In verità, secondo la parabola di Yan, l’uomo è davvero ciò che è quando dorme. Un coacervo irriducibile di istinto disgregante, votato al cerchio assoluto di creazione e distruzione. Tornerà mai a sorgere il sole? È quello che si domanda Li Niannian. E nella raffinata retorica di questo interrogativo insiste un sintomo dell’arte di Yan. In effetti perché mai dovrebbe tornare il sole se la notte, in fondo, è l’habitat naturale dell’essere umano?
Quello che rende Yan Lianke diverso da Mo Yan e da Ma Jian, forse le due voci meglio rappresentative che dal cuore della contemporaneità letteraria cinese risuonano in occidente, è il particolarissimo equilibrio tra satira e tragedia, divenuto nel tempo quasi un suo specifico marchio distintivo. Una combinazione particolare di iconoclastia, grottesco e quello che per brevità definiremmo realismo magico o mito-realismo.
L’iconoclastia era un’azione concreta, nodale, già in ‘Servire il popolo’, dove il rovesciamento del monito di Mao dava il via a una maratona sessuale (in odore di lotta di classe) che coinvolgeva la moglie di un alto in grado dell’esercito e un inesperto soldato semplice. Lì il vigore erotico era acceso dalla distruzione materiale delle effigi del Presidente, riproposizione simbolica dell’uccisione del padre come unica via di affermazione vitale per i figli. Il tono grottesco permeava le pagine di ‘Il sogno del villaggio dei Ding’, dove si narrava come la vendita impazzita dell’oro rosso, il sangue dei contadini della immensa periferia rurale cinese, avesse provocato negli anni Novanta una vera e propria epidemia di Aids. Il realismo magico, quasi nei toni di un’epopea biblica, scandiva invece le singole storie di ‘I quattro libri’ dove uno dei personaggi, il Bambino appunto, mostra numerosi elementi di vicinanza con Li Niannian, il protagonista di ‘Il giorno in cui morì il sole’. Feticismo della libertà, capriccio, ma anche il peso gravoso della testimonianza, del dover raccontare quello che di inaccettabile il mondo degli adulti aveva prodotto, e dileggiarlo, offenderlo, espellerlo da sé a costo di perdere la propria dignità di essere umano.
In sintesi, se da una parte la superficie ironica e satirica sembrerebbe apparentare l’opera di Yan Lianke al tono tipico di Mo Yan, è forse con Ma Jian la relazione più densa di corrispondenze. Prima fra tutte la condivisione di un motivo come quello del sonno apparente, che nel monumentale ‘Pechino in coma’ di Ma materializzava il correlativo di un’intera generazione, unica condizione possibile perché Dai Wei, il giovane protagonista ridotto a larva dopo i fatti di piazza Tiananmen, potesse attraversare l’incubo cinese, sospeso tra nuove disuguaglianze, sfruttamento e perdita della memoria collettiva. Tuttavia, nessun evento traumatico premette l’epidemia di sonnambulismo che affligge i personaggi del romanzo di Yan.
L’evento accade, fiorisce d’improvviso, come se da tempo una radice malsana si fosse insinuata nella terra del mondo. La distinzione tra chi dorme e chi è sveglio è meno netta rispetto ai suoi precedenti letterari (come il citato ‘Pechino in coma’), e l’osservazione delle gesta mostruose degli addormentati, il racconto del sangue e delle sciagure, si svolge nel lago freddo di uno specchio: quello che riflette noi stessi. Nella notte dell’umanità messa in scena da Yan la speranza è la prima vittima, per una ragione assai semplice. Il senso della strada intrapresa procede contrariamente al risveglio, al ritorno alla luce, come scrive chiaramente Yan: <<Il villaggio era addormentato, ma pareva sveglio. Il paese era addormentato, ma pareva sveglio. Il mondo era addormentato nella notte, ma si addentrava nelle profondità del sogno come verso il risveglio>>. L’estinzione dell’uomo coincide con il suo massimo compimento, con l’adesione completa alla verità oscura che risiede dentro di lui. Le storie, alla fine, si sono mangiate la Storia. Tornerà a sorgere il sole?
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente






