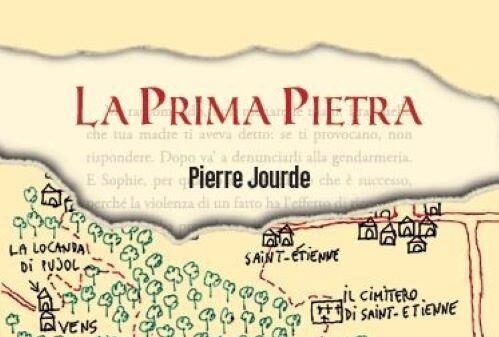
“È un paese perduto”, dicono, non v’è espressione più giusta. Non ci si arriva che smarrendosi. Nulla da fare qui, nulla da vedere. Perduto forse fin dall’inizio, talmente perduto prima di essere stato che questa perdita non è altro che la forma della sua esistenza. E io, stupidamente, fin dal principio, cerco di conservarlo”.
Quando Pierre Jourde compose Paese perduto come elegia per un’adolescente morta, immaginò di tributare la comunità della remota regione dell’Alvernia della sua infanzia, persa tra villaggi descritti come microscopiche conchiglie sulla pelle di un mostro degli abissi. Voce tra le più autorevoli del panorama letterario francese contemporaneo, Jourde è stato insignito negli anni di numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Grand Prix De L’Académie Française. La sua produzione letteraria risente di un legame con i luoghi dell’infanzia che ispireranno opere vicine al racconto di viaggio e al romanzo di formazione quali Il Tibet in tre semplici passi (trad. Silvia Turato, Prehistorica, 2019), e altre come L’Ora e l’ombra (Gabriella Bosco, Prehistorica, 2021) dove l’autore indaga il rapporto tra gli ambienti della prima età e la memoria, nel costante rimando a un passato enigmatico, con un inconfondibile uso del fantastico per esplorare il significato della perdita.
Lontano dalla retorica del pittoresco, Paese perduto è un “ritratto epico, una tavola eroica del posto” mossa dalla rievocazione di un’euforia infantile che risente del coinvolgimento emotivo generato da luoghi frequentati anche in età adulta per le vacanze con la famiglia. L’impronta della tragedia antica è riconoscibile nel periodo temporale ridotto, nella scelta di uno scenario ostile dominato da Alcol, Inverno, Merda e Solitudine, dèi grotteschi, inquietanti, che assistono alle manifestazioni di coraggio e di forza dei loro sudditi rese nel racconto di un quotidiano dominato dagli elementi per illuminarne la bellezza brutale, “la bellezza senza leziosità, la bellezza difficile, che ti respinge o ti aggredisce”.
L’uscita dell’opera provocò una profonda indignazione negli abitanti del villaggio. A nulla valsero le lettere che l’autore inviò a ognuno di loro: nel tornare in vacanza con la sua famiglia subì un’aggressione e un tentato linciaggio descritti ne La Prima pietra, dieci anni dopo l’uscita di Paese perduto. Il fraintendimento fondamentale risiede nelle intenzioni, nel vedere come denigratoria la magnificazione delle bovine, del letame all’ingresso del paese, dello sgravio delle mucche, del trasporto del fieno, del cimitero sulla collina in mezzo al vento, degli olezzi del lavoro nei campi, della bruttezza e delle miserie, della mortificazione, del “sentimento d’abbandono”.
Lo scandalo e il disonore percepiti dai contadini nella scoperta che le vicende interne alle loro famiglie e quelle dei loro morti erano finite in un libro fomentano una rabbia incontrollabile, resa in una violenza capace di “ridistribuire la dimenticanza e il ricordo”. Ripercorrere gli eventi permette all’autore di indagare la forza dirompente della letteratura nell’annullare ogni certezza, nel tradurre l’ignominia opponendo a qualsiasi grossolana finzione la complessità del reale.
Il piccolo borgo diventa per Jourde lo spazio della rievocazione di esperienze che scompaginarono la sua visione sensibile da bambino, capaci di generare suggestioni intatte nell’età matura, nella ricerca di un’evasione dalla frenesia cittadina. Al contempo, da letterato, quel luogo diventa lo scenario d’elezione dell’immaginario, l’incarnazione del mito dell’infanzia.
Sottotraccia prende forma il tributo a un padre la cui storia è motivo di pettegolezzo nel villaggio per il sospetto dell’origine adulterina dell’autore, usata dai paesani come prima forma di accusa nel dileggiarlo al suo arrivo. Una vicenda su cui lo scrittore non intende tacere per riparare un debito che sente necessario nei confronti di un padre mite e dimesso, vissuto all’ombra di sé stesso.
Nell’opera il paese è analizzato come un organismo in grado di generare finzione e perpetuarla scagliandosi contro un libro che aveva fatto cadere ogni impalcatura. In tal senso l’analisi della vergogna è emblematica nel descrivere lo scarto tra l’estraneo e il noto nel calarsi nella visione di chi percepisce un’invasione nella presenza dell’ospite in casa propria. L’autore lambisce la distanza irrisolvibile tra la personale nostalgica suggestione infantile e l’impressione di intrusione in uno spazio “sovraccarico di limiti invisibili”.
L’incedere narrativo è un preambolo al tragico e, al contempo, una riflessione sugli esiti del trauma. Lo spazio temporale distorto e rallentato amplifica lo sgomento provato per la trasfigurazione grottesca di volti amati generata da un odio incontrollato nel terrore del ridicolo. In un continuo muoversi tra passato e presente, lo shock della violenza si rivela nella ripetizione, nella presa d’atto, anche in sede giudiziale, del paradosso del carnefice mascherato da vittima che reitera in aula la commedia della vita di campagna, in una situazione “mitologica e condiscendente” che provoca un senso di irrealtà e di impotenza in chi la subisce.
Le anse liriche sui reperti di tempo irraggiungibile, come le immagini del veglione in casa per tutto il paese nell’anno della tempesta, delle sbornie condivise, dell’aiuto nel trasporto del fieno, dell’accoglienza dei bambini, della benedizione delle tombe a Ognissanti, definiscono il paradosso nella lancinante presa di coscienza della ferocia dell’etichetta dello straniero e del nemico.
L’architettura dell’opera produce istantanee su rappresentazioni alternative del mondo attraverso la resa concreta della realtà rurale del villaggio e, al contempo, nella raffigurazione dell’irruzione della violenza nell’incanto puerile. Jourde indaga la percezione del vero nel disorientamento e nello straniamento, esplora una “violenza in via di cancellazione”, il rapporto con un paesaggio che a tratti assume le sembianze di una configurazione interiore: il paese come esilio e smarrimento.
Un libro non è fatto per ammettere le cose così come noi le sistemiamo nell’ordine necessario della vita. Torna sul passato, e anche sui morti, quindi, perché non può accettare il pensiero che ciò che è stato venga restituito al niente. Per il libro il passato vive al pari del presente.
L’autore torna a un tema d’indagine già esplorato in precedenza, il rapporto tra verità e finzione, attraverso lo studio degli esiti dell’elezione di una maschera per perpetuare e rendere credibili versioni alternative del reale. L’analisi è imprescindibile dal contesto e dallo studio del rapporto con lo spazio nel modo in cui l’ambiente è in grado di forgiare l’indole dell’individuo e raccontarne il rapporto con una natura indifferente. Nell’ispezionare il vuoto, Jourde delinea l’inscindibilità del sentimento del luogo con quello della perdita.
Il libro non voleva essere realista, perché la realtà non è realista. O meglio perché il realismo non è capace di restituire tutta la carica di un immaginario che riempie il reale.
In questo atipico trattato sulla forza impetuosa della letteratura, Jourde si interroga sull’ambiguità della narrazione personale nel rapporto con il proprio io, che favorisce la costruzione di innumerevoli versioni di sé che si allontanano da un’onesta rappresentazione e producono sgomento, inquietudine e rifiuto del ritratto fornito dagli altri, ragione che lo spinge a improntare l’opera sulla seconda persona singolare, rivolgendosi a sé stesso provando a osservarsi dall’esterno.
Ognuno, nel suo riserbo intimo, preserva con gelosia il tesoro di quell’«io» che non utilizza, così come, nelle campagne, non si usano le stoviglie più belle, che si conservano ben chiuse nella penombra dei mobili, per un giorno, per IL giorno, ma quel giorno non verrà mai. Tuttavia l’«io» segreto rimane la promessa di questa assunzione, senza la quale non ci sarebbe ragione di vivere.
L’improvvisa demolizione della dimensione metafisica intacca la malia dell’infanzia che nutrì le pagine di Paese perduto, scritte preservando una sorta di epifania nella narrazione dei segreti e dei piccoli scandali di paese. L’esito surreale ne La Prima pietra risiede nel sovrapporre al racconto del reale l’esperienza privata dell’intellettuale che riversa nel congegno narrativo le allegorie dell’estasi sensoriale e dello smarrimento, il rapimento infantile per le suggestioni di un luogo fuori dal tempo e il terrore adulto della violenza, con una prosa in grado di conferire anche alle scene più drammatiche una sottile levità, che custodisce una remota clemenza.
A volte, nel tuo fantasticare, attraverserai la pietra, andrai a mischiarti ai corpi granulosi dei vecchi muri, ti mescolerai nella sostanza nodosa degli alberi, andrai in fondo alla stalla ad ascoltare il respiro dei vitelli, e crederai che sia di nuovo l’infanzia, l’infanzia che si gira e rigira nelle acque eterne. Entrerai in casa tua, cercherai i letti nei quali, molto tempo prima negli anni, già sognavi questo momento, cercherai nella notte la luce dei lunghi pomeriggi senza fine, scenderai per i vicoli scoscesi, verso la chiesa, verso gli abbeveratoi, sarai sempre lì, loro malgrado, a casa tua.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.






