
La solitudine, l’assurdità di vivere e l’alienazione trovano una nuova traduzione narrativa nella rappresentazione fornita da Dimitris Sotakis ne Il miracolo di respirare (trad. Maurizio De Rosa, Del Vecchio, 2019). L’annientamento sulla base dell’estraneità al mondo e a se stessi appare come l’esito finale della graduale e inesorabile metamorfosi attraversata da un uomo senza nome. In condizioni di grave indigenza e con una madre malata da assistere, il giovane protagonista del romanzo di Sotakis crede di trovare la soluzione ai suoi problemi rispondendo a un annuncio di lavoro in cui un fantomatico istituto ricerca una persona disposta a collaborare offrendo la propria casa per immagazzinare mobili.
Se inizialmente le condizioni appariranno vantaggiose e senza impegno, ben presto si aprirà per l’uomo uno scenario inquietante. Imprigionato nella sua stessa casa, impossibilitato a uscire, è oggetto di un esperimento di cui non è consapevole, convinto sino alla fine di essere un dipendente che deve fare fede al suo impegno e accettare con acquiescenza qualsiasi limitazione di spazio e di tempo pur di assolvere il suo compito. Diventerà giorno dopo giorno vittima dei sogni che aveva appena iniziato a coltivare, a partire dall’acquisto di una casa con la sua fidanzata Risha. “Non avevo più paura di niente, avevo smesso di provare l’angoscia dell’emarginato, la vita mi appariva un ventaglio di promesse, sentivo di essere un esponente a pieno titolo della società umana, una persona come tutte le altre, piena di desideri e aspirazioni”.
Sotakis allestisce un’allegoria feroce della deriva della società attraverso una tragedia il cui attore principale si consuma nella solitudine. Perennemente sospeso tra estraneità e spaesamento, è vittima
di un cocente senso di colpa nel dubitare della fortuna di tale impiego come occasione imperdibile per risanare la propria situazione economica. Il duro attacco al sistema capitalistico, alle leggi del mercato del lavoro e alla privazione della libertà personale e della dignità dell’individuo permeano l’intera narrazione attraverso una parabola non confinata al caso europeo ma che, per la scelta di ambientare la storia in una città senza nome di un paese non riconoscibile, assume connotati universali. La scrittura di Sotakis è caratterizzata dal costante uso del paradosso e dell’eccesso volta ad amplificare il reale e che assume un duplice significato: da un lato innesca una feroce denuncia sociale e politica attraverso l’esposizione all’assurdo per rendere le contraddizioni del mercato del lavoro, e dall’altro usa la visione distorta del protagonista per enfatizzarne e estremizzarne gli effetti. “Un demone immateriale si affilava i denti ogni volta che mi muovevo. Non avevo più paura”.
Il racconto della solitudine e dell’impotenza del singolo di fronte al resto del mondo incarnano in Sotakis la rappresentazione dell’inutilità dell’azione individuale: l’ineluttabilità del destino si rivelerà talmente manifesta da generare un corto circuito interiore nel suo unico destinatario, perennemente in bilico tra smarrimento e fulminei sprazzi di lucidità intellettuale. “Mi sentivo il protagonista di uno spettacolo allucinante. Ero circondato da una massa di mobili, di oggetti e di suppellettili che ormai mi era impossibile distinguere. Intorno a me si ergeva una muraglia fatta di un materiale indefinibile, una massa minacciosa di mostri silenziosi, simili a sentinelle che mi tenevano continuamente d’occhio. Sentivo la minaccia sospesa sul mio corpo disgraziato, non mi restava altro che attendere la scadenza di quell’accordo perverso che avevo firmato, stringevo i denti e portavo pazienza”.
L’uso sapiente del surreale contempla il comico come strumento per addentrarsi nelle contraddizioni vissute da chi sperimenta su di sé patologie legate alla reclusione forzata e arriva a perdere ogni spazio vitale e la possibilità di muoversi, nutrirsi autonomamente e comunicare con gli altri. L’incapacità di dominare le proprie inquietudini genera sparuti spazi di gioia che contrastano, seppur momentaneamente, il dramma consumato e permettono al protagonista di provare nonostante tutto gratitudine per essere vivo e persino stupirsi del “miracolo” di respirare. L’assoggettamento dell’individuo, reso a partire dalla prospettiva deformata del protagonista, delinea l’imposizione di un rimodellamento del quotidiano che renderà progressivamente la casa un luogo estraneo e ostile contribuendo a un’alienazione inesorabile.
La prosa di Sotakis delinea, attraverso il grottesco e l’iperbolico, una mostruosa metamorfosi che approda alla depersonalizzazione e alla disgregazione del reale. L’analisi della percezione del quotidiano attraverso la ridotta prospettiva del visibile – “Il buio produsse l’effetto di farmi vedere le cose con maggiore chiarezza” – innesca un’indagine sul significato di realtà e verità. La distorsione generata dalle paure che assumono sembianze diverse sulla base dell’alterazione emotiva, approda, con le allucinazioni, a una traduzione per immagini dell’ultimo strenuo rifiuto del corpo a una condizione di infermità paragonata a un veleno ormai diffuso in tutto l’organismo. “Desideravo che arrivasse al più presto la luce del giorno, che mi liberasse da quella sovranità del nulla, del vuoto assoluto, ma purtroppo quando le luci dell’alba dissolvevano l’incubo notturno anche la liberazione si rivelava nient’altro che un’illusione, il passo successivo che continuava un circolo vizioso alienante e sempre uguale a se stesso”.
Il congegno narrativo si fonda sulla descrizione della vulnerabilità di un uomo che sperimenta continui tentativi di resistenza, sfociati nella perdita del senso del tempo che approda all’elaborazione di un’immagine mentale trasfigurata rispetto all’esperienza vissuta. “Poiché mi sentivo il tempo scivolare tra le dita e avevo la sensazione di essere irrevocabilmente prigioniero di una melassa vischiosa sena capo né coda, all’interno di una situazione da me non voluta, per non perdere la testa cominciai a immaginare che tutta quella storia fosse una sorta di sacrificio da me compiuto, in qualche modo mi sacrificavo sull’altare dei miei sogni, che, una volta realizzati, mi avrebbero procurato la gioia più grande mai provata in questo mondo da un essere umano”.
L’indagine sul corpo sviluppata da Sotakis sottende un’analisi della resistenza al dolore e dei percorsi della psiche a partire dagli effetti dell’illusione e dell’autosuggestione capaci di generare nell’individuo la percezione di libertà di azione e pensiero anche in condizioni estreme con brevi sprazzi di lucidità. “Il mio essere obbediva in modo totale a quella indesiderata narcosi fisica, il mio corpo si andava trasformando a poco a poco in qualcosa di estraneo, di inerte, in un pezzo di legno”. L’accettazione di qualsiasi tipo di privazione si basa sull’illusione, tratteggiata rendendo i costanti sbalzi di umore che alternano l’incapacità di reazione alla rabbia, al senso di colpa, all’improvvisa euforia nell’immaginare il termine del calvario. “L’inerzia in cui ero sprofondato mi stava privando progressivamente del diritto a essere me stesso. Quello che ero prima, quello che accadeva fuori del mio appartamento o nel resto del mondo non aveva alcuna importanza”.
La metafora cardine dell’intera narrazione è richiamata dall’indifferenza al mondo esterno vissuta dal protagonista, che ridefinisce costantemente i confini del proprio, sino a circoscriverli alla porzione di soffitto che è ancora in grado di vedere. Ormai privo di qualsiasi forma di coinvolgimento emotivo, arriverà gradualmente a sperimentare una radicale estraneità, particolarmente evidente nel contrasto tra la devastazione di una città al collasso per l’insurrezione di carcerati in lotta per la libertà e l’indifferenza con cui l’evasione è accolta, al pari di un lontano brusio di fondo a cui il protagonista non presta alcuna importanza. “Ero diventato un osservatore terrorizzato della mia stessa decomposizione, aveva persino smesso di riguardarmi che cosa ne sarebbe stato della mia vita una volta scaduto il contratto”.
Una narrazione dagli echi kafkiani innervata da riflessioni sul senso dell’esistenza e sulla sua natura enigmatica attraverso una costante immersione e emersione da sé. Davanti all’inesorabile perdita di controllo della propria vita non rimane che affidarsi all’immaginario per identificare un’idea di salvezza nell’illusione vana che ci possa essere un’altra possibilità e che quella vissuta non sia altro che una prova di vita. “Sono anni che sto provando, quand’è che comincerò a vivere per davvero?”
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.

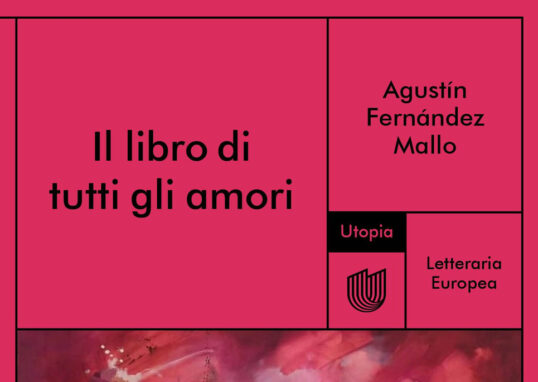
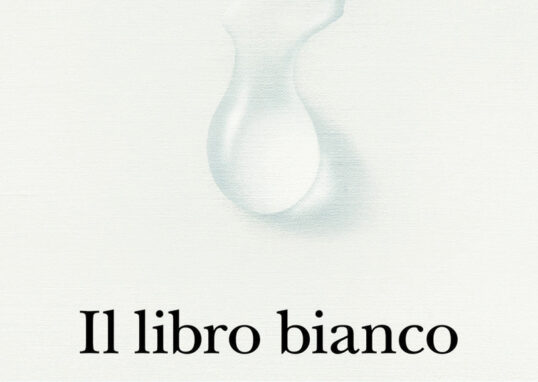




1 commento