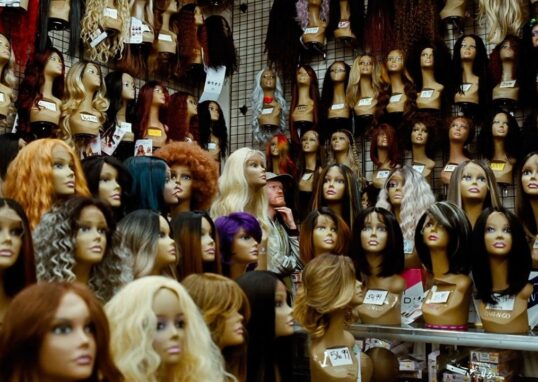Friends, Romans, countrymen, lend me your ears!
Non vengo a parlare del Bowie musicista, bensì del Bowie attore, quello che dagli albori della sua carriera ha intrattenuto con l’arte delle ombre un dialogo fitto e – in taluni momenti – imperscrutabile.
E lo faccio per due ragioni: la prima riguarda un sano, io credo, timore intellettuale. Quella dedicata a Bowie in quasi sessant’anni è una devozione di studio che rasenta il mistero religioso, e per mia indole tendo a non varcare soglie che mi coglierebbero impreparato, e per questo irrispettoso. Conosco e amo il musicista, la sua portata epocale mi abbaglia, ma il discorso si limiterebbe a un viaggio intimo – individualissimo – e non è questo il tema che vorrei trattare. La seconda ragione riguarda invece i miei eccessi cinematografici, il mio essere ‘mangiatore di film’, secondo la definizione coniata da Enzo Ungari, per cui il metabolismo filmico è la riduzione in pensiero di tutto quanto il cinema sollecita in me: emozioni, idiosincrasie, paure, memoria. Ed è in questo particolare diaframma che vorrei inserire il mio discorso.
Ma per renderlo ancora più spurio, non mi dedicherò alle concomitanze tra quel film e quella fase musicale di David Bowie, né alle ragioni materiali della sua adesione a questo o a quell’altro progetto cinematografico, né tanto meno alla qualità delle singole pellicole che vorrei citare. Non dirò che Bowie è stato prima di tutto attore, e che la sua esistenza filmica dimostra come per lui l’interpretazione di un ruolo precedesse sempre la sua icona, né che il cinema è stato per Bowie l’ennesima declinazione della sua ossessione per il cambiamento, per la mutazione inesausta.
Vorrei assumere tutte queste premesse come le condizioni necessarie e sufficienti per la retrospettiva minima che segue, provando invece a inseguire il frullio di un’idea laterale: la parabola cinematografica di David Bowie è il racconto dell’incessante oscillazione tra sé e il suo doppio, tra la sua condizione umana, per definizione limitata, e quella fantasmatica, aliena, vampiresca attraverso cui ha cercato di osservare i fenomeni caratterizzanti il mondo come lo conosciamo, da una prospettiva sofferente e privilegiata.
The Image, regia di Michael Armstrong (1969)
Il primo ruolo accreditato di Bowie è appunto quello di un fantasma. Il soggetto del cortometraggio The Image è esile ed essenziale dove uno spettro, interpretato da Bowie, prende vita da un’opera d’arte (un dipinto per la precisione), e non per confortare il proprio creatore, bensì per dargli il tormento, adombrando nella sua apparizione una sorta di atto punitivo. È l’artista perseguitato dalla sua opera, la maschera che si ribella al suo attore, poiché ogni atto creativo è l’esecuzione di un trauma che prima o poi pretende il suo debito.
L’uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth), regia di Nicolas Roeg (1976)
Il primo mutante musicale di Bowie troneggia nel capolavoro di Roeg: un alieno, ovvero pura spettralità spaziale. Lo scrive bene Massimo Palma nel suo Desiderare Bowie, di recente pubblicazione presso l’editore nottetempo, molto attento al profilo cinematografico dell’artista inglese: <<La credibilità della discesa di Thomas Newton nell’intrico di isolamento e dipendenza è sentita come naturale dall’“alieno” chiamato a interpretarla, che condivide la stessa sensazione di palude, di contenzione.
A Newton-Bowie spettano in sorte trattamenti che sembrano estratti dalla science-fiction di Kubrick degli anni più recenti (tanto 2001: Odissea nello spazio quanto Arancia meccanica), ma in un paesaggio americano soffocante tra corporations e cospirazioni, deserto e consumo>>.
Gigolò (Schöner Gigolo, armer Gigolo), regia di David Hemmings (1978)
Il secondo film da protagonista di Bowie è anche l’ultimo di Marlene Dietrich. E se consideriamo che nel cast vi compaiono anche Kim Novak e Hilde Weissner, la dimensione fantasmatica dell’intero film è più di una suggestione allegorica. Paul Ambrosius von Przygodski, ufficiale prussiano sopravvissuto al primo conflitto mondiale, la cui bellezza è un ostacolo paradossale al suo sogno di vita borghese, deve vendere se stesso per sopravvivere nella Repubblica di Weimar. Il personaggio di Bowie è un morto che cammina tra altri morti che non sanno di esserlo, e il portamento da ‘martire’ già mostrato nel film di Roeg diventa una cifra saturata, al limite della decadenza.
Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo), regia di Ulrich Edel (1981)
Più di un semplice cameo, in quest’opera Bowie compare nei panni di se stesso, durante il concerto alla Deutschlandhalle, doppelgänger della sua icona, quando Berlino era ancora lo stralunato centro del mondo europeo. Il Bowie filmico abbandona per alcuni secondi la crisalide del personaggio mostrandosi nella sua verità popolare, maschera nella maschera, interprete di se stesso.
Miriam si sveglia a mezzanotte (The Hunger), regia di Tony Scott (1983)
Alieno, spettro e quindi vampiro nei panni di John Blaylock, coprotagonista nel film tratto dal romanzo The Hunger di Whitley Strieber. Nel rivedere la pellicola a distanza di decenni dal suo alveo originario, non si può non notare come l’interpretazione di Bowie fosse all’insegna dello straniamento e della distanza, quasi la tensione attoriale che lo aveva connotato fino a quel momento fosse giunta a un punto di rottura.
Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence), regia di Nagisa Ōshima (1983)
Prigioniero di guerra, e di nuovo morto che cammina, il Maggiore Jack “Strafer” Celliers conserva apertamente taluni aspetti peculiari del vampiro John Blaylock. L’ambiguità prima di tutto, la proiezione erotica, la prossimità alla morte. Nonostante la vocazione inconciliabile delle due opere, i relativi protagonisti interpretati da Bowie sembrano del tutto complementari.
Absolute Beginners, regia di Julien Temple (1986)
Dopo essere stato l’improbabile sicario Colin Morris per John Landis (Into the Night, 1985), David Bowie indossa ancora una volta i panni di un doppio cinematografico, una sorta di proiezione tossica del Bowie musicale, in un film dove incarna Vendice Partners, uno dei suoi ruoli più ‘inquietanti’. Algido, distante, aristocratico,il personaggio di Bowie nella sua compiutezza è forse il più ‘bowiano’ dei ruoli interpretati prima della fine degli anni ottanta.
Labyrinth – Dove tutto è possibile (Labyrinth), regia di Jim Henson (1986)
Ma chi è davvero Jareth, il re dei Goblin? Un diabolico oppositore oppure uno strumento di evoluzione, di trasformazione degli individui che lo incontrano sul proprio cammino? Tutte queste cose e nessuna: nel caso del Bowie attore, il re dei Goblin ha il profilo tagliente e sinistro di qualcosa che conosciamo già, che la storia ha già visto, la ricomparsa per altri versi – e con un decennio di mutazioni alle spalle – di un alieno del subconscio, master of puppets dell’immaginario, crudele, ammaliatore, per il quale ora la forza distruttrice è rivolta tutta verso gli spettatori piuttosto che su di sé.
L’ultima tentazione di Cristo (The Last Temptation of Christ), regia di Martin Scorsese (1988) e Fuoco cammina con me (Twin Peaks: Fire Walk with Me), regia di David Lynch (1992)
Il Ponzio Pilato di Bowie è apocrifo fino all’eccesso. Nell’aspetto, nel piglio definitivo, efficiente, cinico. In un vertiginoso gioco di specchi con lo spirito del suo tempo – e il suo personaggio – Bowie chiude gli anni ottanta, mentre apre ai novanta con il delirio paranoide del folgorante Phillip Jeffries in Twin Peaks: Fire Walk with Me di David Lynch. L’uomo intrappolato in un incubo di cui pochissimo vediamo nella prima versione cinematografica (ampiamente ripescato nel 2014 in Twin Peaks: The Missing Pieces), è uno degli ultimi epigoni del Bowie vampiro e vampirizzato, dell’androgino ammaliatore ridotto alla sua deriva psichica in una sequenza – quella della ricomparsa repentina di Phillip Jeffries nelle trame delle indagini – che per quanto breve è uno dei picchi dell’intero film.
Basquiat, regia di Julian Schnabel (1996)
Pochi anni dopo David Bowie diventa Andy Warhol nel biopic dedicato alla vita e all’arte di Jean Michel Basquiat, chiudendo con una maschera nella maschera, un travestimento analogico (l’essere vampiro è un brano della vulgata su Warhol), e forse il suo più nostalgico fantasma. Basquiat è anche il requiem di un decennio, gli anni ottanta, che nel film rivivono in una sorta di elegia postuma, dove l’estinzione, la scomparsa, il segno costante della morte sono i motivi dominanti.
The Prestige, regia di Christopher Nolan (2006)
L’attraversamento del decennio che separa Basquiat dal fim di Nolan, per il Bowie attore è contraddistinto da barlumi sconnessi tra loro, dove solo l’icona resta come segnale di riconoscimento, e quindi di richiamo, delle metamorfosi vissute.
Il mio West, per la regia di Giovanni Veronesi (1998), Everybody Loves Sunshine di Andrew Goth (1999), Il segreto di Mr. Rice (Mr. Rice’s Secret) di Nicholas Kendall (2000), il cortometraggio Empty di Tony Oursler (2000) e il celebre cameo in Zoolander di Ben Stiller (2001) restano sullo sfondo rispetto all’interpretazione ‘totale’ sostenuta da Bowie nei panni di Nikola Tesla. L’uomo della clonazione ante litteram, lo scienziato che tocca con mano il potere totale della tecnica e la sua potenziale vocazione al male quando non calibrata da una morale, è letteralmente incarnato da Bowie. Non è approssimativo affermare che dietro i panni di Tesla pulsa una schiera importante degli eroi tragici interpretati nei film di una vita, tutti detentori di un potere o della consunzione di esso, ciascuno tormentato da una condizione ‘aliena’ che non sa conciliarsi con la dolorosa banalità del mondo.
Danilo Soscia (1979) scrive per quotidiani, siti e riviste letterarie. Ha pubblicato Atlante delle meraviglie (2018) e Gli dei notturni (2020) entrambi per l’editore minimum fax.