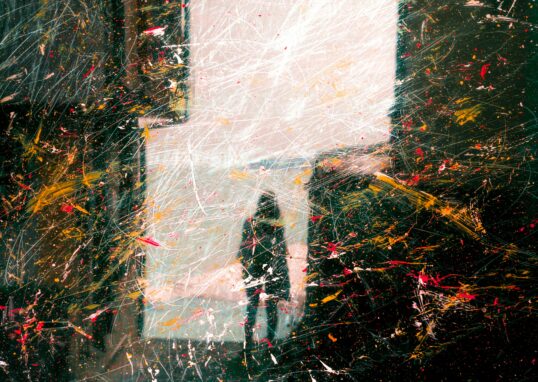di Isabella Panfili
Sabato quattordici marzo il Marocco chiude le frontiere e l’aeroporto di Marrakech appare al mondo come un enorme alveare brulicante di esseri umani in attesa di un volo che li riporti a casa. Terminati i posti a sedere, le persone hanno iniziato ad ammassarsi negli angoli e sulle scale, poi ovunque nel mezzo, chi in piedi, chi appoggiato alle valigie, i più giovani sdraiati in terra, alcuni giocano a carte. Mani nervose sventolano biglietti in aria per attirare l’attenzione del personale aereo, arruffano capelli dalle acconciature già trascurate, si infilano in borse piene di oggetti recuperati all’ultimo minuto negli hotel. Dal mormorio incessante delle richieste di informazioni, delle lamentele e degli scongiuri, ogni tanto emergono imprecazioni e urla di viaggiatori infuriati.
Siamo agli inizi della pandemia. Seduta in cucina, il telefono in mano, ascolto in vivavoce le risposte del Consolato italiano a Casablanca. “Signora, ci sono i voli di emergenza, prenotiamo un posto per lei e la sua famiglia?“. Le notizie sono confuse, nessuno sembra sapere cosa fare. “Ma se partiamo poi ci faranno rientrare? Lei capisce, abbiamo la casa, il lavoro e tutta la vita qui in Marocco”. “Questo, signora, non so dirglielo con certezza. Molto probabilmente non vi sarà possibile tornare, almeno per un po’”. Il mio sguardo incrocia quello di Ismail, che per tutto il tempo è rimasto ad ascoltare in piedi, appoggiato alla porta. Nel patio i bambini giocano, la luce del pomeriggio filtra dall’ampia apertura del riad illuminando le pareti bianche e il pavimento in zellij, i giocattoli lasciati nell’angolo vicino alle scale, un paio di scarpe da ginnastica, la bouganvillea acquistata qualche giorno prima e ancora in attesa di essere travasata. Mi arriva distante la voce della funzionaria del Consolato, “Signora, é ancora lÌ?”, chiede. “Grazie”, rispondo, “noi restiamo”. Lascio nome e recapiti, e riaggancio il telefono.
La sera ci infiliamo nel letto senza riuscire a prendere sonno. Nora, che ha cinque anni, si arrabbia quando le dico che non torneremo dai nonni a Pasqua. Le chiedo allora di accompagnarmi nello studio, la prendo in braccio mentre guardiamo la carta di Peters che abbiamo appeso al muro, e col dito cerchiamo l’Italia e il Marocco, tentiamo di figurarci la distanza che li separa e seguiamo la linea scura del confine attraverso la Francia e la Spagna, fino a Gibilterra. I giorni successivi sono scanditi da notiziari che seguiamo con voluto distacco, le dichiarazioni del governo sull’ammodernamento degli ospedali e l’aumento dei posti letto, la protezione sociale auspicata per tutti, la chiusura delle scuole e dei luoghi pubblici, l’inasprimento dei controlli ai confini per contenere i flussi migratori illegali verso l’Europa.
Nel frattempo, la città intorno a noi si trasforma. Quella Marrakech rumorosa e affollata che inizialmente non ci aveva conquistato perché troppo satura, troppo densa di odori, ci chiediamo ora dove sia finita, le strade deserte, gli erogatori del disinfettante per le mani all’ingresso dei suq. Ci assale la sensazione che un conflitto silenzioso si stia consumando sulle pareti della nostra casa. Tutta intenta a modificare gli spazi di fuori, la pandemia sembra risparmiare gli interni, dove la vita si ripete più o meno uguale a se stessa. Alla fine di marzo, la gatta partorisce nel sottoscala del bagno. Viene a cercarmi quando capisce che il momento è arrivato, le si rompono le acque sulle mie ginocchia. I bambini sono entusiasti, passano il tempo a giocare con i cuccioli, mentre noi ci consacriamo con difficoltà al lavoro a distanza. Ogni venerdì, Aicha ci prepara il cous cous, prima di lasciarci per andare a fare la preghiera.
Ad aprile la medina ci mostra il suo volto più duro. Con il blocco del turismo vengono meno i servizi, fuori casa gli sguardi si fanno sospettosi e le richieste di aiuto più insistenti, mi capita di essere seguita fino alla porta del riad per qualche moneta. Il fratello di Ismail ci propone di raggiungerlo a Sud, qui non ci sono casi, i bambini possono stare all’aperto, hanno allacciato internet, potete continuare a lavorare, se necessario tornate a Marrakech in poche ore. Facciamo le valigie con l’idea di stare fuori solo qualche settimana e attraversiamo la via che si snoda lungo i fianchi ripidi dell’Atlante con un viaggio diretto, senza interruzioni, con i bambini che custodiscono diligenti il grosso cartone pieno di buchi per far passare l’aria in cui riposano la gatta e i cuccioli.
Arriviamo ad Ait Ben Haddou nel tardo pomeriggio di una giornata di metà aprile, ci vengono incontro per prime le donne, ci salutano, nonostante il virus, alla maniera tradizionale, sfiorando la mano con la punta delle dita e poi appoggiando leggermente la punta delle dita sulle labbra. Sorridono, dicono parole in berbero che non capisco anche se so che parlano di me, sarò forse dimagrita dall’ultima volta, o forse soltanto si vede che sono stanca. Ci raggiungono i bambini, si incaricano di portare le borse più leggere, che scarichiamo di propositodal portabagagli. Fatima, che ha quasi quattordici anni e con i suoi occhi allungati e il naso minuscolo ricorda una scultura africana, prende Nora e Zakaria per mano e li accompagna dentro casa. Poi arrivano i tre fratelli più giovani di Ismail, ci danno un benvenuto cauto, a distanza, e prendono quello che resta. Li seguo fino a casa lungo la via di ciottoli su cui si affacciano edifici in terra e cemento che espongono, come fossero cicatrici, mattoni, ferri, enormi pali di legno, spazi pensati per essere salotti e al momento usati come cortili per pecore e galline.
La capanna in terra e paglia dove ho trascorso i primi mesi della mia vita in Marocco adesso é una costruzione moderna a due piani, senza balconi. Entrando nel salone spoglio che fa da ingresso, mi investe l’odore di incenso e carne speziata. Ci sistemiamo al piano di sopra. Dalle ampie finestre delle camere vediamo l’oasi, la casbah e l’unica strada asfaltata che attraversa il villaggio in tutta la sua lunghezza e su cui di rado si sentono passare le automobili. Da qui, assistiamo al trascorrere di lunghe giornate prive di eventi. I tempi si dilatano, dormiamo più del necessario, spesso ceniamo che é già notte fonda. La vastità dei paesaggi amplifica le distanze, la pandemia ci appare come una minaccia lontana, anche se continuiamo a seguire i notiziari, quello italiano, quello marocchino, quello francese. Nel frattempo, i bambini si abituano a giocare in strada e imparano le prime parole in tachlehit, la lingua berbera di queste regioni, la lingua della loro famiglia. Zakaria quando ha sete adesso dice aman, che vuol dire acqua, per mandare via il cane randagio che si é appostato davanti casa gli tira di nascosto i sassi che trova al lato della porta, come fanno qui, nonostante abbia capito che io e suo padre non vogliamo. Lo osservo raccogliere sassi e sporcarsi le mani con la terra, mentre seduta in un angolo della strada di fronte a casa mi impegno a mettere insieme le poche parole che conosco in lingua locale, a formare frasi, a tentare di creare legami, sono tutti zii e zie, cugini e cugine, ci vengono a trovare e mi parlano come se fossi una di loro, anche se io nella maggior parte dei casi non sono sicura di conoscerli.
Sono i primi di giugno, il mese di ramadan si é concluso lasciando nell’aria una sensazione di leggerezza che poco si accorda con le previsioni cupe di un ritorno alla normalità non prima dell’estate del prossimo anno. Andiamo spesso a fare lunghe passeggiate a piedi attraverso gli orti che circondano le rovine dell’antico insediamento sahariano e la fortezza in terra che occupa il fianco della collina rivolto a sud-est. Cartelli sbiaditi in varie lingue ci indicano la direzione per l’ingresso.
Fino a qualche mese fa, avremmo trovato qui una lunga fila di turisti con le facce sudate e gli zaini in spalla, accompagnati da solerti guide locali che li avvertirebbero di fare attenzione a non scivolare nel canale di irrigazione che costeggia il sentiero. Probabilmente alcune guide coglierebbero l’occasione per spiegare che nei canali scorre un’acqua particolare, che é salata perché attraversa le miniere di sale che si trovano sulle montagne, un tempo proprietà del terribile Pacha Glaoui, il traditore, colui che al termine dei suoi viaggi lasciava le scarpe fuori dalla grande porta del suo palazzo perché tutti sapessero che era tornato e ne avessero timore, colui che si era venduto ai francesi e per questo morì in esilio. Raccontiamo tutto questo ai nostri figli mentre camminiamo sulla terra rossa, tra gli olivi, i melograni e l’erba medica, l’ultima parte é quella che preferiscono, Zakaria stringe le sopracciglia e arriccia le labbra per imitare il volto spaventoso del Glaoui, mentre Nora vuole sapere che cosa facesse di così crudele per incutere tanta paura ai suoi sudditi.
La memoria mi riporta indietro all’estate di otto anni prima, all’immagine di me, seduta in terra su un tappeto logoro, all’ingresso del negozio di cianfrusaglie di Abdellatif, lungo la via che conduce alla casbah. Abdellatif è un ragazzo berbero sui venticinque anni, con lo sguardo mite e i ricci scuri nascosti in un turbante nero. Io e lui non parliamo molto. Mentre mi siedo, lui riordina gli oggetti nello spazio angusto della boutique che ricorda i racconti delle mille e una notte, con i tessuti appesi alle pareti e gli oggetti di diverse provenienze sparsi ovunque, maschere africane, mani di Fatima, porte intarsiate, cofanetti in madreperla che nascondono gioielli dai simboli il cui senso mi sfugge.
Ho i piedi infilati in un paio di ciabatte in plastica, indosso un caftano di colore scuro, il volto semicoperto da un foulard. Guardo i turisti scendere dai minivan a gruppi di dieci, dodici persone per volta e avviarsi alla visita coi dépliant in mano, mentre indicano con curiosità gli oggetti esposti all’esterno dei negozi. Un gruppo di italiani mi domanda il prezzo di una collana. Si sorprendono a sentirmi rispondere in italiano e istintivamente mi si siedono accanto, mentre Abdellatif ci porta il té e un piacevole profumo di menta si diffonde nell’aria. Mi chiedono cosa ci faccio qui, gli rispondo che ci vivo. “Ah, sei tu l’italiana che vive qui”.
È una mattina di dicembre. Sdraiata nel letto, guardo Ismail prepararsi a partire per un viaggio con dei nuovi clienti francesi. Ne abbiamo discusso a lungo, prima che lui accettasse la richiesta arrivata via mail, in maniera del tutto inattesa, qualche giorno prima. “Hanno fatto il test, è negativo, bisogna pur tornare alla normalità”, mi ha detto alla fine, chiudendo la conversazione, e sebbene io sia preoccupata, non ho saputo come controbattere. Mi saluta con una carezza sulla spalla ed esce, tirandosi la mascherina sul volto.
Da che siamo arrivati nel nuovo appartamento, al secondo piano di una palazzina residenziale risalente agli anni novanta, i vicini non hanno mancato di ricordarci l’importanza delle norme di prevenzione anche nel percorrere, all’ingresso o all’uscita, le scale condominiali. Cosi, dopo più di due mesi, ancora non conosciamo il volto di nessuno, anche se tutti si sforzano di apparire gentili, con gesti spesso amplificati, quasi teatrali.
Mezz’ora dopo l’uscita di Ismail sono in sala, col caffè in mano, a guardare attraverso i vetri dell’ampia finestra a tre ante il profilo alto delle palme dei giardini Majorelle. Ho promesso ai bambini che oggi andremo a comprare le nuove decorazioni per l’albero di natale, dopo esserci accorti che quelle dell’anno passato sono andate perse nel trasloco. Poco dopo siamo fuori, seguo con lo sguardo Nora e Zakaria correre, ridendo, lungo l’ampio marciapiede che fiancheggia le mura del Musée Yves Saint Laurent fino alla strada trafficata che conduce dritto a Bab Doukkala, all’ingresso della medina. Dalle grate delle finestre, scavate nelle mura spesse di color terra, si intravedono le fontane e l’interno dei giardini. Accanto alla porta, una guardia aspetta i pochi visitatori in fila per l’ingresso, con in mano un rilevatore per la temperatura.
Dall’inizio della pandemia al mese di Dicembre 2020, il Marocco ha contato circa 400.000 casi di COVID-19 e più di 6.500 decessi. Il diffondersi del virus, contenuto anche grazie a strettissime misure di confinamento e alla chiusura delle frontiere, ha portato allo scoperto la fragilità del sistema sanitario locale, soprattutto nelle zone rurali (circa 1 medico ogni 3.000 abitanti a fronte di circa 4 medici ogni 1.000 abitanti in italia). In termini di impiego, si calcola che nel 2020 siano andati perduti più di 1,25 milioni di posti di lavoro, sebbene i numeri siano difficili da calcolare con precisione a causa delle proporzioni enormi del settore informale, che secondo stime ufficiali arriverebbe a coprire quasi il 70% del mercato del lavoro. Ne risulta la difficoltà a mettere in campo misure di protezione sociale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione, durante i mesi di fermo di quelle attività produttive dove è più diffusa la tendenza al lavoro “nero” (come il turismo, che rappresenta quasi il 10% del PIL nazionale e nel 2019 dava lavoro a circa 550.000 persone).
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente