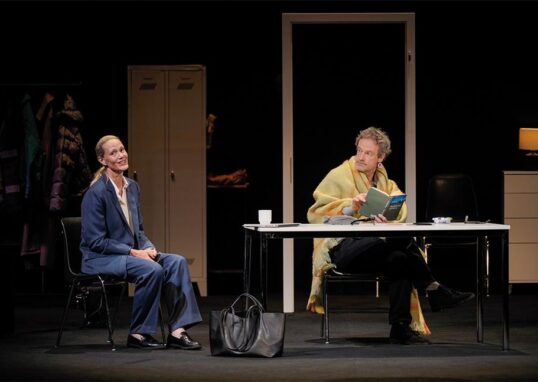Si è concluso Alla fine della città, la rassegna di Ti con Zero, il grande reportage che dal centro all’estremità della capitale racconta nuove realtà urbane, indagando i rapporti tra associazioni e cittadini, le esplorazioni in bicicletta e quelle performative con artisti teatrali. Tra queste, la tre giorni a cura del coreografo fiorentino Virgilio Sieni, con il laboratorio Dalla mano alla mano, che si è svolto dall’8 al 10 novembre nei giardini della Cooperativa Cobragor di Casal del Marmo.
Danzatore e coreografo, Virgilio Sieni è un artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità archeologica del gesto. Crea il suo linguaggio a partire dal concetto di trasmissione e tattilità, con un interesse verso la dimensione aptica e multisensoriale del gesto e dell’individuo, approfondendo i temi della risonanza, della gravità e della moltitudine poetica, politica, scientifica e archeologica del corpo.
Dal 2003 dirige a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta, Centro Nazionale di Produzione della danza per la ricerca e la trasmissione sui linguaggi del corpo, uno spazio per ospitalità e residenze di artisti, in un programma interdisciplinare tra danza, musica e arti visive.
Nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, nata per creare e approfondire contesti di formazione rivolti a persone di qualsiasi età, provenienza e abilità, sull’idea di comunità del gesto. Sviluppa percorsi nelle città e nei territori fondati sull’idea di partecipazione, ascolto del corpo e rigenerazione del territorio.
Nel 2018 fonda La Scuola sul Gesto e il Paesaggio, un contesto di formazione per approfondire la relazione tra corpo e territorio: dalla natura al gesto e viceversa, dalla memoria del movimento alla creazione di nuove geografie urbane. Ed è proprio in questo contesto che nasce l’idea di questo laboratorio pensato per il Festival Alla fine della città.
Tra la mano e la mano è il laboratorio di movimento di tre giorni che ha tenuto all’interno della rassegna Alla fine della città. Com’è avvenuto l’incontro con l’associazione Ti con Zero e com’è nata l’idea di questo lavoro?
Con Maria Morhart [curatrice e manager culturale ndr] ci conosciamo da moltissimo tempo per via di una bellissima esperienza fatta a Tuscania con diversi bambini del territorio, dalla quale nacque un ciclo di manifesti pubblici, poi diffusi in città, che raffiguravano bambini immersi nella natura. In questo caso, l’intenzione era quella di riprendere il tema ambientale legato a un’idea di spazio tattile, di spazio che ci comprende e ci alimenta, che ci fa immergere dentro una dimensione di nuovo ascolto. Il lavoro che ho immaginato per questo laboratorio è stato principalmente rivolto a un’idea di tattilità, all’idea di manipolare l’aria, più che toccare il corpo, capire come il corpo sia immerso in una dimensione auretica. Siamo partiti dall’idea di lavorare nella natura ma poi siamo giunti a un concetto di spazio tattile tout court.
Le persone con cui lavora in questi laboratori hanno età differenti e molto spesso non provengono necessariamente da esperienze con la danza, si tratta di non professionisti che lei definisce “cittadini”.
Lavoro da tanti anni a questi progetti. Ho avuto gruppi estremamente eterogenei, di duecento o di cinque persone. Si tratta di lavori molto spesso intergenerazionali. In questi gruppo, ad esempio, sono dieci persone di un età che va dai trentacinque anni in su. Dentro si ritrovano educatori, pensionati, professionisti o disoccupati. Si crea una situazione meravigliosamente eterogenea, una comunità che altrove difficilmente si formerebbe, stando alle profonde distinzioni di ruoli che esistono in società. Il senso del mio lavoro è far incontrare queste individualità sul territorio del corpo e far trovare espressione al loro senso di abitare il mondo.
Nel 2018 ha fondato la Scuola sul gesto e il paesaggio, per approfondire la relazione tra corpo e territorio. Come avviene questo incontro e cosa si interpone, secondo lei, tra queste due entità?
Il territorio è un qualcosa di già tracciato, allo stesso tempo l’uomo ha la capacità di segnare il paesaggio, sempre meno, perché l’individuo, il cittadino è stato espropriato di questa sua funzione di costruire il territorio. È stato esternalizzato a tutta una serie di istituzioni e attività che lo espropriano di questa sua capacità artigianale. In passato le case le persone se le costruivano, conoscevano i materiali, alzavano muri, conoscevano le tecniche più raffinate di costruzione. La casa diventava quel luogo conosciuto, conosciuto proprio nei materiali, un luogo impermanente. Oggi la casa la si compra. L’idea di territorio nasce da vari aspetti. Uno è confondere una geografia già prestabilita. Andare a collegare tra loro spazi desueti: da un prato a un edificio, da un luogo simbolico che potrebbero essere le Poste a un luogo disabitato. Quello che cerco di fare nei miei lavori è creare una geografia immaginaria e rimodulare un’idea di percezione di una geografia di periferia. Lavorare su una cinquantina di spazi all’aperto intesi come spazi non preparati ma occasionali, che si tratti dell’angolo della strada, di una piccola aiuola, di alberature e della palestra di una scuola. Andare a individuare in un luogo periferico degli spazi in cui dare vita a dei cicli d’incontro. Per avere una percezione rinnovata di territorio bisogna starci. Se io svolgo un ciclo di incontri con venti cittadini sotto la chioma di un albero, quella chioma diventa il ritrovo per tutti e assume un aspetto importante legato alla cura. Si elimina così l’idea di non luogo e si stimola piuttosto l’interesse per quel preciso luogo. A livello cognitivo il territorio assume questa dimensione fondante di una mappa emozionale del corpo umano. Lavorare nel territorio significa frequentare questi luoghi e non farci uno spettacolo e basta. Si può anche iniziare con una performance e da lì poi diluirla nel corso del tempo, ma con l’idea chiara che lavorare nel territorio è un lavoro molto lungo e non basta un evento ma una serie di incontri e di pratiche da svolgere in almeno un triennio, altrimenti è una dimensione solo legata alla società dello spettacolo.
La pandemia ha imposto a tutti noi una riconsiderazione dello spazio e del contatto. Come cambia, in questa prospettiva, il rapporto fisico con l’altro da noi, che sia un corpo o un luogo?
Distanziamento sociale è una espressione impropria, dal momento che la socialità non consiste necessariamente nell’aggregarsi fisicamente agli altri. La socialità è un fenomeno più complesso, è mantenere unita la relazione pur con un distacco fisico. Il distanziamento di cui si è tanto parlato in questi ultimi due anni è stato fisico, non sociale. Il mio lavoro si concentra molto su una serie di ricerche orientate alla dimensione auretica della persona, toccare e non toccare, cercare di capire come non offendere una persona partendo da un discorso legato alla genesi dell’uomo, alla sua biologia. Ad esempio, approfondendo una serie di ricerche condotte nell’ambito delle neuroscienze, ho provato a focalizzarmi su quello che è accaduto al polpastrello, a cui è stata progressivamente sottratta la propria dimensione come elemento prensile, inducendolo piuttosto a lavorare come elemento di ascolto della dimensione tattile dello spazio. Da qui ho sviluppato il discorso dell’immaterialità. Sono vicino a una persona anche se sono a un metro da lei, percepisco il suo corpo e con esso posso instaurare dei dialoghi.
Molti dei suoi lavori vanno ad individuare nella città un corpo umano e, viceversa, i corpi diventano luoghi.
In occasione di Marsiglia capitale d’Europa 2013 ho rappresentato una persona con le braccia aperte, lavorando lungo la Canebière, che rappresentava la colonna vertebrale, mentre il braccio destro corrispondeva ai quartieri arabi, dove sorgeva il teatro nazionale e il sinistro alla città residenziale dove c’è la Citè Radieuse di Le Courbusier. In questo abbraccio ideale i cittadini di queste due sponde molto diverse tra loro si sono incontrati lungo la Canebière, un incontro che è avvenuto dopo tre anni di lavoro. Il corpo come mappa geografica della città è un tema che ricorre nei miei lavori. Del resto, il corpo vive immerso in uno spazio, e quindi ne è determinato. In quanto abitanti del mondo siamo governati dalle leggi della natura, che ci ha visti arrivare e ci vedrà dipartire, ma in questa profondo interconnessione con ciò che sta fuori di noi, il nostro perimetro è un laboratorio continuo di libertà e democrazia. Se ci pensiamo bene, il corpo è molto democratico: la piccola muscolatura, i tendini, sono un sostegno alla grande muscolatura, il piccolo, il marginale, il bordo sostiene tutto quello che è evidente e appariscente.
Il concetto del corpo tende sempre a un’idea di liberazione, che viene sempre prima della democrazia. Tutto il sistema articolare funziona così. Liberare l’articolazione significa riuscire ad associare un gesto ad un altro e dunque a farli connettere insieme. Ecco che il corpo diventa un laboratorio sulla liberazione e sulla democrazia.
Quali sono gli ultimi progetti ai quali si sta dedicando?
Ho curato un progetto con la Fondazione Merz, La dimora del volto, dove ho lavorato con gli oggetti intimi di Marisa e Mario Merz, sono state create delle azioni, soprattutto di coppia, dove si passava dal manipolare l’oggetto a restituire lo stesso gesto senza l’oggetto e quindi a lavorare con una immaterialità. Allo stesso modo, alla fondazione Prada di Venezia, ho lavorato con gli oggetti intimi di Luigi Nono, con l’idea di restituire il gesto agli oggetti caduti in oblio, dove la memoria continua a elaborare una qualità straordinaria del gesto che è quella di percepire un infinito del corpo. Un gesto può essere ripetuto ma può anche essere variato in infinite possibilità.
Giornalista, si occupa di teatro, viaggi e società. Collabora, tra gli altri, con le riviste Il Tascabile e CheFare.