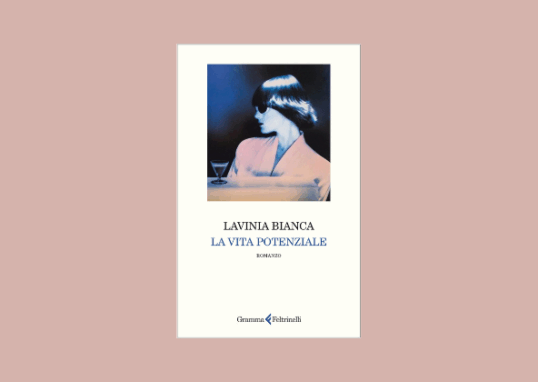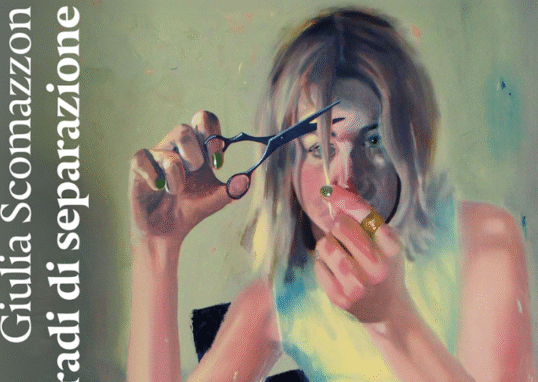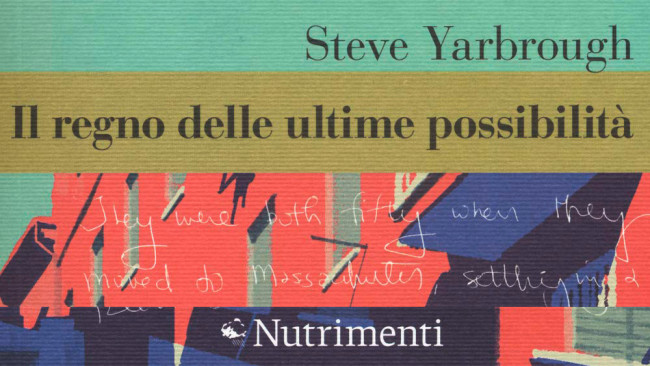
Pubblichiamo un pezzo uscito su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica, che ringraziamo.
Solo nel momento di dover riassumere di cosa parla ci si accorge che, sotto un’apparenza domestica, calda e triste che oscilla tra Yates e Carver, tra impalcatura letteraria borghese e minimalismo, scorre l’epico fiume di Steinbeck. Lo si scopre tornando a leggere l’incipit: “Avevano entrambi cinquant’anni quando si trasferirono in Massachusetts… Come era successo a molti altri in tutto il paese, di recente non avevano avuto fortuna”.
È un’epica nascosta. Se la tempesta di sabbia della Depressione teneva i personaggi di Furore in un unico afflato, qui il trasloco da costa a costa di Kristin e Cal ha le parvenze della scelta: una coppia di mezza età investe le proprie risorse residue di tempo e volontà in un ultimo tentativo di ricominciare. “Il deficit di bilancio dello Stato era costato a lei il posto di vicedirettrice del personale accademico in un grande campus” californiano. La crisi dell’ateneo dipendeva dalla “crescita sproporzionata del settore amministrativo”, erano fioccati i congedi obbligatori.
Se non sembra un’epica è anche perché si presenta come un triangolo amoroso. Lei, Kristin, è stanca del marito, Cal, dopo quindici anni di relazione. Cal fa lavoretti nelle case, ma è un burbero che preferisce accarezzare e suonare la sua collezione di chitarre. Kristin si innamora di Matt, il vicino di casa più giovane, diversamente disperato. La sua dipendenza dalla cocaina ha messo in moto una catena di eventi che gli ha fatto perdere un lavoro in libreria; ora questo bibliofilo sensibile e colto incarta panini al pastrami in un alimentari.
Matt e Kristin vogliono molto più di una relazione. Se facessero parte della controcultura, magari, con la filosofa Donna Haraway si spiegherebbero il loro incontro come un bisogno di generare parentele. Perché hanno bisogno di fare cose nuove. “Per quindici anni, fino a quando non aveva perso il lavoro”, la vita di Kristin “era stata priva di preoccupazioni rilevanti. Ogni mattina si era alzata, aveva preparato la colazione, dato uno sguardo al giornale locale, poi si era fatta la doccia e si era vestita. Era entrata nel garage, aveva azionato l’apriporta, era salita in macchina ed era andata al lavoro”. La chiave è l’apriporta azionato: così funziona la scrittura di Yarbrough. Il dettaglio giusto ci porta dentro la questione. Quindici anni inghiottiti da un apriporta automatico.
La storia procede nei tre punti di vista, ma il più importante sembra essere Kristin. L’invecchiamento di Kristin è il più organico, le sue reazioni sono le più articolate, così la sua sensibilità eleva un romanzo che avrebbe l’aria del solito romanzo sulla classe medio-bassa americana se non tremolasse, come Kristin, di una calma commovente.
Due momenti segnano l’inizio della relazione tra Kristin e Matt. Uno è un allagamento dello scantinato della nuova casa. “Ho trovato il tuo problema”, le grida Matt. “C’è un piccolo foro nel muro, e la mia ipotesi è che ci sia un tombino proprio sopra”. Questo senso della fragilità delle case è una porta di accesso privilegiato alle fragilità dei personaggi, come sa chiunque abbia visto aumentare in casa le infiltrazioni di pioggia negli ultimi anni. Una volta risolto il problema (il marito è in viaggio), Kristin ha una delle sue reazioni lente, umane e per questo strane: ha bisogno di essere abbracciata.
Il loro rapporto trova un correlativo oggettivo che è una grande invenzione: nel secondo incontro cruciale, Matt porta con sé “un frigo portatile con una caraffa di martini già miscelati”. Il martini, uno dei cocktail che più rappresentano un ideale di cristallina eleganza, che in tutto il romanzo trova dei contraltari letterari nelle citazioni di Richard Yates e Sandor Marai, è miscelato e raccolto in un frigo portatile, ma non per rozzezza interiore, solo per una voglia disperata.
Poi c’è Cal. Quando Cal fa i lavori di casa o suona le sue chitarre, questo romanzo assorbe e ronza. E quel che succede a Cal con la chitarra ci aiuta a capire il rapporto di Yarbrough con la sua scrittura: “quando ascoltava il suono prodotto dalla Martin, si sentiva come se lui non avesse niente a che fare con quel suono, come se lui fosse lo strumento e il suono fosse l’artista”.
Francesco Pacifico è nato a Roma nel 1977, dove vive. Ha pubblicato i romanzi Il caso Vittorio (minimum fax), Storia della mia purezza (Mondadori) e Class (Mondadori). Ha tradotto, tra gli altri, Kurt Vonnegut, Will Eisner, Dave Eggers, Rick Moody, Henry Miller. Scrive su Repubblica, Rolling Stone, Studio.