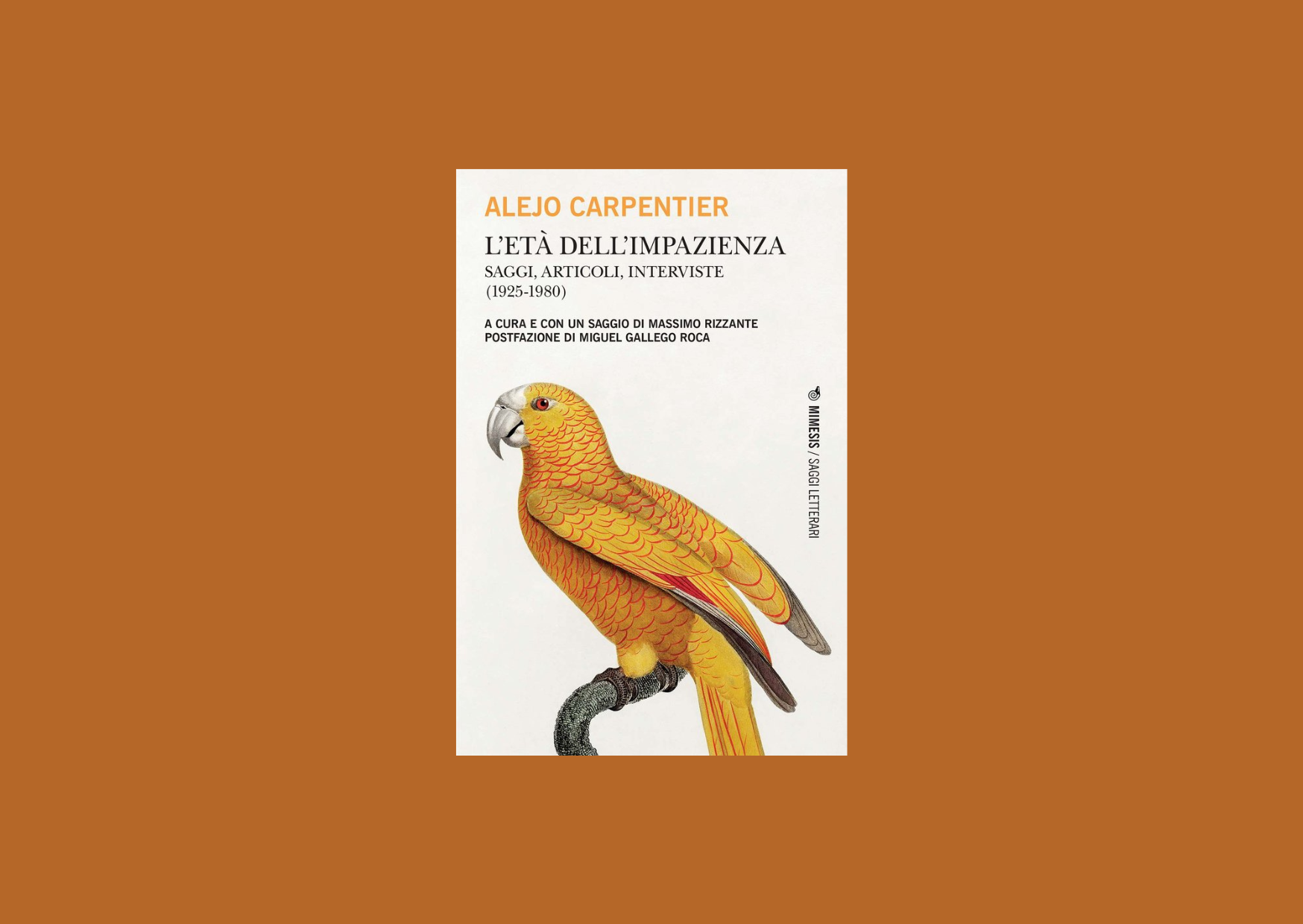
Pubblichiamo, ringraziando l’editore Mimesis, due saggi dalla raccolta di scritti inediti in lingua italiana L’età dell’impazienza Saggi, articoli, interviste (1925-1980) di Alejo Carpentier, scrittore cubano e tra i più importanti scrittori ispanofoni, profondo conoscitore di tutte le avanguardie del XX secolo, unico scrittore latinoamericano a vivere da vicino il surrealismo e il primo a far conoscere agli intellettuali parigini i punti cardinali del romanzo latinoamericano. Il libro è stato curato da Massimo Rizzante.
***.
L’ESTREMA AVANGUARDIA
Alcune caratteristiche del surrealismo
a J.A.F. de Castro
Se leggerete lo stupendo Manifeste du surréalisme di André Breton, conoscerete i segreti di un’arte magica, la cui scoperta costituisce il fatto poetico più importante dalla fuga dalla letteratura di Arthur Rimbaud. Conoscerete le virtù di quella “dettatura del pensiero, in assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione e al di là di ogni preoccupazione estetica o morale”, che partorirà le misteriose e affascinanti poesie di Robert Desnos e i paesaggi infiniti dei Champs magnetiques di Soupault e di Breton; accarezzerete le creature oniriche che palpitano per la prima volta nelle tele di Masson, Max Ernst e Joan Miró; passeggerete nelle città deserte di Giorgio de Chirico; coglierete i messaggi lirici di Louis Aragon, di Éluard e di Péret… Ma la lettura di questo documento fondamentale sulle inquietudini moderne non vi rivelerà l’esistenza di un “atteggiamento surrealista”, la cui trascendenza non era prevista dall’autore del manifesto quando scriveva le sue frasi rivelatrici.
Il culto della velocità, il giudizio tagliente sui valori del passato, l’amore per il cinema, per i ritmi primitivi, per i transatlantici ridotti a pantofole, il disprezzo nei confronti delle prudenti e venerate massime dei padri, la bancarotta di principi considerati fino ad allora norme morali inviolabili, tutte quelle affermazioni – frutto dell’esaltazione o del rigetto – che costituiscono la base stessa dello spirito nuovo, hanno creato un tenace scetticismo intorno all’attuale gioventù. Per il buon borghese gli artisti della mia generazione sono degli allegri iconoclasti: assomigliano a individui pericolosi e miscredenti per i quali la vita è priva di un senso profondo… Tuttavia, coloro che hanno potuto osservare le istanze che animano la mentalità del dopoguerra vedranno che esse devono la loro freschezza e la loro versatilità a una forte fede e a una concezione quasi religiosa dell’attività intellettuale. Benché si accordi meno importanza alla portata delle creazioni dello spirito, si richiede loro una purezza ben superiore… Se i moderni voltano le spalle alle banalità pretenziose dei Bordeaux, degli Echegaray o dei Bazin, se si rivoltano contro un teatro da bottegai, se detestano una pittura mediocre e fotografica, è perché assegnano alle opere dello spirito la nobile missione di essere un veicolo poetico lontano da ogni genere di sciocchezze… Tutto lo sforzo degli intellettuali contemporanei tende a dare grande dignità alla concezione estetica. Coloro che accusano i giovani di disumanizzare l’arte, in fondo, protestano contro quel guazzabuglio di sentimentalismi, quelle misere tresche campanilistiche e quella psicologia da donnette che impedivano all’arte di battere veri record di qualità.
L’atteggiamento dei surrealisti è il solo in grado di definire lo spirito profondamente idealista delle giovani generazioni. Tale atteggiamento, affermato con vigore attraverso le dimostrazioni e le proteste violente compiute dai surrealisti più combattivi, riassume le tendenze della migliore gioventù francese dei nostri giorni. Anche certi gruppi, che non hanno seguito le vie indicate nel Manifeste, procedono secondo identici poli di attrazione e rifiuti.
Una delle caratteristiche principali dello spirito surrealista è la sua avversione nei confronti dello scetticismo. Anatole France ne è un esempio tra i più detestabili: non è in un’epoca come la nostra che si può accettare l’immoralità delle opinioni di un Jérôme Coignard. Il personaggio è assai seducente, ma bisogna convenire che agli uomini che si sono formati durante gli anni terribili della guerra europea e della Rivoluzione russa serve ben altro che le boutades di questo abate egoista, codardo e gaudente che non crede neppure in Dio. Drieu La Rochelle tratta da vecchi furbi dissoluti Bergeret, Coignard, Bonnard, tutti figli del vecchio Anatol France, i cui tratti riproducono così bene quelli del padre. Un padre “incapace tanto di sconfitte definitive quanto di vittorie complete”, che ha flirtato con la filosofia, con l’amore, con la politica, con il comunismo, uscendo di scena tempestivamente senza essere arrivato in fondo a nulla. Ci diranno che è stato il nostro Voltaire (l’ha detto Joseph Delteil), ma noi non abbiamo bisogno di Voltaire. Abbiamo bisogno di uomini come Rousseau, come Bonaparte, come Robespierre… Il manifesto intitolato Un cadavre, pubblicato dai surrealisti dopo la morte dello scrittore de La Bachellerie, rappresenta il più perfetto funerale di prima classe che un’intera generazione abbia mai celebrato a un glorioso maestro nazionale. I giovani non risparmiano coloro che vivono senza lasciare una fruttuosa scia di inquietudini.
In virtù della loro avversione nei confronti dello scetticismo, i surrealisti condannano gli aspetti rappresentativi di ciò che si è soliti chiamare “il genio francese”, incarnazione della chiarezza, del sorriso ironico, della leggerezza e del tatto. Il Traité du style e la prefazione a Libertinage di Louis Aragon sono atti di accusa contro tale “genio”. Non sono, secondo i surrealisti, né Voltaire, né Molière, né Verlaine che incarnano il genio francese, ma i grandi ribelli, i non conformisti, gli innovatori in lotta aperta contro la società e il pensiero della loro epoca: Rimbaud, Lautréamont, Aloysius Bertrand, Jarry, Baudelaire, Gérard de Nerval, Germain Nouveau…
Mi diceva Desnos:
Quando diciamo di amare il romanticismo, il pubblico crede che de- sideriamo far rivivere salici piangenti, chiari di luna e castelli in rovina, senza comprendere che quel che troviamo bello in uomini come Benja- min Constant e Byron è il dinamismo che li anima, la loro tendenza ad avere una vita pericolosa, la loro coraggiosa propensione a giocarsi il tutto per tutto.
Il culto della ribellione ha origine in un furioso desiderio di indipendenza. “Solo la parola libertà è ancora in grado di esaltarmi”, afferma Breton nel suo Manifeste.
Fra le molte disgrazie che abbiamo ereditato, bisogna riconoscere che ci è stata lasciata una grandissima libertà di spirito. A noi di non metterla a repentaglio. Ridurre l’immaginazione alla schiavitù, anche se a vantaggio di ciò che si chiama volgarmente felicità, significherebbe sfuggire a quel senso di giustizia suprema che si trova nel profondo della nostra anima.
In una pagina del suo libro Breton riporta la descrizione di una camera tratta da un romanzo realista. Alla povera fotografia non manca nessun dettaglio: il colore della carta da parati, la decrepitezza dei mobili, un divano, la toilette, alcune sedie. Breton scrive:
Non sono nello stato d’animo di riconoscere come lo spirito si prefigga, sia pur in modo passeggero, simili propositi. Si sosterrà che tale esercitazione scolastica è perfetta e che in questo passaggio del libro l’autore ha le sue buone ragioni per affliggermi. Continui pure a perdere il suo tempo, tanto io non entrerò nella sua camera. La pigrizia e la stanchezza degli altri non mi attraggono. Ho della continuità della vita una nozione troppo instabile per porre i miei migliori minuti sullo stesso piano degli istanti di depressione e di debolezza. Desidero che si taccia quando si cessa di sentire.
“Diciamocelo una volte per tutte (aggiunge Breton qualche pagina più in là): il meraviglioso è sempre bello; tutto il meraviglioso è bello; soltanto il meraviglioso è bello”. E dove cercare il meraviglioso se non in noi stessi? In fondo alla nostra immaginazione, capace di creare nel senso più pieno del termine? Il grande precursore del surrealismo è stato Lautréamont, la cui immaginazione fece nascere le pagine prodigiose dei Canti di Maldoror. Scrive Breton in Les Pas perdus:
Per Ducasse l’immaginazione non è più quella sorellina astratta che salta la corda nel parco; voi l’avete fatta sedere sulle vostre ginocchia e avete letto nei suoi occhi la perdizione… Non si sa quel che vuole; vi fa coscienti di molti altri mondi, tanto che ben presto non saprete più come comportarvi in questo… La verità, da Ducasse in poi, non ha più un dritto e un rovescio…
Il nostro sforzo creatore, di conseguenza, deve tendere a liberare l’immaginazione dalle sue pastoie, a scavare nell’inconscio, a far sì che il nostro io più autentico si manifesti nel modo più diretto possibile. Da qui le esperienze sorprendenti compiute da Robert Desnos, Man Ray, Soupault, Breton e altri attraverso la “scrittura automatica” – scrittura estremamente rapida e priva di un tema predeterminato –, destinata a far sprofondare il soggetto in uno stato di esaltazione ispirata, favorendo la “dettatura del pensiero, al di là di ogni preoccupazione estetica o morale”. Da qui l’interesse e la passione con cui i surrealisti, come Sigmund Freud in Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, seguono le tracce di ciò che li conduce a toccare il nocciolo del mistero poetico. Da qui la definizione di surrealista applicata a Swift – “surrealista della malvagità” – o al Marchese de Sade, “surrealista del sadismo”.
Una volta accordate tutte le libertà all’immaginazione, l’immagine si rivela di una dimensione, di una luce e di una novità insospettate. La poesia galoppa vertiginosamente in sella alle immagini – particelle di infinito – che solo i surrealisti hanno saputo creare con tanta audacia e in così gran numero. Le loro poesie ci mostrano un mondo di meraviglie le cui porte solo ora si aprono alla nostra sensibilità. Gli oggetti più lontani, uniti in una danza cosmica, trovano legami inattesi. I paragoni più insoliti diventano possibili. L’ordine naturale è alterato. La dimensione magica reclama i suoi diritti. La Sfinge divora Edipo. La pietra filosofale esiste. Tiresia provoca il fallimento dell’Agence Havas, la più antica agenzia di stampa.
E un pittore come Giorgio de Chirico – precursore del surrealismo – ci dice:
Bisogna liberare l’arte da tutto ciò che contiene di conosciuto; ogni argomento, ogni idea, ogni pensiero, ogni simbolo dovrà essere lasciato da parte affinché le cose appaiono sotto una luce nuova, come consacra- te da una costellazione avvistata per la prima volta.
I pittori surrealisti – Masson, Ernst, Miró, Malkine, Picasso – sono i primi ad adottare, dopo gli artigiani dell’Età della pietra, la fiera divisa stampata sui cataloghi delle mostre di Man Ray: “C’è qualcosa di nuovo sotto il sole”.
Dal suo studio di rue Fontaine – vicino al Cabaret de l’Enfer – circondato dai suoi meravigliosi dipinti, dalle sue statue africane e dalle sue sculture maya, André Breton ha appena pubblicato un libro di magia contemporanea; un libro pieno di mistero; un libro nutrito dalla fede in una realtà superiore: Nadja.
E dire che alcuni parleranno ancora dello scetticismo delle nuove generazioni!
“Social”, La Habana, 1928
***
ATTUALITÀ DEI CLASSICI
Quando il bisogno di sapere quel che si scrive oggi nel mondo si fa meno pressante – perché nessuna opera attuale suscita in noi una curiosità immediata – ritorniamo ai nostri classici con il sentimento di ritornare a una terra che ci appartiene. Tuttavia, non sono tanto i loro precetti o i loro insegnamenti – quel che Rabelais chiamava “la substantifique moelle” – che ci attirano, quanto l’impressione che i secoli alle nostre spalle non siano davvero trascorsi, che le date si siano succedute senza aver realmente influenzato l’unità dell’uomo e che, a ben guardare, coloro che hanno vissuto nel XVI e nel XVII secolo non sono tanto diversi da noi. Così, di riflesso, quel classico che è diventato Ludwig van Beethoven ci dice nei suoi Quaderni di conversazione che nel 1820 a Vienna si parlava di cose piuttosto simili a quelle che interessano oggi i nostri contemporanei e che la Santa Alleanza, che faceva infuriare tanto gli amici intimi dell’autore della Nona Sinfonia, non era che il nuovo collare di quello stesso cane che, legato ad altri collari, aveva morso durante i secoli precedenti un enorme numero di uomini e avrebbe continuato a morderne ancora molti nel corso dei secoli a venire.
*
Rileggendo questo fine di settimana Il diavolo zoppo (parlo, naturalmente, dell’edizione del 1641), sono rimasto stupito nel ritrovare Luis Vélez de Guevara così attuale e vivace. Non solo a causa della prodigiosa plasticità del suo stile e della forza satirica dei suoi giochi di parole, ma anche per le cose che dice. Non sono solo sbalordito che a un certo punto affermi che ogni volta che scoppia una rissa sono sempre gli stranieri che finiscono per avere la meglio e brindare, né che, a proposito degli asparagi, affermi che “sono legumi che sopportano così poco la compagnia che si riuniscono solo per essere venduti”, ma piuttosto perché devo rileggere tre volte lo stesso passaggio per convincermi che il dialogo che segue non sia stato scritto per noi nel Secolo d’Oro del romanzo picaresco: “Dimmi, che notizie ci sono della guerra? – Oggi non c’è che la guerra! – E contro chi, dimmi? – Contro il mondo intero!”, conclude Don Cleofa, compagno di strada del Diavolo zoppo.
*
Una strada che li condurrà a Siviglia. Una Siviglia decorata, piena di addobbi, trasfigurata per colui che all’epoca veniva dall’America, da dove tutte le strade portavano alla Casa de Contratación de Indias. La città di Siviglia era diventata “lo struzzo dell’Europa, in grado di digerire […] qualsiasi oggetto d’oro o d’argento venuto dalle Indie”. Una città in cui i mambos e le guarachas, recentemente inventati nel Nuovo Mondo, si chiamavano (cito Vélez de Guevara): sarabanda, ciaccona, zambapalo, guineo e colorín colorado che si suonavano con campanelli, nacchere e caracoles e che avevano molti punti in comune con il repertorio dei suonatori di maracas di colore o indios che cantavano nelle nostre regioni. E come se non bastasse – come se l’uomo di ieri non fosse abbastanza simile all’uomo di oggi, alle sue manie, alle sue mode, alle sue sciocchezze e alle sue trovate – una strana moda era nata all’epoca a Siviglia, del tutto analoga all’uso dei pachucos messicani o dei classici cucheros cubani: si trattava di una “scarpa ponlevi” (dal francese “pont-levis” che significa “ponte levatoio”), estremamente appuntita e con i tacchi molti alti, nonché dotata di un farsetto le cui alette erano fornite di fessure. Gli uomini spesso passeggiavano per la città piacevolmente accompagnati da una di quelle graziose mulatte che faceva gridare allo scandalo i visi- tatori della Torre Giralda perché indossava un paio di “scarpini senza calze”.
E quando Vélez de Guevara ci parla di un alchimista alle prese con un bollente “crogiolo pieno di mille ingredienti diversi”, la storia del “crogiolo” ci avvicina ancora di più a quelle Indie a cui si riferisce tante volte il Diavolo zoppo nella sua picaresca avventura terrestre.
Letra y Solfa, “El Nacional”, Caracas, 1952
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente






