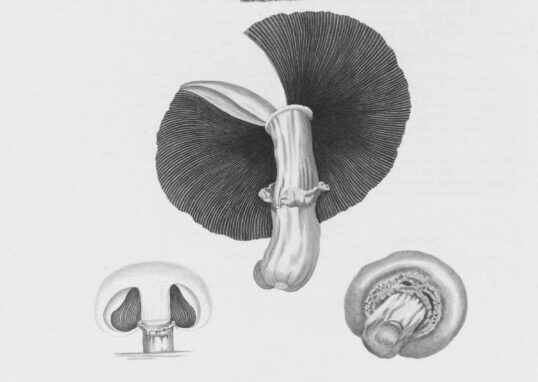di Mariano Croce e Emilia Margoni
Si provi come per gioco a isolare un qualsiasi evento della nostra vita, come se potessimo ritagliarlo nei suoi contorni, nelle sue dinamiche e nei suoi effetti, privo di annessi, connessi e implicature con un altro qualsivoglia evento che l’abbia preceduto o seguito. Un evento minimo, s’immagini, come quello in cui, qui ed ora, mentre scriviamo, ci si trova faccia a becco con un membro di quella specie di columbide assai diffusa che chiamiamo “piccioni” – denigrati, e non a torto, perché vettori di malattie infettive e parassiti d’ogni sorta – e che, per questo colti da un’istintiva ripugnanza, con vistosa angoscia si prenda a battere piedi e mani per allontanarlo. Ecco: se davvero noi si provasse a isolare quell’evento, ci troveremmo nelle ambasce, finanche se volessimo assegnare a noi stessi le proprietà prodigiose e superne di chi fa letteratura e accordarci così il diritto di definire dove inizia e dove finisce una data storia.
Ci troveremmo nelle ambasce perché vita e letteratura si rassomigliano per una comune e ferma avversione ai confini netti. Allora ci troveremmo nel pantano vischioso di quell’intrico di cause e concause che in quel determinato giorno a quella determinata ora ci ha portato a compiere quella determinata scelta – scelta che non capiremmo né sapremmo mai dire che senso avesse, ora come allora, se non ne cogliessimo la relazione con altre scelte, non meno legate alle scelte che l’hanno preceduta e la seguiranno. Ci troveremmo a sbastire e imbastire una rete di cui saremmo dolosi artefici e al contempo vittime, a meno che davvero non si fosse dotati della capacità prodigiosa e superna di far letteratura – caso che, per certo, non è quello di chi qui scrive. E allora, di due persone intente a scrivere che battono mani e piedi per scacciare un piccione si dovrebbe dire perché sono dove sono e perché sono andati proprio lì, il che spiegherebbe pure perché il piccione sia renitente alla fuga, dato che ai suoi occhi aragostati i residui del croissant da poco consumato valgono il rischio che pure corre.
Ma non si è cominciato in questo modo questo scritto per intonare le lodi del cosiddetto determinismo – concezione filosofica dalle alterne ma sempreverdi fortune – quanto per giustificare il perché e il percome un certo libro ci abbia convinto, ma solo in parte. Si tratta di un libro, assai commendevole negli intenti e nel registro, del noto divulgatore scientifico Ananyo Bhattacharya. È dedicato a una figura che, insieme ad altri pezzi pregiati del canone scientifico novecentesco, oggi va riconquistandosi le luci della scena, troppo spesso ingrigita dalla fama di costruttore di ordigni nucleari. Bhattacharya scrive di John Von Neumann per mostrare come egli sia da collocarsi fuori del suo tempo, forse di ogni tempo, come chiarisce sin dal titolo: L’uomo venuto dal futuro. La vita visionaria di John von Neumann, tradotto da Luigi Civalleri e appena uscito per i tipi di Adelphi. Ma ne scrive anche per riconquistarlo a un’araldica meno cenerina che non quella del fanatismo anticomunista a caldeggiare l’uso spavaldo della bomba atomica.
Nato nel 1903 a Budapest, città vivace e florida della Cacania, da una famiglia di ebrei borghesi, colti e benestanti, nei primi anni della sua formazione von Neumann poteva contare sul prezioso apporto di abili precettori privati. Dopo il liceo, nel 1921, si trasferiva a Berlino per iniziare un percorso di studi in chimica su pressione del padre, preoccupato delle ricadute concrete del tipo di scienza che avrebbe maneggiato il figlio. Ma l’interesse principale del ragazzo, sin dalla più tenera età, era la matematica, con particolare fascinazione per gli studi sulla geometria legati alla figura numinosa del matematico tedesco David Hilbert. Questi intendeva ricostruire daccapo le fondamenta della matematica, scosse dall’insorgere degli studi sulle geometrie non-euclidee, come pure da una serie di paradossi palesati, tra gli altri, dai lavori del filosofo inglese Bertrand Russell. Nel 1928, Hilbert stese un ambizioso programma: dimostrare che la matematica era completa, coerente e decidibile. Sebbene tanto temerario programma sarebbe presto stato oggetto di pubblica esecuzione per mano dell’umile ma risoluto Kurt Gödel, matematico e logico austriaco, con un articolo del 1925 von Neumann contribuì a risolvere almeno i paradossi del tipo segnalato da Russell.
Ma come a voler soddisfare le aspirazioni del concretissimo padre, von Neumann passò presto agli esiti empiricamente rilevanti della matematica. A Gottinga, dove Hilbert era di stanza, egli venne in contatto con Werner Heisenberg, giovane rampante della fisica nuova, che nel 1925 aveva proposto il primo modello rigoroso della teoria dei quanti, oggi denominato “meccanica delle matrici”. Quando nel 1926 von Neumann giunse nella città tedesca, la meccanica delle matrici era appena entrata in competizione con una formulazione alternativa, basata su un’idea del mondo opposta a quella heisenberghiana e nutrita da una filosofia con questa inconciliabile. Si trattava della “meccanica ondulatoria” del fisico austriaco Erwin Schrödinger. Ambo le formulazioni avevano per obiettivo quello di spiegare alcuni fenomeni di interesse su scala microscopica, e in particolare il comportamento degli elettroni all’interno delle strutture atomiche. Mentre la meccanica delle matrici di Heisenberg prevedeva dei salti repentini e improvvisi di tali elettroni da una posizione a un’altra, la meccanica ondulatoria postulava che a ognuno di essi venisse associata una funzione d’onda, caratterizzata da un’evoluzione continua, priva di interruzioni. Quel che più sorprendeva è che, in barba alle enormi differenze di merito e di metodo, le due formulazioni sembravano parimenti adatte a descrivere il comportamento elettronico. Grazie al talento unico di von Neumann, che mise a frutto la matematica sviluppata dal suo maestro Hilbert, si poté comprovare l’equivalenza di tali formulazioni. In questo modo, venne delineandosi una prima cornice teorica stabile ed efficace entro cui collocare la novella teoria dei quanti, che tanta influenza avrebbe esercitato sulle generazioni future e sul loro mondo.
Insomma, non ancora trentenne, von Neumann si era garantito il ruolo di enfant prodige delle scienze dure sulla scena mondiale e mantenne fede a questa immagine sacralizzata producendo una serie di stupefacenti lavori sui fondamenti della logica, la teoria degli insiemi, la teoria dei gruppi, la teoria ergodica e la teoria degli operatori. Eppure, più che la fisica quantistica, fu il destino tragico dell’Europa a consacrarlo come il perno di ogni rivoluzione tecnologica futura. Nel 1929 tenne una lezione sulla teoria dei quanti a Princeton, dove fu guest professor dal 1930 al 1933, e al termine di tale periodo fu assunto tra i primi docenti dell’Institute for Advanced Study di Princeton. D’altro canto, quello era l’anno fatale in cui ebbe la certezza di non poter tornare in Germania: nel marzo del 1933, il partito nazionalsocialista aveva completato la sua scalata al potere, che di lì a poco avrebbe provocato il più vasto esodo di figure intellettuali della storia mondiale.
A Princeton von Neumann fece presto a ricamarsi le trame d’una leggenda, riconosciuto com’era quale istanza ultima di giudizio su ogni questione che inerisse ai numeri in pressoché ogni ambito delle scienze dure. Ma gli effetti delle sue teorie matematiche avrebbero presto avuto un margine di incidenza ben più ampio e funesto. Arruolato tra le celebri menti del Progetto Manhattan, A Los Alamos, nel Nuovo Messico, si dedicò in particolare al progetto di implosione del fisico statunitense Seth Neddermeyer, secondo cui una sfera cava contenente plutonio fissile doveva venire fatta implodere simmetricamente, per spingere il plutonio in una massa critica al centro. Von Neumann calcolò che una “lente” di esplosivi chimici, in modo analogo a lenti ottiche che deviano la luce, avrebbe permesso una combustione più efficace. Questo il modello su cui si sarebbe ultimata “Fat Man”, la bomba sganciata alle 11:02 del 9 agosto 1945 sullo stabilimento Mitsubishi della città di Nagasaki. Constatata l’indiscutibile efficacia della bomba in termini di deterrenza, von Neumann si fece promotore di una strategia della minaccia nucleare che potesse ridurre a più miti consigli i dittatori di ogni dove.
Negli anni del dopoguerra, come illustra un altro fortunato libro, Maniac, di Benjamín Labatut (Adelphi 2023), von Neumann contribuì con intuizioni dirimenti alla creazione del computer dell’Electronic numerical integrator and computer (ENIAC), uno dei primi computer elettronici digitali della storia. Di lì si giunse poi al Maniac (acronimo che sta per mathematical analyzer, numerator, integrator, and computer), perfezionato nel 1957. Al netto dell’auto-ironia, come nota Labatut, nell’acronimo si intravvede l’ombra irrequieta del genio che aspirava a superare il limite divisorio tra l’essere umano e la macchina: von Neumann ambiva a produrre un’entità dalla potenza di calcolo ineguagliata, libera finalmente dalle debolezze della natura umana e dalle facezie emozionali che l’affaticano.
Di ognuno di questi passaggi entro i più diversi campi del sapere, capitolo dopo capitolo, L’uomo venuto dal futuro offre un resoconto dettagliato, intrigante, agevole da seguire anche per chi abbia competenze appannate in fatto di scienze matematiche e naturali. I particolari sulla discussa vita privata di von Neumann e sui suoi gusti eccentrici, certo accennati, vengono felicemente sacrificati per indugiare piuttosto sui dettagli tecnici dei suoi numerosissimi contributi. Questo in parte restituisce un ritratto più ricco e vivo di un autore spesso affrescato in toni grigi quale falco tra i falchi in tema di deterrenza atomica; come uomo diplomatico e affabile ma puntualmente egoista; come scienziato intento a spingere agli estremi ogni teoria per la maggior gloria della teoria stessa, a discapito, in più d’un caso, della carriera di qualcuno o della vita di qualche milione di persone.
Quel che al libro manca, però, è l’intreccio di vite e di idee, solo sbozzato nelle numerose ricostruzioni di fatti ed eventi. Emerge pienamente il genio, che spunta miracoloso dal ceto pur agiato della borghesia ungherese e soverchia passo passo ogni suo potenziale interlocutore, perché vede “oltre la superficie delle cose” (36). S’intravvede del pari una personalità iridescente perpetuamente ostile a sé stessa, preda del conflitto tra la spinta al superamento d’ogni limite e la consapevolezza dei rischi insiti nell’abbattimento delle frontiere. Un uomo disilluso, alfine, che sperava “vincesse la parte migliore delle persone e cercava di essere il più magnanimo e corretto possibile” ma a cui “l’esperienza e la ragione […] avevano insegnato a non riporre troppe speranze nelle virtù umane” (369).
Ma se l’obiettivo di Bhattacharya, oltre a quello, centratissimo, di informare con meticolosa cura, era creare un legame tra quel genio fuori tempo e chi legge, maggiore attenzione all’intrico di cui sopra avrebbe forse giovato. Quell’enorme alveare costituito dalle donne e dagli uomini di genio della cultura scientifica novecentesca è ritratto come una serie di incontri fortuiti entro quadri isolati in sequenza: von Neumann trova Hilbert; von Neumann battibecca con Dirac; von Neumann s’imbatte in Shapley. L’intrico ne esce inanimato, come gli esseri umani immaginati nei modelli dell’azione razionale teorizzata da von Neumann nei suoi lavori sulla teoria dei giochi. E così il protagonista davvero sembra uscire da un altro tempo, come se il suo genio lo separasse per spessore e portata dal suo sfondo di vita concreta.
All’opposto, molte delle più significative scoperte del Novecento sono pienamente incarnate nella storia convoluta di quel dolente secolo, in cui ogni idea, sia questa provenuta da genio o da criminale, ha antecedenti, retroscena e conseguenze, con quest’ultime pronte a fare da antecedenti per altre idee. Forse è per questa carenza di elemento, per così dire, relazionale, che la narrazione di Bhattacharya, cristallina ma snodata per intero attorno al prodigio, non riesce del tutto nell’intento di riscattare un personaggio che la storia della cultura ha catalogato tra i protagonisti in negativo. Se ne ricava così un libro che fa piena giustizia al suo titolo, e che già solo per questo ci sentiamo di raccomandare toto corde, perché dettaglia con acribia dove e come nella nostra vita presente si possa scorgere “ovunque l’impronta di Johnny” (17).
Eppure, del libro ci piace immaginare un’anima tacita, ma più profonda e vitale, quella in cui si capisce come e perché von Neumann sia stato un uomo del suo tempo, che, pur nel suo ineguagliato ingegno, come ogni essere umano prende in prestito linguaggi e li restituisce poi ai suoi simili. E che, come ogni essere umano, sia via via concrezione di eventi e sede di ingegni collettivi. Ma, per piena onestà, a favore dello stile scelto da Bhattacharya, mette conto notare che a von Neumann un taglio più attento all’individuo come incontro e relazione non sarebbe poi piaciuto. Con tutta probabilità, avrebbe apprezzato L’uomo venuto dal futuro nella sua attuale forma, se è vero che, come scrive il suo biografo Norman Macrae, una delle definizioni di studioso dal Nostro più amate era la seguente: “Persona che mai firmerebbe manifesti in cui figurino emozioni comuni”.
Mariano Croce insegna Filosofia politica presso Sapienza Università di Roma. Si occupa di critica sociale, postcritica, battaglie LGBTIAQ+ e politiche della trasformazione sociale.