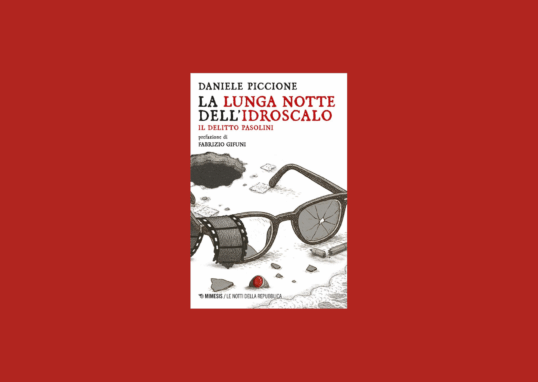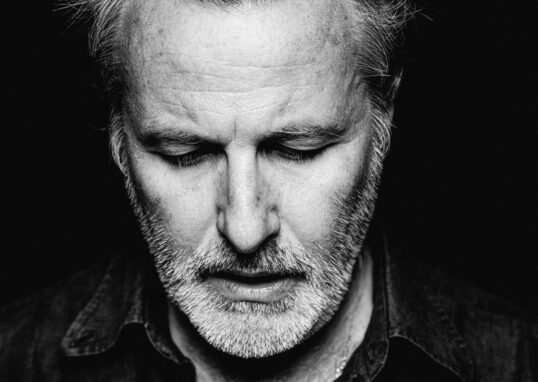G.B.: Saudade, l’ultimo libro di Mariapia Quintavalla (Puntoacapo editrice, con la prefazione di Giancarlo Sammito), già dal titolo si appella a una sensazione generale e astratta quanto precisa, inclusiva, dirompente. Nostalgia, rimpianto, malinconia, relazione con l’assenza (del referente che, in primis, è l’io medesimo che constata la propria incertezza), con note folcloristiche, quindi fortemente antropologiche, originative, ancestrali. Un sentimento che si può estendere a tutto il contemporaneo, decurtato (ma forse non del tutto) dei toni teneramente struggenti del primo romanticismo, e poi di quelli tremendi del tardo romanticismo, e del crepuscolarismo a seguire.
La prima sezione, “Casi del mondo, case dell’amore”, si apre con questo verso: “C’è bisogno degli altri, come di un’illuminazione”: non a caso, l’autrice di lunghissima esperienza poetica e letteraria tout court, inizia il suo libro con un bisogno collettivo e di collettività, di villaggio, di adunanza, di relazione. Un bisogno che è come una luce in fondo al tunnel che illumina, rischiara, chiarisce. Un tunnel di storia, di catastrofi sociali e personali, di disallineamenti emotivi. Una malinconia, appunto, di qualcosa che non è mai esistito, di un essente impossibilitato, di una convergenza impossibile. Lazzaro verrà fuori dalla sua malattia, dal male dell’umanità che è l’umanità stessa, la mortalità? Oppure, l’attesa si dimostrerà paradossalmente beckettiana e la vita trascorrerà invano, aspettando “l’incarnazione dell’amore” post-cristica, post-divina e profondamente umana, biologica?
Eppure, la poetessa ama il suo presente, si sente casa del mondo, rifugio di desideri e aspettative. “I miracolati” vivono e sopravvivono al riparo del sacro (le chiese, e dio, ricorrono pur sembrando emblemi delle paure dell’individuo), nella speranza che “da un amante piccolo possa svegliarsi/un sogno grande”.
Se la poesia non cambierà il mondo, come ha ironicamente affermato Patrizia Cavalli, cosa rimane di inscalfibile nella parola poetica, oggi, alla quale si affidano desideri e preghiere collettive?
M.Q.: Forse si continua ad attingere alla sua segreta natura, che è energia pura. L’ombra sottile che le due facce del verso disegnano, nido di senso – suono, ombra l’una dell’altra.
Irretire la gestualità della parola, la sua tonalità di suono, al pensiero, alla ricerca del parlato/scritto: esiste una traccia ematico-biologica, un’oralità umana che ogni parola trattiene, e restituisce, riportandoci qualcosa di quell’acqua nativa che l’ha generata: lingua materna sacrale, ricevuta alla nascita. Nasciamo parlanti.
La vita, fin dai miei primi libri, si è mantenuta nella postura di una “differenza”, e nella sua nudità esposta (nella trilogia giovanile, da Il Cantare, a Lettere giovani, a Le Moradas).
*
G.B.: È dal corpo che parte tutto. Un corpo “che trascende” (benedetto), che “rende l’amore/ una tangibile cosa”, che riesce a fare cose che non si sono fatte (“coglie rose che non cogliemmo”) – con un ulteriore paradosso ontologico che sembra sfidare le leggi della natura per un concetto di naturalezza superiore, eppure immanente. Una naturalezza perturbata “dall’era digitale” che, invece di unire in uno stream di dati (e non più di coscienza), divide e allontana gli amanti, ricongiunti per avventura nel ricordo.
A volte, la parola si scompagina. Non diventa rarefatta, non rinuncia al discorso e alla consecutio, non diventa incomprensibile: le lettere si allontanano nello spazio tipografico, è uno spazio tra i suoni, un rumore bianco che accompagna la prosodia, ne crea brevi sospensioni.
Il libro, d’altronde, viene “trattato” dall’autrice come una persona, un parente, un amico, un amante, a cominciare dal modo in cui lo nomina, lo chiama come si fa con qualcuno da cui ci si aspetta una risposta.
Dopo tanti decenni di attività letteraria, ci descrivi il tuo rapporto con i libri pubblicati e quelli futuri?
M.Q.: Beh, accade come con l’esistenza: occorre una vita per imparare a capire qualcosa, ed è sempre poco. Secondo Andrea Zanzotto, la mia scrittura cerca sempre di produrre un cambiamento di vita, sia in me che in chi legge. Oltre “una stretta di mano”, una appartenenza di genere universale, di specie varie che si incontrano.
Come mi sono relazionata, nelle epistole “per sempre” giovani, all’ebbrezza e alla meditazione, al bisogno di ordine, un ordine sia dionisiaco che apollineo? Erano alfabeti, lettere nascenti da una stagione totale, giovane, cortocircuiti sprigionati tra soma e mente in un poiein magico che sta sospeso e poi cade in precipitato, in una concrezione chimica che si incolla in ritmo e ritorni, diventa lingua che non sapevamo.
Tutto ciò era parte di noi? O eravamo messaggeri di ALTRO, di aerei pensieri?
Dopo il tempo che si è fermato, alla morte dei genitori, si è imposto un altro ordine: un ordine del tempo “lungo”. Sono le passeggiate – con il pittore Correggio – che portano me e il padre, scegliendo come guida i Compianti della sua pittura, a ricondurci in un tempo circolare, “nostro”. Saranno le foto/poemetti di Album feriale, o le brevi storie di Gina / China, tra città e pianura, che ci porteranno in esistenze precedenti, come le lettere ai non nati, o ai nati nei secoli che ci generarono, precedendoci.
Senza rivisitare il mito, le nostre storie appassirebbero in una ridotta visione del reale, una visione miope, dispersa nella domanda interiore di un epos minimo. E, così, nasce Quinta vez, storia dei finali diversi della vita di China. Prima ci fu Corpus solum, poi Vitae, un viaggio verso la prosa.
Ma la storia non è esauribile nella morte, risiede nella diaspora che prosegue, nel pensiero che si trasmuta, e questo mistero costeggia il nulla, l’imponderabile dell’opera Le moradas.
I libri futuri mi stanno cercando, è evidente, ed io sono in ascolto: si allungano verso regioni nuove in poesia, e in prosa, ma sempre secondo un passo di densa poeticità.
*
G.B.: In copertina, è presente l’opera Naufragio di Alfonso Filieri. Un’immagine che richiama la foglia, l’innervazione biologica della vita, il transito. Ci parli del rapporto tra questo disegno e la tua opera?
Sono sincronie che il cosmo ci assicura di spargere. Io non conoscevo Filieri, prima delle sue mostre a Mantova poesia, né lui la mia opera: la poesia ha creato questa sottotraccia, così come nelle venature della foglia ramificata possiamo vedere la mano della Creazione un creatore. Il titolo è Naufragio.
*
G.B.: “La splendida pace che l’acqua/ci ha insegnato” è come una ratifica dell’esternalità del concetto di pace nell’uomo che non può che apprenderla dalle cose di fuori, introitarla con desiderio – e non si può non pensare all’idea di conflitto e sopraffazione innata di cui parla Simone Weil. Così, il corpo dell’uomo rinasce “come la salvezza”: ancora, compare la nostalgia di qualcosa che non si ha, che non si è.
“Sto qui, nel testo, non cerco il referente esterno”, affermava Angelo Lumelli, come riportato nella prefazione. E, in effetti, anche nei testi apparentemente erotici, il tu è una chimera, parla con la voce dell’io, lo personifica, gli concede dignità d’esistere.
“Non vedo l’ora di toccarti, / dai genitali agli occhi” è una preghiera laica, una disperata ricerca di materia (e non materialità), uno scandaglio della “vera superficie” che risiede nella comunione della separazione – che qui non è un paradosso ma quanto di più tenero e straziante si possa immaginare.
Sono oscure le parole al cospetto dell’amore, tremano degli spasmi della carne, vivono appena.
Come ti relazioni con il referente nella tua poesia?
M.Q.: “Esiste la deliziosa prossimità, non / il perfetto amore”, scrivo ne Le Moradas.
Deleuze dice che le singolarità sono i veri eventi trascendentali, la quarta persona del singolare. Eppure, io mi sentivo come “un io plurale”.
Si può assurgere a una dimensione corale, in un habitat della mente? È la mia ricerca.
Questa saggezza pertiene all’inconscio e ai versi stessi, io non potrei deciderla da sola, si tratta della mia aderenza innamorata alla vita e al reale che ha spasimato tanto, per poi sciogliersi in dolcezza, arrendersi.
*
G.B.: Il testo dedicato alla dodicesima casa astrale, l’ultimo stadio del cerchio zodiacale che vede gli orizzonti più vasti, chiamata anche casa del “sublime” (concetto leopardiano collegato anch’esso alla nostalgia, alla bellezza che si fa evento terribile, fenomeno inaccessibile), afferma che si tratti di “uno spazio ospitale”.
Può il sublime contemporaneo essere un luogo in cui ancora abitare?
M.Q.: La dodicesima casa è la casa dell’infinito secondo le cabale astrologiche, l’ultima del ciclo astrale. Occorre pensare intanto a ciò che calpestiamo ogni giorno per invocare, costruire quella conversione di civiltà che lo stato delle cose sta imponendo. Siamo stati reclusi, e siamo belligeranti oggi, in ogni parte della Terra, senza averne piena coscienza. Non possiamo consistere nella incoscienza.
Anche se è terribile, la bellezza e il non finito devono essere pensabili: poeticamente abita l’uomo. Maria Zambrano dice: “Nessuna tenebra, per quanto fitta, fa disperare che una qualche luce, o qualcosa delle luce, possa penetrare in essa.”
Io sono passata dall’orfanezza affidatami dal destino a territori dove il bene può essere insegnato, testimoniato, portato in alto: l’amore per gli altri esseri, anche amore anti-specista in una visione altra, non antropocentrica. L’esperienza del Nulla e di Dio, durante la fraternizzazione con il mondo, ci ha preparato: “Pensate ai neri budda che eravamo/ donneunuchi neri androgini / maschere vive e sante / ma soprattutto magre / magri cavalieri moderni”.
*
G.B.: Ricorre l’aggettivo “struggente” come un’anafora emotiva, un refrain che immortala l’incanto insito nel dolore, lo strazio del quotidiano osservato da un continuo migrare.
Nella sezione da cui è tratto il titolo dell’opera, la solitudine appare come incompiutezza (“l’eterno tutto/insepolto”) e distruzione per mancanza di cura. Il linguaggio diventa più intimistico, le ricorrenze lessicali e le immagini formano chiasmi, traiettorie di pensieri.
La figlia, figura archetipica, mitologematica, spirituale e, insieme, concreta e reale, fa da contraltare all’io dicente. Così, si alternano e sembrano essere contemporanee e fungibili le scene quotidiane con quelle più orfico-metaforiche in cui il tempo si mischia, diventa un flusso sincronico di fasi esistenziali non assolute, finalmente relativizzabili: “lavava i giorni del passato nell’acqua del futuro”.
Il verso ipermetro imprime l’andamento di una prosodia “tutta d’un fiato”, quasi opposta agli spazi bianchi tra lettere che, per altro, continuano ad apparire quando l’autrice impone una tregua al suono.
Temi e suggestioni sembrano mettersi in relazione con molte poetiche femminili del secolo breve:la speculazione spirituale, perennemente dubitativa, di Margherita Guidacci, le metafore profondamente terrene di Goliarda Sapienza, la malinconia gioiosa e insieme devastante di Alda Merini.
I riferimenti al linguaggio, e in particolare a quello della poesia, sono disseminati lungo tutto il libro, come a sancire un parallelo discorso sulla lingua, sul lessema, sulla particella intonativa di ogni espressione.
Che ruolo ha, per te, la poesia sulla poesia?
M.Q.: Io credo che sia un ruolo involontario. Credo che il poeta, a un certo punto, pensi ad alta voce quanto stia operando con la lingua poetica, e che così escano versi esplicativi. Io lo affermo in questo modo: “fiaccola concreta”, “Differenza”, “donne alberi rosa”, “mite mare”, “sottomarini a noi stessi”, “forma zolla” etc. Sono personificazioni della poesia. Ho scritto a partire da poesie di poetica, non mai da un discorso meta-semiotico.
*
G.B.: Il corpo si riappropria della propria animalità, si ammala, si consuma attraverso le relazioni filiali, è il ritratto dell’anima in pena che lo abita, della vita che lumeggia a fatica tra i venti. Un “corso amico della storia” accompagna le torsioni dell’esistenza individuale, i lutti, gli addii, gli incontri mancati.
La poesia non smarrisce la sua possibilità di essere l’opera aperta dell’uomo, un diario di cammino che non finisce, radice intimista di un discorso plurale.
Ma non è solo poesia questo libro. Le prose irrompono sulla scena, nominate, annunciate proprio per fare differenza con la prima parte dell’opera.
Prose che non interrompono, però, l’andamento lirico, non lesinano figure retoriche e segmentazioni del discorso, concedendosi a temi civili.
Cosa sancisce, per te, formalmente e concettualmente, la differenza tra la tua poesia e la tua prosa?
M.Q.: Il tempo e lo spazio si ripopolano, a mano a mano scorrono davanti e non solo dentro di noi. La verità soggettiva è il migliore antidoto al disordine, a un certo punto non ci si accontenta più del visibile. La dismisura, per esempio, cioè la confidenza con il divino, escono dall’incontro con la morte di chi ti è prossimo. Mia madre se ne è andata cantando Bella ciao; mio padre dopo avere recitato a memoria Pascoli, mentre era al telefono con la nipote. Cantavano perché si sentivano abbandonati, oppure ricorrevano a quei mantra per ricordare a memoria verità importanti.
Ecco dove si muove l’energia di respiro che renderà necessaria la narrazione nella prosa.
Figure carismatiche i genitori, mentre ci abbandonano: è sempre da un pensiero eretico che si rinforza la nostra idea di libertà.
Rispondo con Céline: “in principio fu il trotto, (e le emozioni danzavano libere nei versi), poi fu il galoppo, la corsa, e il pensiero prende il prosieguo della prosa”. Può diventare un bene se accade per vie interne, per una conta differente, non senza costruire un cambio di strumento, una prosodia più liquida.
*
G.B.: Cosa pensi della poesia civile, oggi?
“Una storia apocrifa, fatta di cancellazioni”, chiama Maria Zambrano la storia delle donne. Si tratta dei “secondi”, di cui scrissi in esergo nei primi libri, i coetanei “che non presero la parola”, gli “invisibili”. Seguirono “le Silenziose”, rubrica tra le più importanti di Donne in poesia, donne rapite dalla propria vita di scrittrici, smemorate del nome proprio, azzittite per incuria, pregiudizio o paura.
Che l’universale soggetto che diceva “Io”, fossero due!
Se ne ho scritto, era perché ne fui immersa, cresciuta in un’epopea collettiva. “Noi eravamo un io plurale”, scriverò nel romanzo breve, Fioriture e giovinezza. Ma se pensiamo già all’incipit stesso de Il cantare, il ricorrere della parola canzone dà un senso alla ricerca. Un vocativo per una stagione dove la scrittura sarebbe diventata poesia di “quasi epica”.
La poesia civile, in coloro che si sforzano di scrivere su un oggetto voluto, dandoselo come compito, come dovere, la trovo un operato mesto e vano. Solo da una passione necessaria può aver luogo: César Valléjo non se lo pose come compito, tra una incarcerazione e l’altra ne sciolse il dire, in una nuova quotidianità. Neppure Simone Weil lo programmò.
*
G.B.: Il femminile è presente in tutti i tuoi testi. Un femminile non solo letterario ma anche antropologico, sociologico, mitologico. Ce ne parli? E ci parli della tua famosa rassegna del 1985 Donne in poesia?
M.Q.: Con la risposta che precede entro già nel merito di questo, e ora proseguo.
Le rivelazioni delle donne, le loro visioni, sono il punto di partenza femminile di una storia di pensiero che esce da un popolo muto, da millenni, dirà Carla Lonzi. Eppure, molte cose erano indicibili nel linguaggio femminile che riscoprivamo, tra gli anni Settanta e Ottanta: per Lacan era il godimento stesso, per le mistiche, l’essere visionarie, per le streghe curandere, la cura del corpo.
Il contatto tra divino e umano è come “naturale”, se si è stati esposti all’impossibile. Per Jean Luc Nancy, tutto ciò ci misura.
Ma le donne, all’interno del movimento femminile – femminista, conoscono presto la potenza del pensiero sui legami, scoperta che si va esprimendo in pratiche inedite, al di là della filosofia occidentale, come per esempio nell’invenzione dell’autocoscienza. Divennero così, esse stesse, mediazioni viventi, per sé e per le altre.
Io ho soltanto estrapolato dalla mia formazione un attivismo critico culturale, di pensiero, che non poteva che tradursi in una critica di genere, che sarà poi detta di gender studies.
Donne in poesia fu il fantastico titolo, per via del presente progressivo, scelto da Bianca Maria Frabotta, nel 1976.
Mi è stato fatto notare che la prima parte della mia opera poetica cammina su uno stra-ordinario parallelismo con il movimento femminista poiché, nascendo dal clamore degli anni Settanta e Ottanta, prosegue nella sua fine apparente.
Un pensiero che accetta di indagare il male di vivere a partire dalla comune ignoranza di donne e uomini, usciti dal cono della Storia e gettati a ripensare il senso della propria identità.
Scrivo: “C’è gloria nella storia,/ nella avvenuta avventura umana // con poche cose, ora imparo / da buio alla luce / il ri abbraccio”.
Tuttavia, dopo la stagione dedicata alle madri, simboliche e reali, e alle loro genealogie, oggi sento la spinta a ridefinirmi e vivermi nella figura di figlia. Si apre un nuovo ciclo della mia ricerca. Donne come singole, dopo essere state estranee, libere, donne che intraprendono altri viaggi a partire da sé stesse. Donne in grado di generarsi nel rapporto con il tempo in forme altre della lingua.
*
G.B.: Ci racconti quali poeti del Novecento hanno commentato la tua poesia?
M.Q.: Fu una fortuna avere conosciuto, da poco trasferita a Milano, nel 1984, una cittadella di poeti che influenzarono il secondo Novecento (mancai, purtroppo, Vittorio Sereni, con infinito rimpianto).
Tra chi scrisse e si occupò di me, dai primi libri, ci furono: Andrea Zanzotto, che ha “autorizzato” la mia coscienza di poeta. Il suo saggio, uscito in forma integrale su Nuovi Argomenti nel 1990, “Cantati dolorosi. Per una lettura di Marapia Quintavalla” diventa prefazione a Selected Poems, Gradiva edizioni del 2008 e figurò già in nota critica ad Estranea (canzone) nel 2000.
Ma ho avuto la fortuna di ricevere molti contributi per i miei libri: Maurizio Cucchi ha accolto e prefato Lettere giovani; Franco Loi, sin dal primo libro scrive note critiche per Il Sole 24 Ore, e scriverà la splendida prefazione di Album feriale (Archinto, 2005). Giancarlo Maiorino, che presentò alla Libreria Einaudi di Milano Lettere giovani con Marisa Bulgheroni, e fu prefatore de Le Moradas, nonché in giuria al Premio Tropea; e Antonio Porta col quale ci furono un’amicizia e un sodalizio unici, di cui compaiono articoli su Alfabeta, nella rubrica omonima Donne in poesia.
Ci sarebbero tanti altri ancora da ricordare, come Giampiero Neri prefatore di Corpus solum (Archivi del ‘900), Niva Lorenzini, Alberto Bertoni, che mi antologizzò in Trent’anni di Novecento (Book editore), ma il rischio di un elenco incompleto è dietro l’angolo. Conservo corrispondenze preziose ed uniche con Giovanni Giudici e Franco Fortini, custodite in archivio; oltre i testi che le scrittrici e saggiste Grazia Livi, Marisa Bulgheroni, Marica Larocchi, Rosita Copioli hanno scritto di me su riviste letterarie dopo la lettura miei libri.
Quando arrivai a Milano, portai presso Mondadori i libri freschi di stampa della casa editrice Aelia Laelia di R.E. a Maurizio Cucchi. Nello stesso periodo, ho conosciuto Stefano Agosti, Giuseppe Pontiggia, Giampiero Neri, Franco Loi, Giancarlo Majorino, Raffaele Baldini, Luciano Erba, Milo De Angelis, Giancarlo Pontiggia, Enzo Di Mauro, Nicola Crocetti, Ermanno Krumm, Marosia Castaldi, Mario Santagostini. Era un periodo meraviglioso per conoscersi. I poeti, con la poesia, uscivano all’aperto molto più di oggi. Per incontrarsi, vivere le relazioni e non solo inventare eventi, ma parteciparli. Difficile da immaginare oggi, ma funzionava senza mediazioni strutturali. I festival, le riviste, le rassegne erano una festa e non sette recintate, caste: si formavano per affinità elettive. Poi c’erano luoghi, come la Casa Zojosa, Intrapresa, Il Teatro Verdi, Il Centro Lusca, Milanopoesia Festival, l’Out Off Officina teatro, le Officine Ansaldo; poi è nata, dal 1985, la rassegna Donne in poesia, da me ideata come festival e come antologia, in tempo reale legata alle presenze partecipanti ai reading nazionali
Dovunque c’erano luoghi umanamente abitati: Milano era vissuta da persone di riferimento, che venivano anche da fuori: Giuseppe Conte, Rosita Copioli (le donne erano molto meno, sempre), Andrea Zanzotto (lo si incontrava spesso a Milano) e Alberto Bertoni, Davide Rondoni, Paolo Valesio, Enzo De Mauro, per citarne solo alcuni.
Gisella Blanco vive a Roma. Collabora con Il Foglio. Scrive per la rivista Leggere Tutti cartacea e on line, per Atelier Poesia cartaceo e on line, per Liguria Day, per Poesia di Luigia Sorrentino, per Smerilliana. Ha seguito la comunicazione della Fiera del Libro di Iglesias, del Premio Nazionale Elio Pagliarani, Elba Book e del TeverEstate per il Cibaldone Culture Festival. È giurata nel Premio Internazionale Città di Sassari per la sezione Poesia.