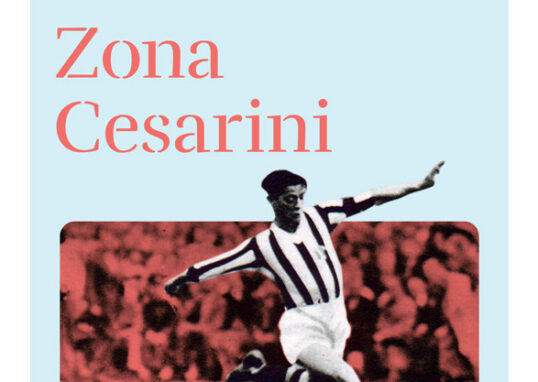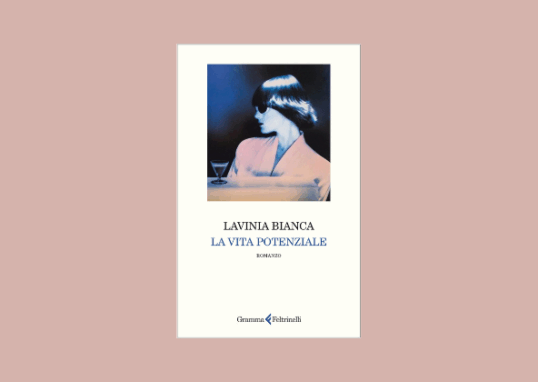Pubblichiamo un estratto dal libro di Massimo Palma Desiderare Bowie, uscito per Nottetempo. L’autore presenterà il libro questa sera alle 19.30 presso la libreria Giufà, a Roma. Interverrà Giovanni Ansaldo.
Nell’ottobre 2001 Bowie è a New York, che da qualche anno, dopo le tante migrazioni europee, è di nuovo casa sua. È al Madison Square Garden di fronte a una platea sconvolta dal recente attentato dell’11 settembre. Deve aprire il Concert for New York, organizzato da Paul McCartney per le famiglie delle vittime. Bowie sta seduto al centro della scena, i capelli fissati dal gel, una ciocca bionda gli oscilla sulla fronte, a volte gli copre l’occhio destro, quello più chiaro. Una luce fissa, viola, gli illumina il viso. Tutto il pubblico all’inizio è tenuto al buio: per un lungo, lunghissimo minuto vede solo lui sul palco.
Bowie suona un omnichord, uno strano piccolo strumento elettronico che Damon Albarn ha appena utilizzato per gli accordi di Clint Eastwood, il primo grande successo dei Gorillaz.
La voce inizia bassa e quasi trema. Ogni volta che Bowie pronuncia la parola “America” la folla grida forte – è un riflesso condizionato che dura tutta una sera e un’epoca intera. Ma Bowie trattiene la voce, la mantiene spessa e densa, non eccede e quando sale di un tono chiude gli occhi. Ora la melodia è senza oscillazioni. Guarda nel vuoto, immobile tra le immagini delle due Torri ancora in piedi dietro di sé e altre vecchie foto, mentre si adagia nella storia semplice che il suo brano racconta.
È la prima volta che canta in pubblico America di Simon & Garfunkel: nella retorica di quel giorno – gli Who faranno diventare la loro Union Jack una bandiera a stelle e strisce – Bowie vuole proporre una contronarrazione, vuole usare l’omnichord per raccontare un’altra America, senza rumori né eccessi. Sembra perso nella canzone, nel piccolo esercizio mimetico che sta portando avanti, ipnotizzando se stesso oltre che il pubblico. Conserva tutto il suo accento British mentre in bianco e nero, sullo schermo alle sue spalle, appaiono immense le folle di migranti a Ellis Island, la Statua della Libertà sullo sfondo, e donne di altri tempi col capo coperto, e bimbi ignari che sorridono.
Bowie non ride mai, tiene gli occhi fissi su un punto, lascia andare avanti l’intensità di quel brano, America, per raccontare le sensazioni della migrazione, del lavoro da trovare, l’essere perduti nel mondo nuovo. Aumenta l’intensità quando grida il vuoto e il dolore e l’ignoranza del futuro che segue a quei moti di carri, valigie, cianfrusaglie, in porti giganteschi le file enormi di umani e bagagli, le attese.
Quel giorno David Bowie a New York è un disperso come tanti. Guarda altissimo, verso le luci e un pubblico inesistente allo sguardo, mentre dice che tutti sono venuti alla ricerca dell’America. All’America in lacrime – i miti sono la prima cosa che abbiamo visto piangere – Bowie restituisce la sua storia recente. Si protegge col totem di Paul Simon, con le sue parole che raccontano di come l’America sia solo quello, mito immenso e sogno di spazio. America è la storia di migranti che si sentono persi e sofferenti a vedere orizzonti aperti, campi. E di una massa di persone come loro, in cerca. Mentre è fermo e pigia l’omnichord, canta dei due amanti che prendono la corriera a Pittsburgh e poi fantasticano del Michigan. E poi scherzano, delirano, forse per la fame. In particolare, dei due, lei parla di una spia che vestiva un abito di gabardina. Aggiunge che in realtà il suo papillon – il suo bowtie – era una macchina fotografica.
Dietro Bowie, tra le fotografie che scorrono, e davanti a lui, tra le pupille di un pubblico che ora deve tacere, lo spazio è vuoto e lacrimoso. Bowie continua a non sorridere – l’ultima immagine è una bandiera a stelle e strisce immane durante una manifestazione. I drappi della Statua, ancora, sempre in bianco e nero. Guarda il pubblico, accenna un inchino, ora un sorriso, poi lo ritira. Nel buio lo applaudono piano.
Tre mesi prima di quella serata strana di lutto collettivo per l’11 settembre, che si fece via via sempre più rumorosa, chiusa dal caos sonico degli Who e da Paul McCartney, Bowie aveva passato un giorno in uno studio di New York a registrare una nuova versione di un suo vecchio brano che era uscito come singolo nel 1985, per una colonna sonora di un film di spie che fanno traffici a cavallo della cortina di ferro: This Is Not America. Bowie l’aveva scritto con Pat Metheny: ne era uscitoun pezzo di jazz fusion leggero e irrilevante, in cui nessuno deidue sembra davvero riconoscibile, tra i synth banali anni Ottantae un testo senza guizzi, ma che tutto sommato regge allaprova del tempo per quel titolo che ritorna ossessivo, e si staccadal contesto del film.
Nel luglio 2001 Bowie prestò il brano a P. Diddy, già allora personaggio controverso, che gli cambiò nome in American Dream. Mise alcuni rapper dell’epoca a dettare le barre e lo fece diventare un pezzo di denuncia del dominio razziale negli Usa, parlando di polizia corrotta, di discriminazione. Bowie appariva
solo nel ritornello a cantare “this is not America”: nel paese che lo ospitava si diceva anamericano. Il punto, nella rilettura hip-hop di un suo antico brano innocuo, era la negazione pura: negare che quella fosse America – sfruttarne l’omofonia col miracolo, “America”/“miracle”, e ancora negarlo. Adesso, subito prima dell’11 settembre, Bowie metteva la sua voce e quell’unico verso – il titolo stesso del brano – a infrangere con la melodia il ritmo incessante di ragazzi neri che denunciavano la profilazione razziale da parte delle autorità: li appoggiava col suo peso specifico di bianco, anche se sapeva bene che “non gliene frega un accidenti di cosa pensiamo noi. Non vogliono i nostri consigli”.
Nel 1992 Bowie si era ritrovato spettatore della rivolta nera di Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney King. Era appena arrivato in California con la nuova moglie, la supermodella Iman Abdulmajid, che aveva sposato a Firenze. Raccontò che teneva i soldi e le chiavi della macchina accanto al letto per scappare subito, qualora gli incendi fossero arrivati sotto l’hotel di lusso dove dormivano. Disse che dall’albergo vedevano avanzare la rivolta come un’alluvione, straripante e senza piani d’azione, tra saccheggi e roghi ovunque, dopo l’ennesima aggressione ai danni di un nero commessa da una divisa. Erano chiusi in un hotel e senza strumenti di comprensione. Era come vedere la rivolta di una prigione all’aperto, dirà. Pochi mesi dopo un suo brano cercherà di gestire la sua stessa confusione, la paura provata e il desiderio di dirsi parte del problema.
In Black Tie White Noise, che dà il titolo all’album del 1993, il cantato è quasi tutto in delega ad Al B. Sure!, all’epoca astro nascente del soul. Nel testo inondato dal sax, dai rimandi a Marvin Gaye, si balbetta confusamente di razze e di Dio, di pistole e fascisti bianchi e neri, di fratellanza. Ma si dicono anche i limiti dello sguardo bianco pietoso, marchiato negli anni Ottanta dalle foto di Oliviero Toscani per Benetton (gli occhi africani da cui è impossibile trarre una trasparenza, citati in apertura del pezzo), e ancora fermo a We Are the World o più dietro ancora, agli anthem degli anni Sessanta. Nulla è chiaro se non che l’idea di uguaglianza è nata bianca e che ci vuole altro per definire i “legami neri”, il black tie. Perché il resto del testo, che narra di vita nera soffocata, di profezie di sangue che scorrerà, mostra che il rumore bianco si sparge a partire da parole astratte vendute e ripetute. E se Bowie in quei giorni citerà positivamente la Nike per la sua capacità di veicolare l’immagine di neri come “esseri umani in carne e ossa in grado di pensare e avere delle opinioni proprie”, intuisce che nella testa dei neri schiacciata sulla terra non ci sono parole bianche da ascoltare, ma fortissimo rumore bianco. Dirà pure che “siamo fin troppo bravi, da bianchi liberali, a suggerire ai neri come dovrebbero migliorare la loro sorte”.