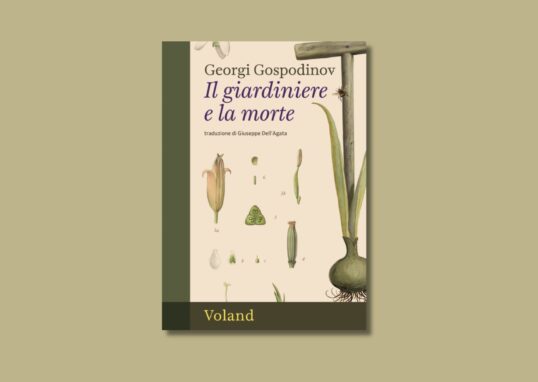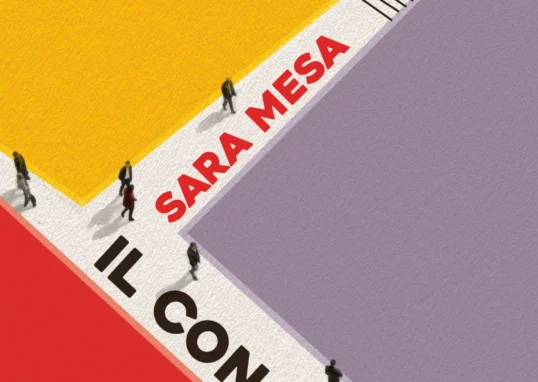Tra le amicizie che attraversano la nostra vita, i compagni di liceo formano una categoria irripetibile: al contrario di quanti sono venuti dopo, loro ci hanno visto “in potenza”, quando eravamo un magma incerto, appena qualche qualità già accennata e per il resto aperti alla possibilità di diventare tutto. Ci hanno conosciuti senza la paura del tempo e senza quanto di guasto l’età adulta comporta nell’individuo. Adami Baldini Donati… La classe è per sempre il ritmo dei cognomi in sequenza sul registro; la catena dell’appello tiene insieme ruoli, caratteri, tic, estati infinite, le fatiche e le cazzate, la prof. di, la volta che. Una stagione mitica e cristallizzata, toni ed episodi da epopea, un po’ goliardica un po’ esistenziale: ognuno la sua, per tutti uguale. Non è strano, perciò, se tra le pagine de I convitati di pietra, l’ultimo libro di Michele Mari, il lettore troverà traccia della propria vecchia aula al secondo piano in fondo al corridoio, lato sinistro.
Innanzitutto, il nucleo narrativo. Al primo anniversario della Maturità – 22 luglio 1975 – i trenta della III A Liceo Berchet di Milano decidono di stipulare un patto. Ognuno verserà ogni anno una somma di denaro, piccola in sé ma che una volta reinvestita per mezzo secolo, con accumulo degli interessi, produrrà una cifra enorme, da spartirsi tra gli ultimi tre compagni rimasti in vita. È il meccanismo della tontina, un sistema di risparmio collettivo chiamato così, sembra, dal nome del banchiere Lorenzo de Tonti che nel 1653 lo propone al cardinale Mazzarino per aggiustare le finanze del Regno.
La cena di classe del 22 luglio diventa un appuntamento fisso, anzi una vera liturgia, con il rapporto sul progredire dell’operazione, l’aggiornamento dello stato di salute dei presenti e la conta di chi ancora poggia i piedi per terra e di chi invece va depennato, che dispiacere! dalla foto di gruppo. Morte e soldi in una giostra a eliminazione progressiva: il congegno narrativo di base pare un misto tra And then there were none di Agatha Christie, Final destination e Squid Game, ma soprattutto The Wrong Box, un romanzo scritto a quattro mani da Lloyd Osbourne e Robert Louis Stevenson. Viene perciò naturale scorgere il tributo di Mari a un autore con cui ha un rapporto molto stretto, prima da bambino che legge “con gaudio immediato e invereconda immersione”, poi da figlio che riceve La freccia nera in regalo dall’”orchesca persona di mio padre”, infine, da filologo e traduttore.
Ai compagni della III A è chiaro fin da subito che l’accordo stipulato ha l’odore metallico del sangue. Inevitabile: nel loro legame si incista l’idea della morte, ma anche dei soldi, non solo in quanto morte e soldi in sé, ma anche e forse prima di tutto come morte e soldi rispetto agli altri, oltre alla sensazione di aver attivato la macchina macabra con la loro decisione, pur sapendo che ciò è impossibile, ma lo stesso provando una strana inquietudine insieme all’illusione di poter resistere in qualche misura all’assedio del destino.
C’è chi gestisce il giro delle scommesse, chi ordisce omicidi, chi esegue macumbe, chi abbandona la gara compiendo l’atto estremo; e, certo, c’è il convitato di pietra – chiamatelo caso, ananke, o statua del Commendatore –, eccolo che arriva puntuale, sceglie, ordina di dargli la mano e, presa la mano, accompagna il prescelto nel regno di sotto.
Quanto tempo ci vorrà perché si compia…? Perché un intero gruppo di coetanei…? Se sono nati nel 1955 (come Michele Mari), quanto possono durare se…? Così, partendo dal passato e bucando la soglia del presente fino a un ipotetico 2049, il romanzo ottiene un effetto metaletterario, perché più si procede con la lettura più si consuma vita e l’ultima pagina corrisponde a… segna la fine di…
Si va da trenta a uno in un susseguirsi di episodi, tra gesti etici e disumanità, tra rancori e tresche amorose. È un libro di corsa. Accadono molte cose, i personaggi pensano poco, parlano poco, restano condensati nei loro cognomi-etichetta – Migliavacca, Testaviva, Brodo – che li fa rientrare, per costruzione, nell’universo dei personaggi-attributo di Mari, assieme al Mucògeno, Quello che Gorgoglia, Quella con il Velo e molti altri, più o meno spaventosi. Finché nell’ultima parte del romanzo, per un effetto meccanico-quantitativo la spartizione delle pagine premia i sette superstiti (una specie di tontina di secondo livello per la vincita di uno spazio letterario) e a ciascuno è concesso di ingrandirsi, rivelarsi e diventare una figura riconoscibile.
Appoggiandosi a una struttura ricorsiva composta da strofe (gli accadimenti), ritornelli (la cene del 22 luglio) e post-ritornello (il funerale del malcapitato di turno), Mari si abbandona al piacere della trama, e anzi: mentre altrove la sua euforia combinatoria si esprimeva nella lingua (capace di muoversi tra Omero e i fumetti, tra la Bibbia e Maigret), qui si trasferisce all’intreccio sovrabbondante, talvolta improbabile, che pare costruirsi man mano con grande libertà immaginativa, un’ingordigia quasi, fino al grottesco e all’humour noir (come quando lei e lui, ex fidanzati, presi da nostalgia nello stesso momento, decidono ciascuno per sé di rivedere l’altro, ma si scontrano in un frontale a metà strada).
E forse potremmo far corrispondere queste due attitudini (stile vs invenzione) a due filoni della produzione di Mari, rispettivamente: uno in cui si mettono in scena i mostri dell’infanzia, il portato degli oggetti, il feticcio, l’ossessione numerico nomenclatoria , il doppio e il disagio della convivenza sociale (Verderame, Rondini sul filo, Leggenda privata tra gli altri) e un altro in cui ci viene restituita la fascinazione del bambino lettore immerso senza riserve nella letteratura (ad esempio Roderick Duddle, Tu sanguinosa infanzia). In questo secondo gruppo collochiamo I convitati di pietra, un libro da cui fuoriesce l’aspetto ludico regressivo e anche patetico della letteratura; per il lettore nessuna fatica né richiesta di immedesimazione, solo la gratuità di una storia capace per un certo tempo di sottrarlo al suo presente, o meglio, al reale.
La strategia promozionale di Einaudi per questo libro punta su un Michele Mari “mai così divertito e divertente”, autore di “un ingranaggio affabulatorio che inchioda il lettore alla pagina“. Mari divertito, sì. Divertente, meno. Perché quando le stranezze si accumulano una sull’altra lo scalpore risulta depotenziato. Dopo la trentesima, la cinquantesima, beh, ammettiamolo, si finisce per rimpiangere il pastiche manieristico e nevrotico di altri suoi lavori, quello sì pieno di ironia dissacrante (gaddiana, manganelliana), e anche, diciamolo, ci manca il ritmo di Mari quando fa Mari, perché allora l’italiano suona nuovo e tu non penseresti mai che l’italiano possa suonare così.
Qui il narratore è – immaginiamo – il compagno di classe con gli occhiali e la camicia bianca, quello che sa tutte le capitali e non gioca a pallone. Lui da grande scrive un romanzo al passato remoto su loro tutti, li guarda da fuori e li conosce a tal punto da indovinare quel che pensavano allora e pensano adesso, vede dentro il loro modo di agire, sa come moriranno.
E se altre volte Mari ha costruito i libri con altri libri, sia per mimetismo della lingua che per riferimenti e citazioni, in questo testo l’omaggio preponderante è al cinema. In un’intervista del 2015 a Carlo Mazza Galanti per “Il Tascabile” (qui), Mari dichiara: “A volte vedo certe scene come fossero film, o certi personaggi li immagino come attori: per esempio il signor Jones di Roderick fin dall’inizio l’ho immaginato come Gene Hackman.”
Ed ecco, di rimbalzo, uno dei nostri personaggi, Lothar Semprini, decide di scrivere un romanzo-saggio “di celebrazione e di culto” proprio su Gene Hackman. Rivede e studia settantuno dei suoi film, abbozza, lima, ancora e ancora, ma non è mai pronto, mai finito. Si innesta dunque nel romanzo una sottotrama dalla valenza simbolica (e, forse, dalla vena autobiografica), perché nell’uomo che rincorre il progetto, ovvero nell’opera “da farsi”, si mantiene una riserva di desiderio, una spinta vitalistica, una speranza. Chissà, un’arma contro la morte.
“[…] il bello cominciava proprio allora, quando la macchina sarebbe entrata nella sua fase decisiva e il loro tesoro (lo quantificò, una cifra sbalorditiva) sarebbe stato sempre più reale, sempre più vicino, sempre più alla portata dei più forti, dei più sani, dei più risoluti, come un premio alla vita che (ammise) dovrebbe essere premio a se stessa, ma da vecchi, insomma, quando si è perso quasi tutto, un riconoscimento non guasta, anche perché, aggiunse con gravità, non contava tanto il premio, che comunque i vincitori avrebbero goduto per poco tempo, ma la sua aspettativa, avere qualcosa per cui vivere, combattere, qualcosa da sognare, qualcosa che poteva farli ritornare i bambini, a monte della Maturità, alle elementari, all’asilo!”
Una volta chiuso il libro vien da pensare che forse, insomma, vuoi vedere che questo premio è la letteratura?
Francesca Zanette scrive e fotografa. La zona di confine tra parola e immagine è il territorio su cui indagano alcuni dei suoi progetti, ricerca che ha alimentato una serie di sue mostre recenti. Ha pubblicato racconti su riviste letterarie e in antologie, scrive di fotografia e letteratura su minima&moralia e Doppiozero. È autrice del romanzo 𝐷𝑜𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎, ed. Readerforblind, 2022.