
Sta diventando una piacevole abitudine quella di attendere l’uscita del nuovo libro di Nuova Poesia Americana, che Black Coffee ci regala verso la fine di ogni anno, ormai da tre anni. Anche quest’inverno, qualche giorno prima del Natale è arrivato, proprio come arrivano i regali, il terzo volume, curato come sempre da John Freeman e tradotto con la consueta grazia e attenzione da Damiano Abeni. Di nuovo sei poete e poeti, sei storie, sei maniere di scrivere, di pensare, di raccontare, di fare musica con le parole. Versi che arrivano da diversi angoli di quello sterminato paese che sono gli Stati Uniti d’America. Parole che vengono scaraventate tra le pagine dalla Louisiana, dall’Illinois, dal Messico (via Usa), da New York (via Londra, via Parigi), dalla Carolina del Sud e dalla Giamaica. Parole scritte per essere recitate ad alta voce e, allo stesso tempo, per essere lette, questo è uno dei segreti, dei fili che lega autrici e autori qui raccolti. Anche per il terzo volume, Freeman ha scelto chi non è mai stato tradotto da noi, e che è, però, molto distante dall’essere sconosciuto. – sono tutti più che premiati. Questo aspetto ci ricorda che esiste molta poesia che non conosciamo, che neppure immaginiamo, e il discorso vale per tutto il pianeta. Se esistono voragini di conoscenza tra i poeti del nord America, residenti in uno dei paesi da cui più si traduce, pensiamo a cosa non è mai arrivato dall’India, dall’Africa, dall’estremo Oriente, e che mai arriverà. Accontentiamoci, cominciamo da qui.
Nell’introduzione al primo volume, Freeman raccontava di sorta di maturità raggiunta dal lettore americano, che non aveva più bisogno di sapere cosa stesse accadendo nel campo dei diritti civili, nel mondo del lavoro (o lo sa e gliene importa, o lo sa e fa finta di niente). Il lettore di poesia aveva (e ha) bisogno di sentirsi dire «con quanto impeto si può arrivare a desiderare un bacio». Aprendo il secondo volume, il curatore raccontava il sentimento della solitudine, di quanto fosse impossibile non provarla nello sterminato territorio del nord America. Sul desiderio del bacio – sulla capacità di immaginarlo, di scambiarlo – e sulla solitudine – su come sfuggirle, assecondarla, raccontarla, viverla – si costruivano le mappe di quei due volumi, ed eccoci al terzo, una nuova geografia poetica che viene a trovarci.
Questo nuovo libro parla di letture ad alta voce, di poesia trasmessa come musica da una radio, portata in giro, di locale in locale, di stato in stato, di microfono in microfono. Freeman fa un po’ di crono-storia, ricordando come in un dato momento uno o più reading abbiano segnato una svolta epocale per la cultura e non solo. Tutto esplose nel 1955 con un reading di Allen Ginsberg, che raccolse il testimone dai poeti degli anni ’40 – il reading di quella sera fu presentato da Kenneth Rexroth. Dopo la Beat Generation si passò al Black Arts Movement degli anni Settanta, fino ad arrivare ai giorni di Adrienne Rich e al successivo periodo d’oro delle slam session; insomma, spiega Freeman che la poesia è sempre stata tesa al rinnovo e quel nuovo è stato urlato con gioia. Una poesia aperta al dialogo e al confronto. Il venerdì sera si usciva per andare ai reading, poi siamo entrati in questo periodo buio, non ancora finito, e allora la poesia ha voglia di ritornare nei locali, ha voglia di sussurri e di metriche rovesciate in un microfono, nel frattempo alcune di queste modalità le troviamo tra le pagine. Parole aperte e lanciate da una città all’altra, in attesa del luogo.
La prima poesia del libro apre la serie di Jericho Brown e ci fa capire subito quale materia abbiamo tra le mani: «Un uomo baratta il figlio con dei cavalli. / È la versione che preferisco. Mi piace / il senso di sicurezza, la colpa di nessuno, / e che ci guadagnano tutti. Dio si prende / il ragazzo. Il ragazzo diventa / immortale […]». Un incipit straordinario, ma anche una chiara indicazione della poetica di Brown, autore di testi che molto hanno a che fare con Dio, con il rapporto tra l’uomo e Dio – pieno di falsità, ricatti, fallimenti, paure – e tra padre e figlio. Su questa ultima relazione Brown ha scritto una delle sue poesie più belle, un canto di perdono del figlio al padre. I versi di questo poeta – nato in Louisiana – riguardano la preghiera, la litania, producono un bel suono se letti ad alta voce. Sono preghiere terrene, che non fuggono la redenzione ma la cercano con le nostre armi, con le cose che facciamo e che non facciamo, sospesi tra gli schiaffi ricevuti dai nostri genitori e i corpi (e i cuori) di chi abbiamo incontrato nel tempo e che ci ha salvati.
Il corpo e Dio entrano in qualche modo anche nella poesia di Patricia Smith, – originaria di Chicago, considerata una delle regine del Poetry Slam -; vi entrano come voci di richiamo, come destini che ci lasciano. In una poesia particolarmente riuscita, una figlia dice del padre che è stato ucciso. C’è il corpo che va via, e ci sono tutti i conti che si fanno a un funerale, e il salasso non sta nel prezzo della cerimonia, ma nella resa di una ragazza al cospetto dell’inutilità della fede – della preghiera – di sua madre. «Ma adesso è il suo corpo in coda per il marmo, / la sua benedetta temperatura con cui giocherelli, e la sacra / direttiva di Dio cambia di conseguenza […]»; un pezzo di bravura enorme in questi due versi e mezzo, c’è tutto: il corpo, il dolore, la perdita, e la delusione verso Dio. Smith è di rara efficacia, e non dimentica il quotidiano, così duro, così difficile da evitare (e da affrontare), quando chiude una poesia così: «mi sono svegliata stamattina / mi sono svegliata stamattina / la prima bugia che così tanti di noi dicono».
Sandra Cisneros ha la doppia cittadinanza – messicana e statunitense – e in quei passaporti vanno cercate le origini della sua poetica. Cisneros scrive di desideri, di fuga, di povertà, di nessuna possibilità di farcela – eccetto quella di andarsene, lasciarsi la famiglia alle spalle, buttare via un destino segnato, e ce la fa. Penando, soffrendo e scrivendo. Una sua poesia straordinaria, si intitola Prefazione a un certo punto recita così: «Il mio primo reato – ho cominciato con la poesia. / Per questo handicap, s’è bruciato il riso / Madre mi ammoniva che non sarei mai stata moglie. //Moglie? Una donna come me / le cui opzioni erano solo mattarello o fabbrica? / Un vizio assurdo, questa vita perversa / da scrittrice-sgualdrina […]». Bellezza e potenza, ironia e dolore, visione limpida sullo stato delle cose. Questa è la poesia di Cisneros, che più avanti scrive: «Volevo fare la scrittrice. / Volevo essere felice». E ci è riuscita, facendo la sua parte, rimanendo sé stessa, in ogni altrove in cui è stata.
Marilyn Hacker è di New York, ha vissuto a Londra e ora sta a Parigi, del libro è la mia preferita. Ha una visione del tempo e del mondo incredibili, pare riesca a condensare tutta la realtà possibile in due versi, e al terzo regalare uno sguardo sul futuro. Ciò che siamo è nelle nostre giornate, ciò che non siamo pure. In mezzo sta quello che tentiamo, a volte riusciamo per buona sorte, a volte la sorte è uno sfacelo. Hacker da sempre si batte per una società giusta, continua a fallire perché non ce la si fa, ma non si arrende, né nel privato né quando scrive ed è capace di scrivere cose come questa – che hanno nella metrica tutta la nostra miseria, il nostro dolore, il nostro avere a che fare con noi. Il nostro non perdonarci -: «Torni a casa dalla riunione, dall’ospedale, fai il caffè e guardi lo specchio / e ancora una volta ti chiedi cosa hai fatto per aver provocato i tempi bui». Già, cosa hai fatto?
Nikky Finney è poeta di domande all’apparenza semplici. Questioni che hanno a che fare col quotidiano e lo spazio, su come ricavarne abbastanza da farci stare dentro un po’ di felicità, d’amore. Freeman scrive che «dall’etica dell’amore è riuscita a ricavare un’estetica», e in effetti è così. Finney parte dalla memoria, dalle case, dalle scuole e osserva lo stile di vita americano, i sogni a perdere, gli slanci generosi. Scrive delle donne ma scrive per tutti e a tutti, scrive di quello che tutti dovremmo aspettarci, qualcosa di simile alla gioia. Non sperare soltanto ma aiutare la speranza a germogliare, a compiersi. Finney, dalla sua South Carolina scrive cose così: «Dopotutto, era solo la povera New Orleans, / vecchia città bastarda, di gente che non sa scrivere. Non-nuotatori / con accenti da fisarmonica. Tra coloro / che resteranno in vita chi se ne curerà?». Chi? Forse solo i poeti che guardano dove non guarda nessuno.
Ishion Hutchinson è il più giovane del volume ma non meno sorprendente degli altri. Le sue poesie hanno un respiro ampio, si muovono nel mondo e verso il mondo, lo chiamano per nome, lo coinvolgono. Usa un linguaggio chiaro, che sembra piano e poi all’improvviso svolta, taglia, imbrocca una strada laterale e ti mostra un panorama che non era indicato nella mappa. Scrive cose come questa: «non una parola, tranne: Non preoccupatevi, ripartendo in auto, / come se avessero lasciato promesse migliori per il futuro». Hutchinson è nato in Giamaica, come tutti qualche volta abbiamo desiderato.
Queste poete e poeti scrivono come tutti qualche volta abbiamo sperato.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/

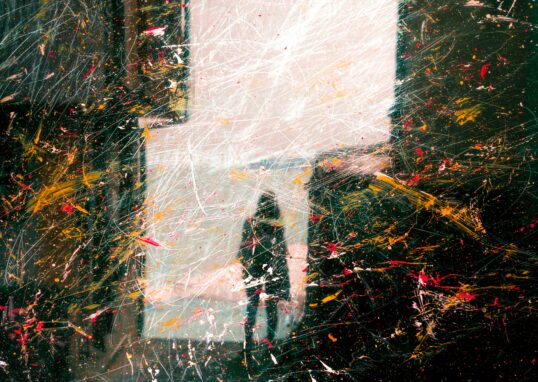

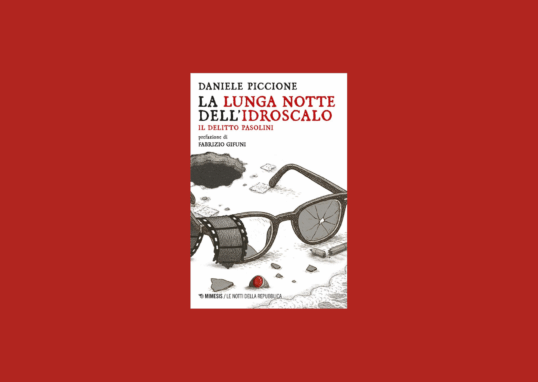
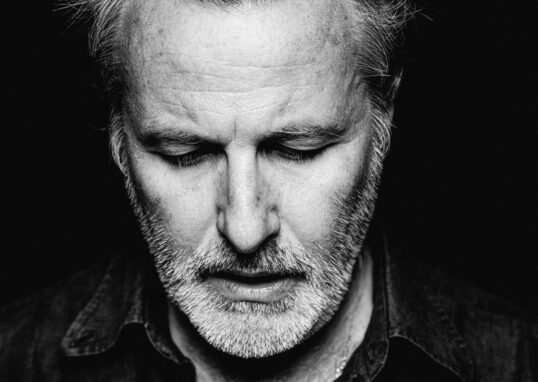


Oggi la poesia americana è talmente viva che si potrebbero tranquillamente pubblicare cento antologie come questa, ciascuna con l’opera di sei poeti. Abbiamo deciso di iniziare da sei scrittori che riteniamo particolarmente rappresentativi del contesto attuale. Poeti che non solo mettono alla prova i limiti imposti dalla forma, ma che accorciano il divario immaginativo tra che cos’è veramente l’America, chi sono le persone che ci vivono e come tutto questo viene raccontato in poesia. Io e Damiano Abeni non abbiamo dubbi: ogni nuovo volume di questa collana sarà una specie di piccolo evento, anche perché nessuno di questi poeti è stato ancora pubblicato in italiano. Speriamo che questa nostra selezione, meravigliosamente tradotta da Damiano, contribuisca a cambiare le cose».
– John Freeman