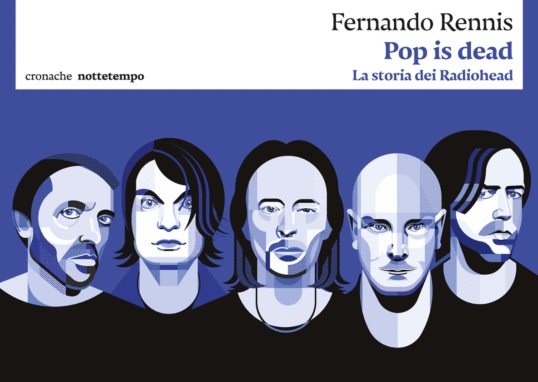Photo by Joshua Stannard on Unsplash
Pubblichiamo un estratto dal libro di Graziano Graziani A Venezia, uscito per Giulio Perrone editore, che ringraziamo.
I poeti parlano di altri poeti. È fatale, inevitabile. Per quanto si possa essere convinti del proprio talento, e per quanto la poesia possa richiedere un grado anche profondo di solitudine per essere scritta, essa rimane un fatto collettivo. Si può scrivere per se stessi, ovviamente, ma resta sempre il sentimento di fondo che ciò che sorregge il senso di questa operazione senza senso sia il sentire di qualcun altro, un lettore, un poeta che possa aver fatto un percorso simile o difforme, ma comunque in assonanza a quello di chi scrive.
Brodskij ammirava Auden. Fu una delle prime persone che andò a incontrare a Vienna, quando iniziò il suo esilio in Occidente.
L’influenza che il poeta inglese esercitò su di lui fu enorme. Ma, iniziando la sua passeggiata per Venezia, i primi poeti che cita sono italiani. L’Adriatico selvaggio di Saba, che si agita oltre le spiagge del Lido e di Pellestrina, che chiudono la Laguna in un abbraccio protettivo. E Montale, di cui parla per attaccare discorso con una non meglio specificata visione, una donna di cui forse era invaghito ma in forma più ideale che reale, che era venuta ad accoglierlo in città, in quella sera di dicembre di molti anni fa che apre Fondamenta degli Incurabili.
Il poeta genovese, in realtà, di Venezia aveva scritto nel 1969, in due componimenti in cui spicca un verso parlato, discorsivo, che non a caso definì “due prose veneziane”. Nella prima rievoca una vacanza avvenuta nella città lagunare nel 1934 con la compagna dell’epoca Irma Brandeis e snocciola alcune delle zone del sestiere San Marco che fanno da baricentro del turismo lagunare, la piazza stessa – l’unica a fregiarsi di questo nome in una città costellata di campi e calli –, la Riva degli Schiavoni, il Florian descritto come “deserto”, il ristorante dell’Hotel Paganelli.
È una Venezia di quasi cento anni fa, certo, ma tutto lascia intendere che la città si esaurisca in una manciata di strade dove il turismo internazionale che se lo può permettere si dà convegno. Siamo o non siamo nel “salotto d’Europa”, come è anche chiamata piazza San Marco? Montale, ad ogni modo, dà segno di riderci su, scavalca becchime, piccioni e fotografi, si dice avvolto da un senso di estraneità a tutta quella giostra acuito dal caldo bestiale, appesantito dai cataloghi della Biennale (perché a Venezia il turismo è anche turismo culturale) e conclude di sentirsi fuori posto, in un luogo che domanda soltanto “turisti e amanti anziani”.
Ancora una volta la Venezia del turismo è una Venezia di chi se la può permettere, una forma di giostra sofisticata che in fondo può essere lasciata a se stessa.
Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.