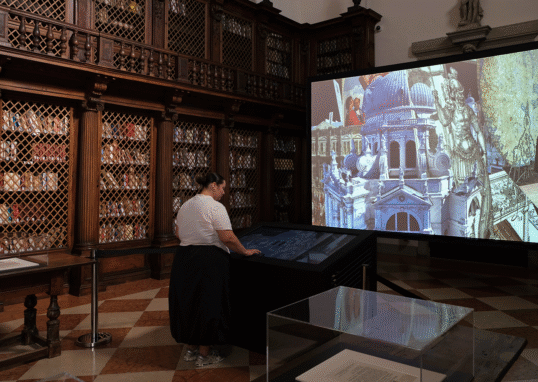«Quanti anni bisogna avere perché l’avambraccio di tua madre sia esattamente lungo come il tuo busto?»
Quando ho visitato Buenos Aires qualche anno fa, girando per le strade, attraversando le piazze, scrutando i murales – più che i monumenti e i musei – mi sono reso conto che la storia della dittatura di Videla e della sua giunta militare non può essere archiviata (che non vuole dire dimenticata) fino a che l’ultimo corpo, l’ultimo nome, l’ultimo vestito o paio di scarpe, di una desaparecida o di un desaparecido non sarà ritrovato. Fino a che le ultime ossa, l’ultimo brandello d’ossa non sarà restituito ai familiari. La storia potrà essere capita fino in fondo, i figli e le figlie dei torturati e dei dispersi potranno avere un minimo di pace. Devi avere qualcuno da seppellire, da piangere, poter soffrire davanti a una certezza, a un’evidenza. Lasciarsi andare per poi ricominciare a vivere. La frase «No olvida ni perdona» la si legge un po’ ovunque, ti accompagna, ora è su un muro di Palermo, ora è a La Boca, ora la leggi fuori da una finestra di San Telmo, ora è a Belgrano, una scritta su un lampione a Barrio Norte, davanti all’ingresso di una biblioteca in centro. Passi in Plaza de Mayo e trovi i segnali delle madri.
A Buenos Aires sai che i desaparecidos sono con te, e capisci che dove stanno le madri (e i padri) che hanno perso i figli, stanno pure i figli che hanno perso madri e padri, che hanno visto qualcuno portare via i propri genitori in un giorno come un altro. Marta Dillon, straordinaria scrittrice e giornalista argentina, è una di quelle figlie e ha raccontato la sua storia in Aparecida (gran via, 2021, traduzione di Camilla Cattarulla). Dillon ha saputo mescolare inventiva narrativa e fiuto da reporter, memoria e dolore, cronaca privata e vicenda pubblica, scrivendo un libro molto bello, aggiungendo un prezioso frammento al servizio che la letteratura ha reso alle vittime della dittatura. Dillon parlando di sé, della vita di sua madre, dei suoi fratelli e sorelle, dei suoi figli, di sua moglie, porta una luce calda sui nostri cuori, sulla nostra capacità di commuoverci, sul nostro desiderio di conoscere i fatti.
Cercare è una parola spinosa quando si tratta di desaparecidos, perché in verità non è così chiaro che li cerchiamo, che cerchiamo lei, nel mio caso. Quello che si cerca è un materiale residuale, il sedimento della sua vita prima e dopo essersi trasformata in quella irrealtà che non è, non c’è, non esiste.
La militante Marta Taboada viene sequestrata nella sua casa di Moreno, provincia di Buenos Aires, sotto gli occhi dei quattro figli, è il 28 ottobre del 1976, non la vedranno mai più, non ne sapranno più nulla. L’Équipe Argentina di Antropologia Forense si occupa di attribuire l’appartenenza di resti umani ritrovati nel tempo, di mettere un nome sopra le ossa, di restituire un corpo, di colmare un vuoto inesorabile. Il 30 settembre del 2010, Marta Dillon si trova in vacanza in Europa, con sua moglie Albertina e il loro figlio, riceve una telefonata: è stata determinata l’identità di alcuni resti ritrovati in una fossa comune, ci sono anche quelli di sua mamma. L’elastico che ha teso i 34 anni, trascorsi fino a quel momento, all’infinito cede e annulla il baratro, ricompone il pianto. Comincia così, da un telefono che esaurisce il credito il racconto di Aparecida.
Come se mi dovessero un abbraccio. Come se fossero mie. Le avevo cercate, le avevo aspettate. Le volevo.
Dillon si pone una domanda: come ci si riappropria di un corpo? Come mettere in luce ciò che è stato nell’ombra? Bisogna trovare un modo di guardare ciò che è stato amore, dolore e che adesso è anche paura, timore. Come ci si confronta, perciò, con un ritorno che stavamo aspettando da sempre e per il quale, in ogni caso, non siamo pronti. Termina un’assenza e deve cominciare un lutto, non più da elaborare ma da accompagnare. C’è da fare ciao a tutto ciò di cui si è stati privati e metterlo là dove si può andare a piangere. E quel pianto non è più lacerante, quel pianto è soltanto mancanza. Ora si può far posto al dolore e si può anche ridere, celebrare, ripensando a tua madre: ballare.
Per ricondurre le ossa al loro nome e perciò a sé stessa e alla famiglia, Dillon, smuove la memoria, fruga tra i ricordi, frammenti, flashback, parla della sua vita, le sue scelte, i suoi problemi, la perdita della gioia, il ritrovamento della felicità, l’insensatezza, l’irruenza, il suo correre sfrenato. Una vita tra inseguimento e fuga, di incomprensioni e amore con la sua figlia più grande, di freddezza e diffidenza verso il padre, che aveva lasciato moglie e famiglia. Ci dice dell’Aids, del suo amore per Albertina, del suo occuparsi di femminismo, questioni di genere, del suo fare avanti e indietro a interrogare testimoni, a cercare luoghi, a setacciare database, in nome e per conto del suo amore e della verità, della giustizia collettiva che il popolo argentino non smette di reclamare.
[…] le altre ossa lunghe erano state associate tramite il DNA, e attraverso questa catena aveva restituito loro i nomi, aveva visto come venivano ricevute dai parenti, intrecciate di nuovo alle famiglie. Quelle famiglie adesso collegate alla mia dall’ultimo sospiro dei nostri cari.
Marta Dillon commuove mentre ricostruisce la figura della madre e di tassello in tassello ricompone il suo senso di perdita. L’importanza della memoria di un popolo è fatta di frammenti di piccole cicatrici individuali, di storie di famiglie spezzate, di ossa che ritornano a casa. Racconta le reazioni molto diverse dei due fratelli e della sorella, il loro avvicinarsi a quei tessuti che si chiamano mamma. La fine della brutalità sta nel ritorno di un corpo e allora la sepoltura deve essere preceduta da minuscoli atti d’amore, da piccole cerimonie casalinghe, da un girotondo di amiche chiamate a raccolta, tra un ricamo, un fiore e una poesia.
Il linguaggio dell’amore non si parla, si incide. È questa poesia materiale che ho imparato da mia madre.
Ho letto molti romanzi che hanno a che fare con la dittatura argentina, Aparecida di Marta Dillon è tra quelli che mi hanno colpito di più, per il modo in cui è stato costruito, per la sua durezza, per il suo carico d’amore, perché toglie via ogni schiaffo con una carezza.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/