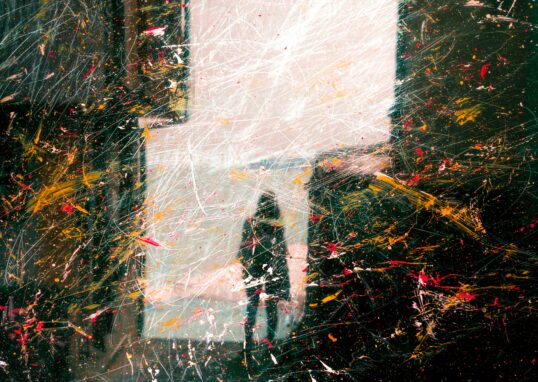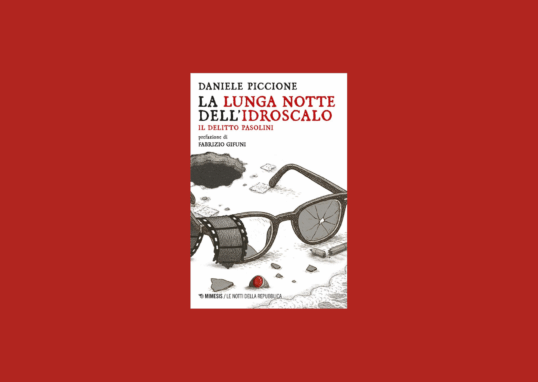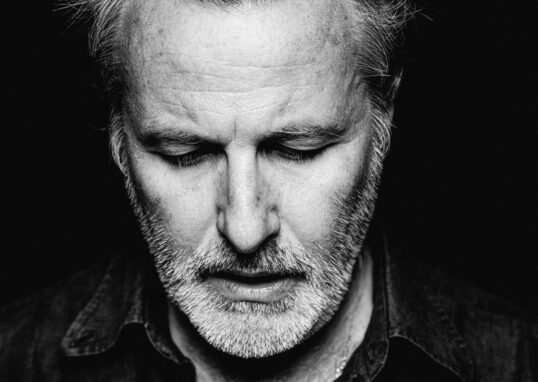Pubblichiamo l’introduzione e il sesto capitolo del saggio “Una possibilità del linguaggio. Pierre Menard come metodo” di Alfredo Zucchi, di prossima uscita per Mucchi.
*
di Alfredo Zucchi
Introduzione
“È verosimile che queste osservazioni siano già state enunciate, una volta o persino molte volte; la discussione intorno alla loro novità mi interessa meno della loro possibile verità.”
J.L. Borges
Questo esercizio esplorativo prende avvio dalla lettura di due passi di Foucault, contenuti entrambi nel saggio “La follia, l’assenza d’opera”.
Nel primo, il filosofo francese descrive un movimento di sdoppiamento e svuotamento del linguaggio; questo movimento è una fuga verso il basso e riguarda una certa esperienza della follia che, a partire dall’opera di Freud, conquista la regione dei linguaggi che implicano se stessi.
Nel secondo, Foucault associa questa esperienza della follia a una certa esperienza della letteratura a partire da Mallarmé. Il nesso tra i due è il linguaggio che implica se stesso.
Questo nesso, accennato da Foucault nella chiusa del saggio, ha azionato una catena di associazioni: per analogia è entrata in gioco la tradizione borgesiana della letteratura che implica e tematizza se stessa, con i suoi procedimenti metatestuali, metanarrativi e metaletterari. Posti l’uno di fronte all’altro, i due elementi hanno preso a contagiarsi: la figura descritta da Foucault ha aggiunto profondità – peso, direzione e conflitto – ai procedimenti borgesiani; questi ultimi invece, per via di un elemento tanto semplice quanto efficace – la gioia dell’inganno: la gloriosa ambiguità della finzione – hanno rinvigorito le riflessioni di Foucault, liberandole in parte da quell’aria di fatalità che Nietzsche ha chiamato “la malattia moderna”: il nichilismo europeo.
Insieme hanno scavato una traccia che è allo stesso tempo un varco e uno sbarramento: è un limite – del linguaggio, del pensiero, della rappresentazione. Questo limite, nelle parole di Foucault, è il volto visibile di una forma generale di trasgressione; questo limite, a partire dal racconto “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” di Borges (“perché questa non è la storia delle mie emozioni, ma la storia di Uqbar, di Tlön e dell’Orbis Tertius”) è divenuto forse l’orizzonte stesso della letteratura: il suo tema, il suo motore e la sua meta. Le due prospettive, mescolate per contatto, sembrano indicare che questa meta si trova in basso e dentro; che il movimento necessario per avvicinarsi a essa è il movimento del linguaggio stesso; che il modo di questo movimento è una fuga; che questa fuga, nel suo movimento, crea lo spazio che chi scende si trova di volta in volta a occupare; che questo spazio è un vuoto, una piega scavata dall’interno del linguaggio (quando si sdoppia e implica se stesso: una possibilità del linguaggio); che la condizione per adeguarsi a tale movimento consiste nell’abbandonarsi a esso senza riserve; che abbandonarsi a esso non è neutro ed è un rischio; che questo rischio è un affare personale, come l’amore, la vita o la morte.
[…]
Curioso pericolo
L’insieme semantico e simbolico a cui Foucault attinge nella Storia della follia abbraccia varie tipologie di insensatezza: tra queste, i mostri a metà tra l’umano e l’animale, gli animali impossibili come il Grylle tête-à-jambes di Hieronymus Bosch; queste “figure fantastiche”[1] informano e abitano, nel periodo storico che secondo Foucault precede appena l’esclusione e la riduzione al silenzio della follia da parte della “ragione classica”, la letteratura e in particolare le arti figurative[2]. Nel saggio successivo alla Storia della follia, “La follia, l’assenza d’opera”, Foucault associa poi follia e trasgressione per il tramite delle interdizioni di linguaggio. Facciamo, nel laboratorio centrale, un esercizio di associazione analogo.
Cervantes, a differenza di Cartesio nelle Meditazioni metafisiche – le quali, secondo Foucault, fondano l’esclusione della follia dal discorso della ragione, il suo internamento e il suo silenzio –, non ha inteso escludere e internare le “figure fantastiche”, ma trasformarle e farle slittare. Questo slittamento, e le sue conseguenze, sono il tema del saggio di Borges “Magie parziali del Don Chisciotte”. Scrive Borges:
“Paragonato ad altri classici (L’Iliade, l’Eneide, la Farsaglia, la Commedia dantesca, le tragedie e commedie di Shakespeare) il Don Chisciotte è realista; questo realismo, però, differisce essenzialmente da quello cui dette vita il secolo XIX. […] Nel Don Chisciotte [Cervantes] contrappose un mondo immaginario poetico a un mondo reale prosaico […]; per Cervantes il reale e il poetico sono antinomie. […] Il piano della sua opera gli vietava il meraviglioso; questo, tuttavia, doveva apparire, sia pure indirettamente […]. Cervantes non poteva ricorrere a talismani o sortilegi, ma insinuò il soprannaturale in modo sottile, e proprio per questo più efficace”[3].
È importante, in questo punto, accogliere lo slittamento e considerare “le figure fantastiche” nel modo più ampio possibile: non si tratta solo, come nel caso di Foucault, di immagini e simboli che indicano o veicolano una certa esperienza della follia; si tratta, al contrario, di un insieme più ampio di segni che il realismo letterario del secolo XVII esclude e assegna al novero del sovrannaturale (“talismani e sortilegi” e ogni altra figura fantastica propria della letteratura cavalleresca). Nel caso di Foucault, il termine oppositivo che le “figure fantastiche” indicano è la dimensione, tanto medica quanto giuridica, dell’assennatezza; nel caso di Borges che legge Cervantes, esse indicano per opposizione la categoria letteraria del realismo. In entrambi i casi si tratta di configurazioni mobili, la cui definizione varia secondo i contesti storici: dice Borges: il realismo del Don Chisciotte è diverso da quello del XIX secolo; dice Foucault: solo a partire dall’opera di Freud l’esperienza della follia conquista la regione del linguaggio che implica se stesso. In entrambi i casi si tratta dunque di indagare, di volta in volta, la traccia e l’esperienza del limite.
Quel è dunque il modo “sottile, e proprio per questo stesso più efficace” con cui Cervantes trasforma la materia fantastica nel Don Chisciotte?
“Nella realtà, ogni romanzo è un piano ideale; Cervantes si compiace nel confondere l’oggettivo e il soggettivo, il mondo del lettore e quello del libro. Nei capitoli che discutono se la bacinella del barbiere sia un elmo e il basto una sella, il problema è trattato in modo esplicito; in altri luoghi, come ho già notato, è solo insinuato. Nel sesto capitolo della prima parte, il parroco e il barbiere passano in rassegna la biblioteca di Don Chisciotte; sorprendentemente, uno dei libri esaminati è la Galatea di Cervantes, e risulta che il barbiere è suo amico e non lo ammira gran che, e dice che è più versato in disgrazie che in versi e che il libro ha abbastanza buona invenzione, che propone qualcosa ma non conclude. Il barbiere, sogno di Cervantes, o forma di un sogno di Cervantes, giudica Cervantes…
[…] Codesto giuoco di strane ambiguità culmina nella seconda parte; i protagonisti hanno letto la prima; i protagonisti del Don Chisciotte sono, allo stesso tempo, lettori del Don Chisciotte” [4].
Il mondo del libro si confonde con quello del lettore – siamo di fronte a un meccanismo metanarrativo, uno in cui il testo, il mondo del testo implica e nomina se stesso. Siamo di fronte al processo di sdoppiamento di cui scrive Foucault – tuttavia abbiamo ingrandito la lente: non si tratta più qui della singola parola, ma di insiemi di segni più grandi e complessi. Ricordiamo, prima di tornare a leggere Borges, il movimento che questo processo – questo gioco – di sdoppiamento e svuotamento provoca sul quarto insieme di parole interdette secondo Foucault: una “fuga incontrollabile [della parola] verso una dimora sempre senza luce”. Quale effetto provoca dunque questo peculiare gioco di sdoppiamento quando consideriamo un insieme più grande, un’opera letteraria?
Per rispondere alla domanda, nello stesso saggio, Borges usa l’esempio de Le mille e una notte.
“Questa compilazione di storie fantastiche raddoppia e torna a raddoppiare fino alla vertigine la ramificazione di un racconto centrale in racconti giustapposti […] È nota la storia che dà origine alla serie: il desolato giuramento del re, che ogni sera si sposa con una vergine che fa decapitare all’alba, e l’ingegnosa trovata di Shahrazad, che lo distrae con racconti, finché sui due hanno girato mille e una notte ed ella gli mostra il figlio nato da lui. […] Nessuna ci turba quanto quella della notte DCII, magica fra tutte. In quella notte il re ode dalla bocca della regina la propria storia. Ode il principio della storia, che comprende tutte le altre, e anche – in modo mostruoso – se stessa. Intuisce chiaramente il lettore la vasta possibilità di codesta interpolazione, il curioso pericolo che nasconde? Che la regina persista e l’immobile udrà per sempre la tronca storia de Le mille e una notte, ora infinita e circolare…”[5]
La “fuga incontrollabile” assume qui i tratti della proliferazione infinita di un evento. Scrive ancora Borges: “Le invenzioni della filosofia non sono meno fantastiche di quelle dell’arte: Josiah Royce, nel primo volume dell’opera The World and the individual (1899), ha formulato la seguente: «Immaginiamo che una porzione del suolo d’Inghilterra sia stata livellata perfettamente e che in essa un cartografo tracci una mappa d’Inghilterra. L’opera è perfetta; non c’è particolare del suolo d’Inghilterra, per minimo che sia, che non sia registrato nella mappa; tutto ha lì la sua corrispondenza. La mappa, in tal caso, deve contenere una mappa della mappa, che deve contenere una mappa della mappa della mappa, così all’infinito”[6].
L’orizzonte della fuga incontrollabile verso il basso è dunque l’infinitesimale, il quale diverge lievemente dall’infinito per il fatto di indicare un movimento di contrazione e non di espansione, un movimento verso l’interno e non verso l’esterno, verso il basso e non verso l’alto: è la discesa nel laboratorio centrale.
_
[1] M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, Milano, 2001, p 26.
[2] Cfr. Il primo capitolo della Storia della follia nell’età classica, “Stultifera navis”.
[3] J.L. Borges, “Magie parziali del «Don Chisciotte»” in Altre inquisizioni, Milano, 2005, pp. 49-50. Il corsivo a “meraviglioso” è mio.
[4] Ivi, p. 50.
[5] Ivi, pp. 51. I corsivi sono miei.
[6] Ivi, p. 51-52.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente