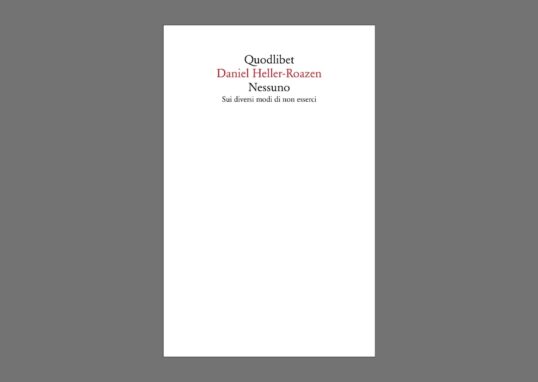Per Paolo Conte ho: preso treni in corsa, macinato chilometri in auto, risparmiato soldi, rischiato multe, cantato fuori tempo, ballato di tutto. E grazie a lui, l’Avvocato che difende le canzoni, esperto di fallimenti e romanticissimi falliti, creatore della saga del Mocambo, senza dubbio l’avventura più bella nella storia della musica italiana, ho realizzato che le canzoni non si spiegano, al massimo si raccontano. Con quella faccia un po’ così, Paolo Conte è il più grande classico della musica italiana, cantore del memorabile e pittore che abita le pieghe del nostro quotidiano. Dal bar Mocambo all’Harry’s Bar passando per Vienna, Genova e Timbuctu, i suoi luoghi dell’anima hanno dato vita a un manifesto poetico che ancora continua si muove leggiadro sui sentieri dei grammofoni. E oggi, proprio oggi che compie 86 anni, voglio ringraziare questo zio che spiega la vita, spiega com’è, spiega perché.
Quando si ha a che fare con la discografia di Paolo Conte, la domanda sembra farsi carveriana: di cosa parliamo quando parliamo di canzoni? Difficile prescindere dalla sintesi di musica e parole. Tradurre è un po’ tradire, le canzoni alla fine si commentano con le canzoni stesse. È questo l’atteggiamento simil ortodosso che in questi anni mi ha fatto scoprire le suggestioni musicali di Conte. Di sicuro il più intraducibile dei cantautori, anomalo anche in virtù del fatto che la sua musica e le sue parole potrebbero benissimo fare a meno l’una delle altre, trascurarsi reciprocamente poiché i suoi versi vivono di un’autonomia semantica vicina alla poesia e il disegno della frase musicale regge anche senza le strofe. È che dobbiamo dirlo, insieme, i due elementi creano uno spettacolo unico: è una combinazione complice, vincente. Le sue tracce bastano a se stesse, convincono anche quando decidono di traccheggiare, di prenderla calma, dire e non dire, fare cips cips, evocare fantasmi, alberghi, miraggi che potrebbero esistere o no. Prendete Boogie, e le “caramelle alascane” masticate dalla cassiera di una fumosa sala da ballo, costante dell’immaginario contiano. Si narra che in molti abbiano creduto a quel dettaglio e abbiano chiesto a grandi aziende dolciarie come acquistare quel particolare tipo di caramelle. Far credere all’irreale e immaginarlo possibile, questo è l’universo dell’Avvocato.
Un mondo in cui le canzoni non si spiegano se non vogliono spiegarsi. Si può provare a raccontarle come fossero fiabe, favole, fantasie. Tentando di rispondere alle parole con altre parole nel rispetto della magia originaria. Mi basta l’attacco di Via con me, l’andatura spedita di Bartali, lo sfinimento straziante di Chiamami adesso o il furore controllato di Sparring partner. Mi bastano quegli accordi che scivolano tra minore e maggiore, per ritornare a un’età lontana, a mondi interiori, mi bastano per ritrovarmi in strada ad aspettare il passaggio un ciclista, sotto la pioggia o in una camera d’albergo tra un accappatoio azzurro e un mondo freddo. Sono queste le belle canzoni che scavalcano ogni tempo e si fissano nella nostra memoria. Le sue sono commedie da tre minuti in cui gli eroi sono semplicemente uomini e donne che si incontrano, si amano, si lasciano.
Conte è un ladro di stelle e di jazz. Ma anche di rumba, di tango, di blues, di swing, di boogie. Generi e ritmi che ha rubato con la perizia e l’aplomb del perfetto furfante gentiluomo. Conte in realtà è proprio uno che ruba per amore e non soltanto per mestiere. Uno che vive di musica, di cui ha frequentato tutti i generi, li ha amati e poi traditi di continuo, con oscillatorio languore. Traendo da ciascuno il miglior accordo, il miglior ritmo. Troppo spesso si usa il termine Maestro a sproposito; ecco, Paolo Conte Maestro lo è davvero. Basta osservarlo dal vivo, come ammaestra la sua orchestra; è sufficiente uno sguardo, una smorfia, uno scatto del collo, i baffi che si alzano, tutto è direzione musicale nel suo corpo, seduto al piano, lo sguardo serio che tradisce sempre un sorriso sornione, le mani che si staccano dai tasti e si fermano sullo spartito mentre le dita ruotano. Non basterebbe una vita per poterlo studiare né per entrare in sintonia con la struttura musicale delle sue creazioni.
Se analizzare una struttura musicale significa, come scrive il musicologo Ian Bent, “scinderla in elementi costitutivi relativamente più semplici e studiare le funzioni di questi elementi all’interno della struttura data”, allora addentrarsi nelle canzoni di Conte ci porterà a individuarne le articolazioni, la muscolatura, la colonna vertebrale strofico-metrica su cui si basano. Significherà prendere un brano, smembrarlo, frazionarlo e smontarlo in ogni sua parte per poi ricostruire e cogliere fino in fondo la totalità di significato, il suo senso poetico. Significherà perdersi in quell’Arte che fa vivere la vecchia melodia italiana degli anni venti, assieme alle ballate dei cantautori moderni, ai suoni esotici dei dischi che i suoi genitori riescono a procurarsi clandestinamente visto il divieto imposto dal fascismo di ascoltare la musica americana. Sono distillati di un non luogo e di un non tempo in bianco e nero eppure pieni zeppi di colori. Le sue canzoni odorano di spezie, di sigarette, sanno di freddo e nebbia, baci rubati, liquori dai nomi fantastici e orchestrine jazz.
Più di una volta amici che conoscono il mio affetto per l’Avvocato mi hanno chiesto se Paolo Conte cantasse come “cantano tutti gli altri”. Classicamente, s’intende. Forse, per non litigare con puristi e insegnanti di coro, è meglio dire che mormora, blandisce, invita e corteggia – ed è l’unico che può farlo – con quella timbrica insolita, fra il casuale e il distratto, con un’originalità canora che spesso molti hanno visto vicina alla stonatura. E lo fa con espedienti linguistici rubati alla poesia: pause inopinate, tentennamenti, accelerazioni ritmiche, cesure, allitterazioni, metonimie: quella di Conte è una mitologia linguistica e semantica che abbraccia tanto Duke Ellington quanto Hemingway – peraltro omaggiato con candore nell’omonimo brano del 1982.
Penso al suono che ha Conte, all’onnipresente orchestrazione, sempre acustica che valorizza al meglio la fisicità degli strumenti, dalla tromba al sax, dai clarinetti all’oboe, e poi ancora fagotto, corno inglese passando per fisarmonica, bandoneon, mandolini, sempre partendo dalla chitarra e dal piano. Un rito religioso che sistematicamente viene interrotto dalla giocosità del kazoo, ormai vezzo dell’artista, quasi un sigillo, un attimo di comica leggerezza che investe il silenzio in cui si svolgono i suoi live. E poi il tempo di Paolo Conte: quello dei luoghi dell’anima è rarefatto, rappreso, ciclico, immutabile. Come in una fotografia che immortala luoghi e volti rendendoli eterni. E quello musicale, che si fa polimorfo, onnivoro: ora è quello languido del tango, ora quello frizzante dello swing, passando da quello struggente della milonga. Nel mondo di Conte si vive a passo di danza. A noi la scelta del tempo da seguire.
La scrittura di Conte non sentenzia mai, preferisce suggerire, accennare, è archetipica quanto basta per rimandare a una metafisica del quotidiano. E intriga proprio in virtù del suo dire – non dire. La cifra stilistica di Conte è la rarefazione, mai un accenno al politico, ma una partecipazione diretta. Le sue canzoni non sono autobiografiche in senso stretto, come ha sempre dichiarato, non raccontano nulla di sé in prima persona eppure rivelano molto del suo essere uomo, del suo navigare non per scoprire ma per riscoprire idee, valori musicali, essenze che riconduce e piega, ogni volta in maniera diversa, a un suo stile. Le storie che tratteggia sono d’altri tempi, si impigliano nella memoria come una nostalgia. E lo fanno grazie a dei testi che piazzano, sorprendono alle spalle, necessitano di una lettura interna, tra le righe. Anche se a volte dovremmo farci bastare il segno che lasciano. Prenderli per ciò che riescono a evocare e non per cosa significano. Gustarsi ogni attimo, ogni suono, immaginare una scena, assegnarle dei colori. Conte usa un lessico tutto di sua invenzione, vicino alle crittografie, vicino all’enigmistica di cui è un grande appassionato: in una scena del documentario che Carlo Verdelli ha dedicato al Maestro, Vinicio Capossela confessa di ricevere spesso complicatissimi crittogrammi che lo tengono sveglio la notte.
Paolo Conte è l’unico che può farci vedere “la luna del pomeriggio”, “cuochi ambulanti” che “soffriggono musica”, “una calma più tigrata” o chiedere “un sandwich e un po’ d’indecenza”. Ed è stato forse l’unico, in più di quarant’anni di carriera, a non abbandonare mai il sogno, vocabolo e concetto assai ricorrente nel corpus contiano, che non è, come si potrebbe pensare, eminentemente legato alla lontananza di scenari esotici. Ma è proprio quell’invito alla fantasia che ci fa credere che un mondo a prima vista dichiaratamente fantastico, può rivelarsi sorprendentemente realistico (o plausibile, il che è forse più interessante), riflettendo fedelmente la complessità e l’irrisolvibilità della vita.
Nascosto e felice nell’inconsueta geografia delle parole, nella sua musica che nasce dentro la musica, Paolo Conte è l’umorismo intelligente e vibrante che ci accomuna tutti sotto le stelle di quella rapsodia jazz che è la vita – tutto il resto è già poesia. Quindi grazie, e buon compleanno Paolo Conte.