di Fabio Stassi
Ho con Emilio Salgari un debito inestinguibile. La mia è stata forse l’ultima generazione a essersi formata su di lui. Per il mio decimo compleanno, chiesi ai miei un’edizione annotata dei suoi romanzi: un cofanetto Mondadori, a cura di Mario Spagnol, che avevo visto nella cartoleria vicino scuola. Il primo ciclo della jungla. Furono i due volumi più alti e più preziosi mai entrati nella nostra casa. Il primo riproduceva un fregio che Salgari aveva disegnato sul frontespizio di un suo quaderno. In alto un veliero, un mappamondo e un cannocchiale, tra i fulmini e la luce di un astro; in basso un’ancora, e in mezzo la scritta “Poesie” e il suo nome, in bella calligrafia. Il giorno che lo ricopiai, sostituendo la mia firma alla sua, iniziai anch’io ad avere un quaderno su cui scrivere. Fu un piccolo atto decisivo e iniziatico. Quei due libri li collocai poi sulla mensola delle cose a cui tenevo di più, accanto a un album di figurine del Risorgimento che non ho mai terminato.
Soltanto ora mi accorgo del legame che c’era tra quell’album e il mio cofanetto. Curiosamente, il mancato romanzo risorgimentale, quello che doveva fissare per sempre l’eroismo, e la dedizione ingenua a una causa, e l’ansia di giustizia e di riscatto, è questo giornalista veronese con la passione della scherma, degli aerostati e del velocipede a scriverlo. Un romanziere d’appendice che aveva più o meno la stessa età del Regno (era nato nel 1862) e millantava di avere solcato tutti i mari e di tenere in tasca un brevetto di capitano di gran cabotaggio.
L’altro romanzo, quello della disillusione e del tradimento degli ideali, saranno per lo più i siciliani a comporlo ma come un’opera collettiva, passandosi il testimone di una riflessione comune che può riassumersi mettendo in fila, uno dopo l’altro, i malavoglia, i Viceré di De Roberto, i vecchi e i giovani di Pirandello, il Gattopardo di Tomasi, il quarantotto di Sciascia, l’ignoto marinaio di Consolo e le menzogne della notte di Bufalino.
Salgari, il disincanto di come erano andate le cose lo aveva incarnato sulla sua pelle, e ne era stato stritolato. Dopo un primo quasi tragicomico tentativo di suicidio, crollò definitivamente quando restò solo, con i quattro figli. La moglie è affetta da psicosi. Lui non ha i soldi per una clinica e nel 1911 è costretto a ricoverarla nel Manicomio pubblico, dove la registrano tra i poveri. È “ormai un vinto”, come scrive ai figli, un uomo senza onore. “Spezza la penna” tagliandosi con un rasoio il ventre e la gola in un bosco fuori Torino, a 50 anni esatti dall’Unità d’Italia, la sola morte eroica che gli era rimasta. Fu la sua estrema rivolta contro chi si era arricchito con il suo lavoro, gli editori sanguisuga per i quali scriveva “a tutto vapore”, non meno di tre pagine al giorno, e che lo avevano abbandonato in uno stato di “semi-miseria” e di autentica disperazione. Un finale feroce e maledetto che si ripercosse sulla sua famiglia e sui figli in una catena inesorabile di infelicità (due altri suicidi, un incidente, la tubercolosi, la follia…).
Ma Salgari la tragedia l’aveva già alle spalle, che è come averla sempre davanti: una madre morta di meningite poco più che quarantenne (quando comunque lui aveva 25 anni) e poco dopo un padre suicida. Era cresciuto in una cascina di Negrar, un comune della provincia di Verona che suonava già come un nome inventato. L’intreccio tra la sua indole sognatrice e un vissuto così doloroso modificò la direzione delle sue storie, le inasprì, diede loro una risonanza inaspettata, e si può essere sicuri che Sandokan e il Corsaro Nero non avrebbero avuto una diffusione così universale se a generarli non ci fosse stato questo desiderio di rivincita che Salgari, nel chiuso della sua stanza, invocava per primo per sé stesso e che sosteneva per intero la sua fatica. Il suo Risorgimento, la sua rivoluzione, quella che doveva portarlo a un’esistenza migliore, Salgari li perse, come in gran parte li perse l’Italia. Ma si batté fino all’ultimo respiro. Ogni nuovo libro divenne una sfida mortale: lo scriveva con la sensazione di giocarsi sempre il tutto per tutto, con la consapevolezza di poter soccombere, una volta o l’altra.
In lui straripava lo stesso slancio giovanile che solo i diaristi o i cronisti dell’epopea garibaldina avevano provato a raccontare, un avanzo di tutta quella stagione di sconsiderata intrepidezza di cui doveva essere così imbevuto. Idealismi troppo languidi e ingenui, forse, per metterci le mani. Salgari lo fece con la rabbia di un adolescente che è arrivato tardi a una festa, e ci è rimasto male. Si sente come un rimpianto, il dispiacere di chi ha sprecato malamente la sua giovinezza. Solo pochi anni prima se ne sarebbe stato lì, sullo scoglio di Quarto o sulle barricate di Palermo, con una camicia rossa indosso, a morire per la Repubblica Romana o in una qualunque spedizione, oppure sul ponte di una nave, attraversando gli oceani e i continenti, e invece gli tocca in sorte una vita così mediocre da vivere, e piena di problemi, una vita che ci vuole una forza enorme per sublimarla…
Lo schema narrativo che usò per restituire nella finzione tutta la Storia a cui non aveva fatto in tempo a partecipare è di una semplicità quasi disarmante, niente di più che una decalcomania infantile. Me ne accorsi accostando un giorno per caso il mio album di figurine ai due volumi annotati. Le illustrazioni combaciavano, potevo sovrapporle. Sandokan aveva il viso e le mani da marinaio di Garibaldi: marinaio come lui, i capelli erano gli stessi, lo stesso il dono e il culto del coraggio; la mappa di Mompracem corrispondeva a quella di Caprera, l’isola del buen retiro; Yanez poteva essere Nino Bixio (che andò a morire di colera proprio nell’arcipelago malese, a Sumatra) o anche André Aguyar o István Türr o qualsiasi altro dei luogotenenti del Generale; i tigrotti, naturalmente i Mille; Marianna, la Perla di Labuan, che muore tra le braccia di Sandokan, ricalcava senza ombra di dubbio Anita nelle valli di Comacchio; l’Inghilterra colonialista sostituiva l’impero austro-ungarico, lo straniero oppressore, e sir Brooke il maresciallo Radetzky.
Salgari prese tutta la valigia dei sentimenti popolari che avevano agitato fino a pochi anni prima la nostra penisola e la rovesciò su una carta geografica presa in prestito. È lui il più grande cantore in maschera del Risorgimento. Non fece mai mistero, del resto, di avere modellato su Garibaldi il suo più famoso protagonista. Tutta la sua opera è e una celebrazione dell’eroismo disinteressato di chi aveva combattuto, un tributo alle dissennate imprese mazziniane, al sacrificio di Pisacane, alla chiamata a raccolta a Roma di tutti i ribelli del mondo, nel quarantanove, come accadrà solo nella guerra civile spagnola, un secolo dopo. Eroismi troppo presto repressi e disinnescati dai politici e dai diplomatici, ibernati per sempre nella retorica e nell’agiografia dei manuali o abbandonati all’oblio. Sentimenti buoni solo per un romanzo, che solo in un romanzo potevano continuare a pulsare. Così, mentre l’Italia si muoveva verso Adua, Salgari conduceva solitariamente la sua polemica anticolonialista e antimperialista.
Quando iniziano a uscire, a puntate, Le tigri di Mompracem è il 1883, la stessa data in cui si rilega Pinocchio. I due libri segnano una comune linea anti-don Abbondio. Entrambi inneggiano al coraggio e alla disobbedienza, e rappresentano l’orgoglio di un’altra possibilità, di un altro modo d’essere, una sovversione piratesca della vigliaccheria nazionale e delle altre ingloriose tradizioni di una stirpe di imboscati e di furbi. Sono passati poco più di vent’anni dall’Unità, e anche questo è un intervallo tipicamente italiano. Da noi, la riflessione sulla Storia arriva sempre un poco in ritardo, e spesso mascherata o trasposta; in alcuni casi non arriva mai, o si scopre molto dopo (è un’eccezione la Resistenza di Fenoglio e di Calvino). Come mi ha scritto un amico costretto a emigrare in questo nuovo secolo di spartenze e di uomini desterradi, l’Italia è un paese dov’è impossibile riflettere davvero, prendere coscienza di ciò che si è. Qui l’epica si traduce quasi sempre nella nostalgia di un’occasione perduta.
Salgari è intriso di nostalgia. Ha ancora addosso il gilet del giovane Werther come l’ultimo dei romantici. Per lui, ogni amore è un amore impossibile, e la sigaretta di Yanez dà sempre l’idea di essere l’ultima. Non a caso ama Dumas il mago, Dumas il biografo di Garibaldi e dei Mille, lo scrittore affascinato dall’azione, e non Verne lo scienziato. Ama naturalmente l’Opera e il Melodramma, che molto più del romanzo avevano intercettato i sentimenti risorgimentali (Verdi è una bandiera come nessun scrittore riuscirà ad essere). Sostanzialmente, il generoso mitomane che vive in un modesto appartamento torinese è un visionario, un irregolare, mai accettato dall’ambiente letterario, uno scrittore senza patente, fuori dalle università, un istintivo anarchico e cortese, antiaccademico, antiborghese, antideamicisiano, in definitiva un ingenuo bohémien che viene depredato dalla società e dai suoi meccanismi. È necessario per lui trovare una via di fuga, ma che sia clamorosa, iperbolica ed esagerata come sarebbe il suo carattere se non fosse frenato dalle condizioni. E la via di fuga che inventa è spettacolare: un altro continente, un’altra umanità con cui inscenare i suoi sentimenti. Pagina dopo pagina, un giorno dietro l’altro, Salgari ripopola il mondo di corsari, spadaccini, esploratori, di essenze d’oppio, e frutti tropicali, cibi malesi, “armonium di ebano con la tastiera sfregiata”: tutta la nomenclatura di un universo parallelo.
In realtà, quella dell’esotismo, per Salgari, è una pista sbagliata. In lui l’India non è mai India, e lo stesso discorso vale per la Siberia o per i ghiacci del Polo o per i Caraibi del Corsaro Nero o per l’America del Far-West dei suoi racconti minori. La geografia di Salgari è una geografia trasfigurata. Si può avvicinare allo scenario dei romanzi d’avventura che leggeva Don Chisciotte, alle quinte dell’Orlando furioso o della Gerusalemme liberata, ai fondali dell’Aida o della gazza ladra, al ciclo carolingio dei pupi siciliani. I suoi luoghi sono sempre luoghi immaginati: come tutti sanno, Salgari non li ha mai visitati di persona se non sulle enciclopedie della biblioteca che raggiungeva in tramvia. Il grado delle sue opere è esclusivamente “letterario”. Le sue pagine nascono da altre pagine, sono reportage da altri libri, non da altre terre.
Salgari è un tipo di scrittore puro: la sua fantasia si mette in moto solo attraverso l’incontro con le parole, ma devono essere parole strane, inconsuete, misteriose, parole in corsivo, parole in un’altra lingua. Tutte le sue storie non nascono che da suoni, come le filastrocche. Da un kriss, da un babirussa, dalla voce del ramsinga… i suoi personaggi più compiuti devono forzatamente avere nomi stranieri, altrimenti non prenderebbero mai vita: Tremal-Naik, Kammamuri, Sandokan e il più seducente di tutti: Yanez de Gomera. Particolarmente vicina alla sensibilità moderna, poi, la sua capacità di impastare la vita con la fantasia e di usare soggetti realmente esistiti come James Brooke per i suoi “romanzi con personaggi veri”. Parafrasando Vittorini, si può dire che il Borneo di Salgari “è solo per avventura” Borneo, solo perché il nome Borneo “gli suona meglio del nome Persia o Venezuela”. Contrariamente alle apparenze, Salgari resta uno scrittore profondamente italiano, che parla dell’Italia. Ha solo bisogno di un altro modo di chiamare le cose per riuscire a dirle. Occupa lo stesso posto di un narratore orale in un paese del Sud, di un cuntista con le sue tavole, e la spada di legno, le sue leggende. Ma è comprensibile da tutti che se avesse ambientato i misteri della jungla nera negli Appennini, la saga non avrebbe funzionato. In qualche modo, Salgari fugge dall’Italia come fugge dalla sua vita, la nasconde anche a sé stesso, le muta il nome. Ma è da lì che parte, ed è lì che rincasa.
Stranamente, nelle sue carte geografiche, il Sud America non assume lo stesso peso fantastico dell’Asia, nonostante sia stata la seconda terra di Garibaldi. Eppure proprio in Sudamerica Salgari viene letto e amato forse più che nel resto del mondo. I suoi libri sono sempre nella bisaccia di Ernesto Guevara e negli armadi di molti zii anarchici o rivoluzionari (in un racconto di Paco Ignacio Taibo II, i tigrotti sbarcano a Città del Messico e partecipano agli scontri del Sessantotto; ed è lo stesso Paco Ignacio a scrivere il seguito del ciclo indo-malese). Per tutti loro, messicani, cileni, peruviani, argentini, Salgari è principalmente la rabia, la rabbia, e poi l’avventura, la vendetta, l’amore, e infine la fatica e la disperazione, tutta quanta la vita, a dispetto dei critici letterari che non lo hanno mai amato e dei suoi detrattori.
Ma solo sotto il sole dell’Oriente, al riparo della sua luce che confonde tutte le cose, l’avventura di Salgari si unisce a un discorso più vasto sul destino, ai presagi, ai rischi mortali e alle guarigioni miracolose, alle delusioni storiche, ai drammi già vissuti e a quelli ancora da vivere. L’ombra dell’Asia di Salgari si allunga fino agli indovini di Terzani e al suo ultimo giro di giostra. Perché se in Sudamerica era stato il Che a raccogliere l’eredità salgariana nella pratica della lotta politica e della guerriglia nella foresta, nel nostro emisfero sarà Tiziano Terzani a indossare la giacca bianca del viaggiatore che Salgari aveva soltanto immaginato di essere.
Oggi, rovesciate le tradizionali geografie letterarie e la nozione stessa di esotismo, a cento anni dalla sua tragica fine, mi piace pensare a un Salgari indiano intento a scrivere con furia dell’Italia, divenuto il paese più pittoresco del mondo, e a mostrarci una piccola isola del Mediterraneo dove una banda di pirati libertari continua a condurre la sua resistenza corsara al dominio dei maharajà e dei James Brooke che avvelenano la nostra terra e ci tengono in ostaggio…
Fabio Stassi (Roma 1962) di origini siciliane, vive a Viterbo e lavora a Roma in una biblioteca universitaria. Scrive sui treni.
Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Fumisteria (GBM, premio Vittorini Opera Prima 2007). Per minimum fax: È finito il nostro carnevale (2007), La rivincita di Capablanca (2008), Holden, Lolita, Živago e gli altri (2010) e Il libro dei personaggi letterari (2015). Per Sellerio ha pubblicato L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio), Come un respiro interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria (2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio) e La lettrice scomparsa (2016). Ha inoltre curato l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013).






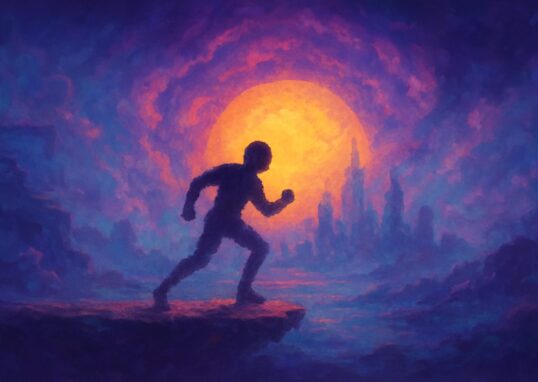

E’ una delle cose più acute che siano state scritte sul centenario salgariano. Complimenti vivissimi all’autore.
Ernesto Ferrero
Splendido “pezzo”. Preludio, auspico, di un tuo nuovo romanzo.
Bellissimo, complimenti!!
splendido. splende.
Lucidissimo questo articolo e, di conseguenza, il suo autore. Si vede la cultura senza esibizione, quella limpida che ti fa sorridere (di compiacimento) ma non ti annoia, e ti permette di comprendere ed approfondire.
Un capolavoro! Maravilha, Fabio!
Darwin
magnifico
Che meraviglia, complimenti!
Meno male che c’è qualcuno che si ricorda di E.Salgari. Leggere pezzi così, mi fa sentire orgoglioso di essermi ispirato al personaggio di Sandokan per il progetto di educazione finanziaria ” I pugnali di Sandokan ” che ho realizzato in una 5 elementare nel 1998.Lo trovate sul mio canale youtube.
Un grazie di cuore all’autore di questo articolo!
Giuliano Brilli
Non c’è dubbio: la tigre è ancora viva.
Complimenti, davvero illuminante.
Interessantissimo, denso, pieno di spunti di meditazione e con una scrittura magnifica. Mi unisco a tutti i complimenti altrui.
Rallegramenti. Questo prezioso articolo, molto acuto e profondo è davvero una luce che permette ripercorrere l’opera di Emilio Salgari scoprendo attraverso molteplici chiavi di lettura la sua grande attualità e modernità.
Grazie di cuore
NESSUNO RICORDA COME SALGARI VENNE SPREMUTO DAI SUOI EDITORI .lA CASA EDITRICE cARROCCIO CREBBE E PROSPERò SFRUTTANDO QUEL POVERO UOMO. ED I FIGLI PATIRONO M LA FAME GnON VIENE \