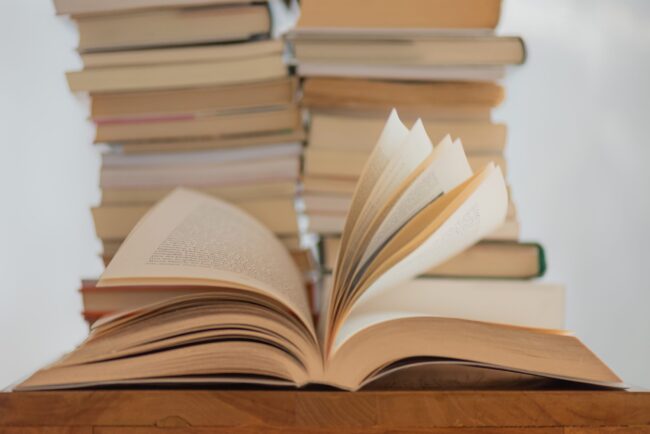
Photo by Elisa Calvet B. on Unsplash
Leggendo una poesia di Roberto Bolaño, per il canale streaming di «Decamerette», ho involontariamente sostituito in piedi ci sono solo i cordoni / della polizia con in piedi ci sono solo i cordoni / della poesia, mi è parso da subito uno dei più bei refusi di sempre. L’idea di una nuova rubrica è nata quel giorno, un appuntamento che facesse l’esatto contrario di ciò che fanno i cordoni della polizia: avvicinare. Accorciare le distanze. Per ogni numero si parlerà di una, due o più poesie, di vari poeti, cercando un filo comune, facendo sì che versi lontani si tengano per mano.
*
Parliamo di dissolvenza, di sottrazione, di come si scompare. Si può fare a meno di qualcosa, si possono togliere cose alla descrizione, se ne possono aggiungere alla visione. Cosa vediamo quando leggiamo? Quale immagine di un testo poetico viene in avanti con la baionetta in mano e quali (e quante) altre rimangono sullo sfondo, comparendo ogni tanto sfocate, lontano dal centro dello scatto eppure ugualmente importanti? Forse più importanti proprio per quella caratteristica che le fa balenare tra un verso e l’altro dopo qualche lettura, non a ogni lettura: oggetti inanimati, porte socchiuse, gambe che corrono senza che noi le vediamo, volti di profilo, un occhio chiuso, un occhio aperto, tre finestre che guardano verso l’interno, una sola che guarda il mare. Solo che il mare qualche volta scompare, e allora è un fiume, dopo un ruscello, nel verso più riuscito una pozzanghera. Il fango che non è sempre scuro, che muta colore a seconda dei riflessi, di chi lo calpesta, di chi lo tocca. Il tutto che è niente, perché non c’è e in quel non esserci si compie la sua vera realizzazione. Oggi andiamo a incrociare quattro poete, di età varie e che scrivono in modi decisamente diversi l’una dall’altra, eppure tutte e quattro sembrano aver ben chiaro che la prima cosa che l’occhio vede non è quella che conta sul serio, conterà più avanti quanto i sogni, le visioni, i miraggi, i vivi e i morti si mostreranno in un saliscendi, in un chiaroscuro, in una struttura libro, in una poesia. Autrici che trovano tanti modi di stare dentro la realtà, a volte sovvertendola, a volte guardandola di spalle, altre riducendola ai minimi termini sotto strati di fantastico, a volte immaginandola, dispiegandola in piccole magie, mai negandola, sempre distraendola.
Viola Amarelli è poeta campana e mi è sempre parso che la sua poesia si nutrisse della forza del magma, del fuoco, del mare vulcanico che agita quelle terre (che poi sono anche le mie) e allo stesso tempo agisse con moto respingente, rifiutando l’alimento. Bilanciandolo, come avviene durante un sisma, con il vuoto su cui grandi parti della regione si reggono. Un disequilibrio che in Amarelli si pareggia. La sua poesia si muove tra il tragico e la commedia, tra la vita e la morte (il confine qui quasi sempre scompare), tra il linguaggio classico e la sua reinvenzione costante. Amarelli governa il ritmo e muove i versi con un senso di rapidità che conquista. Sa essere fulminea e profonda, ciò che mostra non è mai il primo lato delle cose, oppure dimostra che quel primo aspetto è diverso da come lo abbiamo fino a qui guardato, lo era, lo è sempre stato, e, soprattutto, non è mai lo stesso. Il suo libro più recente si intitola L’indifferenziata (Seri editore, 2020), titolo non privo di plurivalenze e di ironia. Del resto Amarelli è ironica, non è poeta (persona) che si faccia impressionare dalle mode, dagli eccessi sperimentali o dai ricalchi della tradizione. Amarelli sta in un regno suo, interessante e vario, spesso inafferrabile ma sempre concludente. Quando scrive casa subito aggiunge spaiata. Non è tra le mura la comoda dimora, è sempre nella ricerca e nello sguardo. Una bella poesia è questa:
«capita di, sfiora paure non volendo
entra dentro, tocca non sapendo
rabbie, vergogne, specchio a se stessi
simili, capendo
sfiora, la mano e il sangue
si riconosce uguale
l’io di altri io
sciogliersi, come la madre
al figlio, come la foglia al battito
dissimilmente identica la linea nella curva,
la curva nella linea
tramuta, uguale, è non è
il segnale»
Questo testo rappresenta un interessante gioco labirintico, non ha entrata non ha uscita, perché non è. Il soggetto non si presenta, non appare. Ogni verso è destinato a sparire nel successivo, mentre si contraddice, nel negarsi si afferma. In questa ricreazione sta la poesia. Chi fa non vuole fare, chi sfiora non sfiora, ciò che si capisce sfuma, l’io è sciolto in altri io, è dissolto, non esiste; dovremmo ricordarlo che in fondo non siamo se non scomposti in altri somiglianti: esistere solo nel complesso, quindi nel levarsi. La linea è nella curva, allo stesso modo la curva è possibile solo nella linea, rinnovandosi mentre resta uguale. La realtà, per Viola Amarelli, è uno stato provvisorio, importante tanto quanto ciò che non accade, ciò che non si vede. E se la notiamo è solo nell’attimo in cui scompare, avanti, laggiù dopo la curva.
La Fata Morgana è un fenomeno scientifico, è una forma particolarmente complessa di miraggio che si scorge all’interno di una linea stretta posta al di sopra della striscia dell’orizzonte. Eppure già dal nome, dalla sua origine evoca qualcosa di magico e di terribile. Non era la Fata Morgana colei che conduceva i marinai alla morte, soggiogandoli con visioni idilliache? L’associazione più frequente e più nota dell’elemento Fata Morgana si realizza in Italia, manifestandosi lungo lo Stretto di Messina. L’effetto ottico generato dal miraggio fa sì che le cose, i luoghi si dimentichino della loro forma originaria. Guardiamo un’isola e questa si allunga, si muove, si dissolve. Ecco. Si resta affascinati e disorientati, da quello sgomento, che segue un minimo senso di perdita, si può ritrovare qualcosa in una nuova veste o forma. Che si tratti di un desiderio, una figura, un luogo, un affetto. In questo campo immaginario, in questo territorio semantico si è generata spesso la poesia di Marilena Renda: nella dissolvenza, nel turbamento compare ciò che serve a vedere meglio quel che ci era sfuggito, a ritrovare quello che avevamo perduto. La ricerca della poeta di Erice si mostra ancora più limpida nell’ultima raccolta che si intitola appunto Fate Morgane (L’Arcolaio, 2020), raccolta che rappresenta un lavoro in continua evoluzione, in prosieguo. C’è una poesia molto bella, tra le altre, osserviamola.
«Avvengono prodigi anche all’inverso,
per esempio un ponte a cui manca la mano,
una strada senza testa, una casa senza fegato.
Lo sguardo non crede a ciò che vede.
Com’è possibile che questo corpo sia stato spogliato
di un polmone nel sonno, o della milza mentre mangiava?
L’occhio aspetta che le forme si ricompongano
e che la verità sia ristabilita; finge di non sapere
che l’inganno non si è mai trasformato nel suo contrario.»
È vero, i prodigi avvengono anche all’inverso, del resto un occhio è anch’esso – più di altre – una cosa guardata. Renda al quarto verso scrive che lo sguardo non crede a ciò che vede, ma dal retrobottega sussurra anche il contrario: lo sguardo crede a ciò che non vede. Niente è realmente visibile, l’occhio che attende fingendo di non sapere, in realtà sa che niente può ristabilirsi nella forma originale perché un’origine non c’è, la forma è dissolta da prima, da sempre. Cosa ricomporre, dunque, se la milza o il polmone non possono rincasare? Chi riconoscere tra una madre, un padre, un fidanzato, una figlia? In questo miraggio, in questo tratto di vita sottile, discendente da terremoti e da quotidiani esili, nasce il disorientamento. Ciò che scompare in Amarelli qui si dissolve, restituendo qualcosa a cui aggrapparsi, in cui riconoscersi. L’effetto è proprio quello della Fata Morgana. Noi che leggiamo un po’ siamo marinai preda della leggenda celtica, un po’ siamo turisti che non sanno cosa fotografare mentre guardano una nave (o chissà cosa) sgranarsi nello Stretto di Messina.
L’occhio è da sempre protagonista della poesia di Carmen Gallo. Un occhio che vede ciò che può, vede molto più di quel che occorre, occhio che vede niente e cerca di tenere salda la vista in quel vuoto. L’occhio immaginario che non sta fermo e corre non perché insegue con la vista ma perché inseguito. L’occhio che sa che il vero è retto dal falso, che il falso troppo spesso è vero. Carmen Gallo è napoletana e io credo che l’esserlo c’entri con la sua poesia, l’oscillazione tra mitologia e sopravvivenza, tra ciò che accade sotto casa e quel che sta dietro lo Stargate deve molto al tufo partenopeo, perfino al suo odore forte eppure indefinibile. Nella poesia di Gallo insiste una perdita primordiale e una ricerca angosciosa non del sé ma del perché del come del dove. Si vede meglio al buio, si capisce di più sognando, l’immagine è più nitida se ciò che si guarda sta correndo. I versi di Gallo sono in fuga, il lettore deve essere attento e pronto a (in)seguire un filo che passa da mondi antichi alle case popolari, che annoda una pagina di un libro e muore alle soglie di una camera da letto. Il libro più recente dell’autrice napoletana è Le fuggitive (Aragno, 2020), di nuovo fin dal titolo qualcosa che non sta ferma.
«Tornare in superficie
come bocche di colpo spalancate
animali finalmente anfibi.
Dimostrare di avere imparato
il doppio respiro, a stare e restare
nello spazio indiviso dove le cose
accadono e basta. In questo gioco
chi si cerca e chi si nasconde
hanno la stessa faccia.
La paura costringe a forme di vita
innaturali, costringe a stare
nella durata di un altro.
Impossibile prendere aria.
Restituire la paura, lasciarla
sulla soglia di casa e dire
puoi tenerla o nasconderla in giardino
prima che il tempo e lo spazio propaghino
la sua forza. È novembre. Ho trentasei anni.
Mi porto dietro tutti i miei luoghi.
Faccio attenzione a non dimenticarne nessuno.»
Le cose dove accadono e basta, senza conseguenze, senza avvertenze, senza che si abbia bisogno di costruirci (o di ricamarci) sopra alcunché. La paura è nominata, ma non è la protagonista né del testo, né del libro. La paura partecipa al mondo delle cose, contano di più quelli che cercano e che si nascondono, hanno la stessa faccia, o nessuna faccia. Esistono, è lì sta la paura, nel riconoscersi e nello sfuggirsi, nel dilatarsi del tempo e dello spazio, nel luogo e nella sua scomparsa. C’è un doppio respiro ma manca l’aria, chi scrive si porta dietro tutti i suoi luoghi come un fardello e come un salvezza, e i luoghi non sono solo i posti, ma occhi, volti, mani, braccia. Si corre sul posto, si corre bendati con qualcuno sulle spalle, si fugge insieme a qualcuno, si prova a uscirne in qualche modo, a fondo pagina, a uscirne vivi. Tutto è troppo rapido per essere fermato dallo sguardo, ma può essere visto lungo i bordi di un confine che si dissolve, come l’io di Amarelli, come il corpo di Renda, come il fiato stesso di Gallo.
Un altro confine che s’annulla viene a raccontare Silvia Righi, mettendo in scena un teatro che si osserva dalla platea e da dietro il sipario, siamo sempre spettatori invitati, sottratti alla dimensione reale, a volte dobbiamo essere doppi, lasciando forse le gambe in poltrona e portando gli occhi e le mani dietro la tenda. Lo facciamo perché Righi lo ha fatto scrivendo, annullando il sé, scomponendolo in decine di soggetti senza dimensione che fanno avanti e indietro come il lettore/spettatore. La poesia di Silvia Righi si genera in un meccanismo a scomparsa, piccoli scrigni, piccole stanze, dentro c’è qualcuno, dentro c’è nessuno, dentro ci sono la vita e la morte. C’è un corpo nudo e un altro vestito e un altro si sveste, è un corpo che si sovrappone a un altro, è un corpo in due, è un corpo di donna di un uomo di entrambi di due donne di due uomini di tante e tanti. C’è un mondo sospeso in Demi-Monde (Nem, 2020), opera prima, un non tempo dove l’erotismo, il dissolvimento più che la messa a fuoco, l’illusione meglio dell’apparenza, la conseguenza del possesso di un oggetto davanti all’oggetto stesso, fluttuano raccontando più storie difficili da afferrare e perciò affascinanti. C’è una poesia che fa così:
«Questo è un teatro dei desideri.
Non credete, non abbiate fede
è un gioco per provare
mettere in scena copie comparse
sogni di sogni; si uccidano,
si stringano, brucino al posto mio.
L’illusione
mai sarà più vera
come sulle false labbra di un falso.»
Di nuovo incrociamo la dimensione del gioco, come monito, avvertimento, non dobbiamo credere perché dobbiamo affidarci totalmente a quello che non c’è. L’autrice desidera sottrarsi e vedere sulla scena altri creati apposta per fare l’indicibile o l’ordinario (la differenza è sottile). Sogni di sogni, scrive, la realtà il più lontana possibile. Ma qui siamo sulla soglia, l’intercapedine tra desiderio e perdita, tra il luogo e la sua messinscena. L’illusione se sarà vera nella parola falsa che esce dalla bocca di un falso, la verità tenderà a sopravvivere nella sua rappresentazione. C’è un mondo dal quale Righi scrive e una scia di universi possibili nascosti dietro i buchi delle serrature di questo libro che è come il corridoio di un albergo, si va a tentativi, di stanza in stanza. Bisogna sparire per indovinare la camera giusta o sbagliata di Righi, la curva di Amarelli, dove stia nascosta la milza di Renda, il tendine teso nella corsa di Gallo.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/

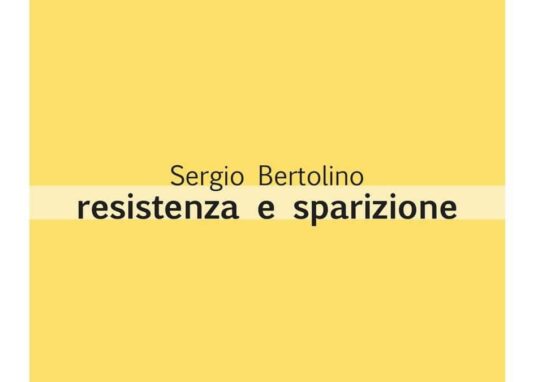



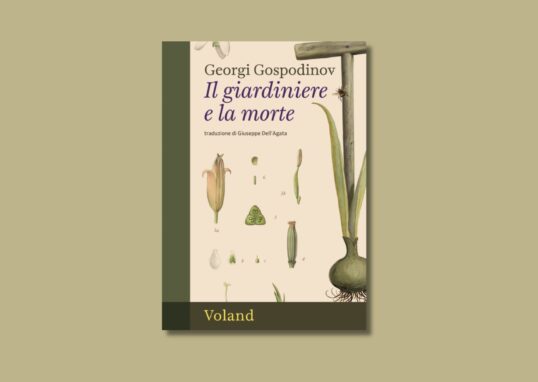

Complimenti per la selezione di questo elevato quadrittico, tra cui conosco meglio l’amica Viola Amarelli, che stimola un approfondimento di lettura.
Grazie Gianni per questa bella rubrica,
Marco
Caro Marco, grazie.
Gianni
Grazie per questo interessantissimo pezzo e per la selezione delle poesie. Letto tutto d’un fiato.
stefania
Cara Stefania, grazie.