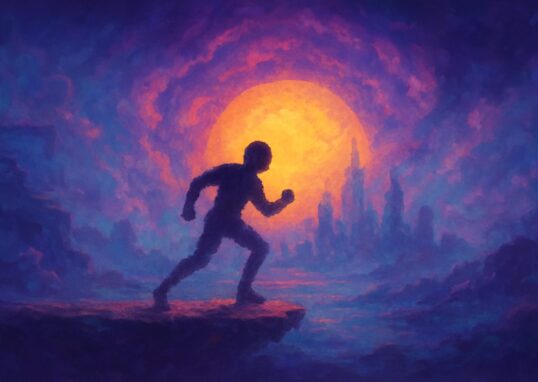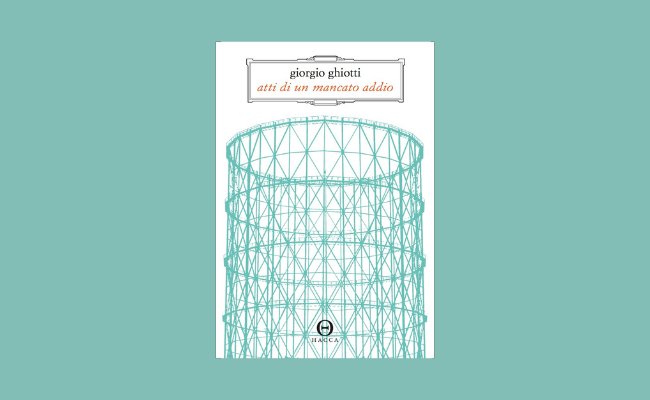
Da poco in libreria con “Atti di un mancato addio” (Hacca Edizioni), Giorgio Ghiotti ritorna alla prosa con una storia fatta di giovinezza che non è però un romanzo di formazione. Qui di seguito proponiamo una riflessione dell’autore.
di Giorgio Ghiotti
Mi accorgo, mentre scrivo questi appunti, che ha lavorato in me assai più il lettore dello studente di Lettere, molto più le storie dei saggi sottolineati – pure con allegria e interesse – all’università. Forse per questo mi sono trovato spesso in disaccordo con la definizione, per certe storie e certi protagonisti indimenticabili della letteratura, di “romanzo di formazione”. Perché mi appariva chiaro, più che l’approdo a un’idea di sé, l’approdo a un’idea di mondo. La dispersione anziché l’individuazione, la vastità ambigua del reale contro il formarsi di una coscienza solida, a bassa carica conflittuale. Un’identità pacificata e pacificante, risolta, come il migliore dei mondi possibili contro il turbamento e il gran battagliare che non appartiene esclusivamente alla giovinezza, ma alla vita sempre e a certe vite più di altre (la Madame Rosa di Gary, Maudie Fowler nel Diario di Jane Somers, la madre di Giornate intere fra gli alberi di Duras, tzia Bonaria in Accabadora, gli anziani genitori del Gigante sepolto, la nonna protagonista di Mal di pietre…).
Il romanzo di formazione costituisce una risposta e una possibile soluzione al conflitto tra l’ideale dell’autodeterminazione e le esigenze della socializzazione, nota Franco Moretti. Il che implica, in una certa misura, un processo di educazione alla socialità, o al “corretto stare in società”, dove il modo positivo in cui vivere socialmente si misura sull’aderenza a comportamenti, sentimenti e pratiche standardizzate. Un’idea precisa di adultità, non solo applicabile anche ai bambini, ma incoraggiata ad emergere quanto prima. Penso a quale choc sia, per la madre il padre e i fratelli, l’arrivo di Ben Lovatt in famiglia (Il quinto figlio; Ben nel mondo, Doris Lessing), e quale maggiore inaccettabile creatura diventi uno che come Ben, da bambino, ha sostituito la tenerezza con la violenza, l’educazione con l’istinto, la fragilità infantile con una forza inspiegabile, volta alla distruzione. L’allegria con la tristezza, la socialità con la solitudine.
Un romanzo di formazione ha per forza di cose in sé un’inclinazione pedagogica, ma una pedagogia ha bisogno di esempi, di modelli per essere esercitata. L’immedesimazione, anche parziale, è fondamentale nel processo di formazione; parlo di immedesimazione, non di empatia, che è invece, a me sembra, la base di ogni libero confronto e incontro con la vera letteratura – empatizzare col bene quanto col male, lasciarsi attraversare da altezze e abissi, senza temere di lasciarsi contaminare dal grigio dell’esistenza del quale siamo fatti. Apro una parentesi che potrebbe in verità essere il cuore di questi appunti, per dire che la formazione è, appunto, un processo che non ha mai fine, e non un risultato. Questo basterebbe di per sé a scongiurare il rischio di una facile equazione “romanzo di giovani (o giovanile) = romanzo di formazione”. Tutte le storie sono storie di crescite, inciampi, scoperte, amori, delusioni, prese di coscienza, spaventi, così come tutti i personaggi sono molto più complessi di una definizione. Una letteratura nella quale ci si riesca a riconoscere è una letteratura che si comporta come uno specchio, e nello specchio non ci si può trovare che l’immagine (tutt’al più deformata, o un poco manomessa) di sé stessi. Io credo alla letteratura come porta, una letteratura che, attraversata, spalanchi mondi inediti, offra nuovo pensiero, operando un ribaltamento di senso – o una risemantizzazione del mondo per come siamo abituati a intenderlo – che metta in discussione il già noto.
Io credo (in quante cose crediamo o crediamo di credere) nel sistema dei generi letterari, e anche nella possibilità (nel compito?) della letteratura di ibridare, reinventarsi, tradire quel sistema stesso. Credo nella seconda perché credo nel primo. Che è come dire – rubo l’espressione a Pavese – un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via. O ancora (mi rendo conto che suona come uno spot): le geografie, non meno che le storie. Ne approfitto qui per dire che un romanzo di formazione è sempre un Frankenstein: ha in sé qualcosa del romanzo d’avventura, del romanzo sentimentale, del romanzo per ragazzi, può essere un fantasy, o magari un horror. Harry Potter, It, Il Signore degli Anelli ne sono ottimi esempi. Per dirla con Virginia Woolf, “everything is always everything else”.
I ragazzini e le ragazzine protagonisti di Eravamo bambini abbastanza di Carola Susani, a fine romanzo (di quello che potrebbe essere considerato un romanzo di formazione), non approdano a una adultità, ma a una forma di nostalgia per quello che è stato, per il breve tempo nero e mitico vissuto con il Raptor (unico adulto/non-adulto della vicenda, a capo del gruppo), approdano a un disagio e a un terrore perché sanno che, finito il viaggio, si ritroveranno catapultati in un mondo che si aspetterà da loro una vita da perfetti individui socializzati. Aspettativa che non potranno soddisfare. Quando sei passato per esperienze simili, la normalizzazione sociale non può essere che una bugia o una recita. È proprio come scrive Paolo Zanotti in Bambini bonsai: “So che ormai è tardi. È finita l’infanzia, sono passate le tempeste. Eppure mi sorprendo sempre a tornare a quegli anni, testardo come un’ape che batte i campi verso l’arnia lontana e insieme soffocato da uno di quei sensi di colpa enormi, completi come mondi, che si possono provare solo da bambini.”
Massi, Edo, Trottola, Cecchi, Roberta, Mastino e tutti gli altri protagonisti di Atti di un mancato addio (e tutti i loro fratelli e sorelle maggiori letterari, dai quali discendono e ai quali devono così tanto), al termine delle vicende che racconto, non danno forma a un’identità – se mai imparano che l’unico modo per poter stare nella complessità del mondo, del reale, è, come scriveva Elio Pagliarani, “saltare saltare saltare / se no sulla coda ci mettono il sale.”
«Facevo questo gioco allora di estraniarmi da me e osservarci dall’alto, come una cinepresa. Chiusi in un pub di San Lorenzo, intorno a un tavolo, uguali a tutti gli altri ragazzi e ragazze del quartiere, non dissimili ai notturni abitanti dello Scalo, i più miseri i più disgraziati, eppure investiti adesso da un compito altissimo. Non mancano, nella mia giovinezza, esempi virtuosi di uomini piccoli, eroi improvvisati che, inaspettatamente, salvano il mondo in incognito: gli hobbit della Contea, i Perdenti dei Barren ai confini di Derry. La vita imbastisce grandi destini con pochissime cose. Non sempre le premesse determinano gli esiti.»
(da Atti di un mancato addio)
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente