
Pubblichiamo la versione illustrata di un racconto di Giordano Meacci tratto da Tutto quello che posso. (L’immagine di apertura è di John Stezaker)
di Giordano Meacci
L’ultima parola di questo racconto è del 2004. Primo maggio 2004, per essere precisi. Negli ultimi dieci anni, tutti quelli che lo hanno letto – così come chi l’ha scritto, a essere onesti – si sono costantemente trovati alle prese con una serie di congruenze paradossali tra le storie raccontate in Brechtdance e il tempo in corso tra il 2004 e oggi. Ora: che non si parli seriamente di profezia. La letteratura ha forse questo privilegio: confermarci che la questione non è prevedere il futuro ma guardare bene il presente (‘quello che c’è”, spiegherebbe la Blimunda di Saramago).
Così, giochiamo pure sul vecchio lancio orwelliano: di séguito, “l’anno che stiamo vivendo raccontato dieci anni fa”. Ma sempre con la consapevolezza prossima ventura dei versi di un poeta del Secondo Ottocento, Ernesto Ferranti: «Anche Cassandra / talvolta si stanca / del senno di poi: / “fin qui ve l’ho detto; / da qui, fate voi…”».
Brechtdance
Riusciva a ricordarsi a fatica
dei momenti della sua infanzia in cui era stato al centro dell’attenzione paterna; di quando, tra i sei e i nove anni, vestito da Estragone, da Šveik, da Padre Ubu, affogato nei veli di raso di Irìna Nikolàevna Arkàdina, oppure muovendosi con disinvoltura da minigangster in pigiama gessato, si divertiva a sparare su un suo ritratto a olio a grandezza naturale con una Beretta d’ordinanza. Una pistola carica che il padre lo aiutava ad armare e puntare (“Alza il cane, coosì, premi il grilletto… Bravo– ba-bàang”), in una rielaborazione “a pannelli” da Nostra Signora dei Turchi che lo stesso Carmelo Bene definì, una volta venuto a conoscenza dell’età del protagonista, “una crudeltà inammissibile”.
La fatica rugginosa dei condizionatori, in alto, vecchi di trent’anni, allagava l’ossigeno sottotetto del teatro di singhiozzi strascicati e lamentosi – enfisemi di polmoni d’acciaio che si mescolavano a vampate morbide di aria calda, al parlottare indistinguibile del pubblico di genitori: un bisbiglio sudato di telecamere digitali, risatine di compatimento, soggezione immotivata, cenni e torsioni improvvise del collo verso i vicini di fila. Da dietro la scenografia, che copriva metà palcoscenico – un fondale su ruote su cui era stata dipinta una libreria – Eugenio poteva vedere le scintille delle luci al neon del soffitto sul metallo cromato dei videofonini cellulari.
Incurante delle proteste più o meno silenziose degli spettatori, una teoria sparsa di trentenni e quarantenni in giacca o maglioncino girocollo, scollatura castigata da foulard e spille d’oro bianco, si alzava in piedi a sprazzi per puntare l’obiettivo sui visi dei figli. Come se la precisione mirata dell’inquadratura potesse incendiarne il tempo e concentrare i raggi dell’attenzione sui vestiti di scena, i tentennamenti impazienti dei minuscoli attori senza battute; e tutto in modo da permettere al dopo di mangiarsi il presente, avvicinando i poli lontani dei parenti alla recita: che si stava consumando nonostante loro e che però ne avvertiva l’assenza – sagome sorridenti in carne e pixel – nell’aria tiepida del teatro. Quello cui Eugenio assisteva dal suo riparo di quinta era la smania comune del ricordo: la nostalgia del passato ancora inavvenuto che si rende adesso già prima, prevede il futuro, riavvicina il tempo e lo spazio in un’unica ondata elettromagnetica bagnata dalla frenesia dell’orgoglio materno (o paterno: a seconda di chi, balzando in piedi come a un appello di leva muto, si assuma il compito della memoria).
Con gli occhiali appoggiati al cartone della libreria, all’altezza di un buco in una copertina verde disegnata di piatto, Eugenio rinveniva finalmente i giorni opachi della sua prima infanzia portentosa. Nella barba finta di Walter Regola, nella gualdrappa ridicola che sembrava caduta addosso a Clara dall’alto. Il blu coprente del velluto: e l’oro, ricamato a reticolo prunoso sulla stoffa pesante, creavano un effetto di soffocamento aggiunto; la rendevano l’incarnazione temporanea e ingigantita di un angioletto Thun con la gotta, mentre la bambina si trascinava da un punto all’altro della scena, in silenzio, compitando tra le labbra le parole di Walter a Stefano per non perdere la battuta.
Di schiena, oscillanti, gli altri bambini aspettavano il loro turno. Lorenzo, rapito dall’esplosione di luce del soffitto, era un Sagredo in pantofole alla strenua ricerca dei miracoli che gli si nascondevano nel naso: insinuava l’indice proibito fino al setto, per poi mettere alla prova il grezzo del tessuto, sulle maniche di panno, con poche pennellate di polpastrello. Marcello e Rosa si tenevano per mano, canticchiando la cover melodizzata di un vecchio successo rap di cui conoscevano soltanto il mm-mh-mmmh-mmàm-mmàam-màm iniziale. E infatti lo ripetevano ossessivamente da quando erano state aperte le tende rosse del sipario. Lontani dagli occhiali in metallo di Eugenio, gli attori momentaneamente fuoriruolo – lui si era raccomandato: “Fate finta di non esserci, siate voi stessi, finché non tocca a voi…” – eseguivano versioni private degli esercizi di riscaldamento vocali. Anche Lorenzo: che tra una pietra di paragone e l’altra, tossicchiava con cura l’inizio della sua prima battuta: “Così sarai in grado di pagare il macellaio– così sarai in grado di pagare il macellaio–”
Ludovico, che interpretava il ruolo di Ludovico e si chiamava davvero Ludovico (e per questo aveva avuto non pochi problemi analitici nell’abbandonare qualsiasi tipo di immedesimazione), camminava carponi tra il lavello piazzato al centro del palco e la panca di legno su cui erano seduti Francesco e Teresa: lui, annoiato da un’attesa che avrebbe comportato sei quadri prima del suo arrivo; lei, schiacciata da una parrucca porpora (con tanto di permanente e laccetti di raso) che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto ricordare l’acconciatura di Milva dei primi anni Ottanta; quando al Festival di Sanremo – così aveva provato a spiegarle Eugenio: Teresa ci aveva capito molto poco – “era riuscita a stregare il pubblico dell’Ariston cantando ‘La rossa’ a tutta gola”.
Davanti al lavello finto, Walter arringava Stefano dal riparo nascosto della sua barba di ovatta: un elenco a dito puntato verso un luogo preciso della platea, muovendosi esattamente come gli aveva consigliato Eugenio durante le prove.
“…Papa, cardinali, principi, scienziati, condottieri, mercanti, pescivendole e scolaretti”. Su pescivendole, unendo con una linea immaginaria la punta dell’indice di Walter al suo obiettivo designato, l’attenzione del regista dietro la libreria si spostò dal bambino (in tunica nera e medaglione ballonzolante sul petto) fino alla madre di Stefano, in prima fila.
La signora Moroni si ritrovò all’improvviso lo sprezzo teatrale e inquisitore del piccolo Galileo al centro dell’inquadratura. E per questo fece scattare in ritardo il flash della macchina fotografica, cogliendo suo figlio in una smorfia incredula per un richiamo evidente alla propria madre: tirata in ballo senza preavviso dal gesto didascalico e indagatore del suo compagno di scena.
Stefano aveva tre anni più di Walter; ed era molto più alto. A Eugenio era sembrato significativo proprio questo: un bambino che spiega a un altro bambino, più alto di lui ed evidentemente meno infantile, la necessità splendente di ogni verità, quando viene semplicemente esibita.
“Ti rendi conto, Walter?”, gli aveva detto Eugenio durante la lettura del copione. “La necessità di spiegare come l’intelligenza universale, se ben indirizzata – se cioè la questione estetica e l’attività etica vengono poste su un unico piano armonico – non abbia rispetto delle divisioni in classi”. Walter l’aveva guardato con la stessa espressione condiscendente di sempre. Un sorriso magro, disarmato, di quelli che non esistevano più nelle infanzie degli ultimi due decenni (almeno: Eugenio non li aveva più visti); e che lo trasformava in un uomo piccolo, allontanandolo dal bambino di sette anni che era: quasi l’esperienza che ancora non aveva, della vita, gli pesasse in una smorfia incompiuta, gli raggrumasse tutte le parole di Eugenio in un’unica, impermeabile accettazione della realtà che gli veniva offerta. Il torrente balbettante e sdrucciolevole di Eugenio – divagazioni, curve tortuose tra le parole in grado di far superare, in qualche modo, tutti gli ostacoli di linguaggio attraverso ponti tibetani di sinonimi scelti con cura, corde e rampini che separavano le rive tra i loro anni con impalcature sospese, appigli linguistici di fortuna – affogava Walter di chiarimenti irrichiesti, estasi interpretative piene di allusioni simboliche.
“Tu, Walter…”, gli aveva detto Eugenio, prendendolo da parte e facendo attenzione che Stefano non lo sentisse. “Quando… quando sarai sul palco, quando farai l’elenco di tutti quelli che– che verranno beneficiati dalla scoperta di Galileo, no?” – Walter aveva mosso la testa verso sinistra, l’aveva guardato in silenzio. “Tu cerca tra il pubblico la mamma di Stefano… La signora Moroni, la conosci?” – Walter aveva fatto cenno di sì, sorridendo. “Ecco: tu puntale il dito addosso quando dici pescivendole. Te ne ricorderai?… Sì… Bene. Perché– perché così ci sarà una fusione tra quello che dice Galileo e quello che dici tu, capisci?… Mi capisci? È uno… uno dei modi perché le parole che dici si riprendano la vita che hanno nascosto… lo capisci questo, è chiaro?”
Walter aveva capito; malgrado all’inizio Eugenio avesse avuto l’impressione che il bambino si limitatasse a seguire le labbra del suo maestro, parola dopo parola, senza comprenderle del tutto; fino a implodere in un cenno tentennante del mento in su e in giù, dopo l’ultima domanda, che però avrebbe potuto essere una semplice ratifica della fine; una cortesia. Dal sipario alzato fino alla fotografia in ritardo della signora Moroni, Eugenio aveva pregato il dio dei debutti che Walter se ne ricordasse: sarebbe stata quella – e solo quella – la conferma di tutte le speranze che Eugenio aveva riposto nel bambino.
“Io prevedo che noi non saremo ancora morti…”, stava dicendo ora Walter a Stefano – che lo guardava, intontito dalle luci e dal pubblico ai suoi piedi, in attesa della frase di attacco che gli avrebbe segnato la battuta (“O alba del mondo…”); mentre Ludovico cercava di alzare la gonna di Teresa e Francesco ridacchiava, indicando a Lorenzo la ritrosia infastidita della bambina con la parrucca – “quando anche sulle piazze dei mercati…”
Eugenio seguiva la schiena nera e svolazzante di Walter mentre si muoveva verso il proscenio, con gesti solenni da istrione consumato e una voce cavernosa che strideva, tra una parola e l’altra, degli accenti prepuberali: le ottave sopra che la incarceravano ancora in un’infanzia forzata. Dal nascondiglio verde-copertina del fondale, dal buco nella scenografia che gli permetteva di assorbire la luce del teatro, filtrarla, imprigionarla e poi riversarla all’esterno sottoforma di immagini del presente immediato, i pensieri di Eugenio si condensavano nell’aria intorno assumendo la figura invisibile di interrogativi senza risposta: come potesse, un bambino di sette anni, imparare a memoria, nel poco tempo di un allestimento elementare, monologhi lunghissimi e complessi; come riuscisse a passare da un ruolo all’altro con una facilità ininsegnabile: innata e stupefacente, davvero, si era detto Eugenio, incredulo, già dopo la prima prova. Quanto ci fosse – in sostanza: quanto Eugenio ci rivedesse – in Walter, di sé-stesso-bambino; magari a torto, e cogliendovi addirittura una grazia leggera che, per quanto si sforzasse – impantanato nell’imperfezione dei congiuntivi – non era capace di ritrovare nei suoi ricordi di antico protagonista ormai invecchiato.
“Quando anche sulle piazze – e nei mercati…”, Walter aveva ripetuto un pezzo di battuta: per cadenzarla, attirando l’attenzione sul futuro che la battuta prevedeva; l’aveva rimarcata in modo che le assi spoglie del palco, quella riproduzione veloce di interno che Eugenio e i bambini avevano allestito in meno di una settimana, diventassero subito, con un’emissione studiata della voce, lo scenario che prefiguravano: il Campo, i fiumi del Bernini, la Signoria, le guglie del Duomo, il mare in fondo al Plebiscito, San Marco in sella al leone alato; e una folla, sciamante e distinta in ognuna delle figure in movimento che la componevano, una sfilata quartostatesca di piazze in corteo, paesini medievali, rinascimenti ristrutturati: i secoli che si affastellavano volto su volto, tutto in un innalzamento d’accento, un flusso e riflusso di specificazioni che dalle piazze si immettevano nei mercati – un passo doppio del cambio, i mercati inghiottivano le piazze che il pubblico in sala era riuscito a scorgere tra le parole del piccolo Galileo.
“Quando anche sulle piazze – e nei mercati si discuterà di astronomia…”
Eugenio era certo di non sbagliarsi: l’ovatta brizzolata di Walter li teneva in scacco, incollati alla sua battuta come baffi finti sul labbro di Laurence Olivier; ripeterla un’altra volta e poi trascinarla, verso i cieli puri del Seicento rivisitato, era stato il dipiù che è concesso solo ai grandi artisti, alle rocce più alte e appuntite dei pinnacoli del teatro: una terna incalzante di suoni che prima li aveva chiamati, poi stregati in una paralisi a fiato sospeso, infine confermati nel mondo che Walter aveva ricreato per tutti quanti loro.
Ed ecco che, nel pieno del silenzio siderale che il bambino travestito aveva tradotto, dai buchi convessi dell’infinito fino al teatro della scuola elementare Bettino Craxi di Ariccia,
Walter concluse la porzione di battuta con un movimento ad arco dello stesso dito indice; che comprese, di nuovo, il punto nella sala dove sedeva la signora Moroni, e infine si estinse – a Eugenio sembrò che la punta del dito di Walter si imbevesse di luce tanto da brillare, un arco luccicante tra la platea e il palco – sul viso di Stefano: accigliato, e confuso, per l’ulteriore novità del gesto.
“Anche i figli delle pescivendole andranno a scuola…” – e qui Walter si era guardato intorno, legittimando la sua presenza in quel luogo – “E gli abitanti delle nostre città, / assetati di novità / si appassioneranno a una teoria degli astri / che faccia capo anche ai terrestri disastri…”
Stefano e la madre si guardarono sospettosi – Eugenio vedeva Stefano di profilo: ghiacciato dall’imbarazzo, aveva smesso di ballonzolare per l’attesa da un piede all’altro. Accanto alla signora Moroni, dopo l’arco di Walter e il secondo pescivendole, c’era stato un mormorio sommesso. Il fremito semipercettibile di bocche che si accostano alle orecchie, un ronzio indistinto che in occasioni come queste diventa reale anche se – anzi: soprattutto se – viene solo immaginato.
Walter aveva reinventato, al momento, un’azione che Eugenio, il suo maestro, il regista, non gli aveva mai proposto. Dal fuoco estemporaneo della sua improvvisazione, aveva estratto il giusto collegamento circolare tra il già detto e il nuovo, incandescente, così da rendere Stefano e la madre, l’infastidita signora Moroni in prima fila, una didascalia in carne e sangue: l’esempio estremo di quello straniamento che Eugenio aveva cercato di inculcare, nei suoi minuscoli allievi, fino a macerarsi di metafore edulcorate, giri di parole, esempi tirati fuori a caso dal paiolo freddo della divulgazione immaginifica prescolare.
E mentre Eugenio si commuoveva per la sorpresa di un Karl Valentin formato tascabile a una sfoglia di cartone da lui, Walter – ormai ancora più padrone della scena: nonostante le cantilene dietro di lui, il rossore sulle guance di Stefano, gli applausi immotivati e repentini di Ludovico dalla quinta di sinistra – continuò il monologo finché non fu costretto a un’interruzione anticipata dall’urlo fuoritesto della signora Moroni. Quando, ritornato davanti al lavello (e a Stefano), Walter Regola, Galileo brechtiano di sette anni, concluse la sua personale revisione del sistema solare; scatenando una rivoluzione in scala.
“E la Terra ruota allegramente intorno al sole / e insieme a lei”: eccolo che arriva, dalle profondità limacciose del tempo, lo shâh mât copernicano; la causa prima le cui libertà, vincolate da un rapporto – peraltro mai dimostrato – con un primo effetto da cui poi discendono tutti gli altri, hanno ripercussioni impreviste sullo svolgersi lineare delle azioni umane. Insieme con la traduzione dal tedesco, manipolata personalmente da Eugenio per produrre un effetto comico, un alleggerimento buffo e depistante dei proclami galileiani – l’errore improvvido che poi diventa nodo inerziale delle storie, la più banale e irreversibile delle leggi termodinamiche – il sorrisetto consolatorio di Walter tolse il tappo di decoro dal geyser troppo trattenuto delle rimostranze della signora Moroni.
“…Già: insieme a lei / (ve lo dice Galilei) / intorno al sole / ruotano mercanti, / prìncipi e principi, / cardinali, il papa / …e le pescivendòle…”
Un ruggito di risate in sala: ma per motivi purtroppo diversi da quelli che erano nelle intenzioni di Walter (e di Eugenio, evidentemente); e il grido selvaggio della signora Moroni.
“eh no!… e adesso basta!…”
Fasciata dal tailleur blu dei grandi eventi (e da una camicia bianca ricamata le cui balze sussultarono all’unisono con l’alzata in piedi), la signora Antonella Moroni, proprietaria insieme con il marito Pietro della Pescheria marematto, si trasformò in pupille dilatate e furore giustiziero di Medusa. I capelli – laccati secondo la moda recuperata della stagione precedente – si spostarono un istante prima di lei verso l’alto, attendendo in aria la testa livida che li raggiunse subito dopo, dispensando agli immediati vicini di posto un effluvio saponoso di balsamo Garnier ai frutti tropicali e di Curl Mousse di Wella.
“è la terza volta–”
Sul palco, spaventata dal grido in sala, Teresa restò senza fiato per un lunghissimo secondo munchiano. Quindi esplose in una quaterna di singhiozzi che spaventarono, dalla quinta fila, la madre e il padre; consapevoli tanto dell’ipersensibilità della propria figlia novenne quanto del suo rituale catalettico privato: l’apnea autoindotta che preannunciava il disastro. “Ora Teresa rifà la matta”, disse il fratello minore, cinquanta centimetri buoni al di sotto della spalla paterna, distogliendo lo sguardo per un momento dal duo di Digimon Robotics di ultima generazione con cui, dall’inizio dello spettacolo, inscenava combattimenti saturi di sodomia involontaria.
“non ci si comporta così… dov’è il maestro calveri?… esca fuori!”
Dal fondo, il direttore scolastico – i bigliettini da visita nel portafoglio lo denunciavano “dottor Elvio Picchi, pedagogo” – tentava di raggiungere il corridoio centrale tra le poltroncine al ritmo dei permesso, permesso, costringendo una fila scomposta di parenti a una ola cadenzata, piena di soprabiti e cappotti tenuti stretti come fossero i sostegni sussidiari di una parete invisibile.
Teresa si aggrappò alla giacca di Francesco e iniziò a urlare: un urlo a forma di i che le uscì dalla bocca come il filo di bava di una sirena bambina, le si curvò all’altezza della parrucca e percorse l’aria sopra le poltrone fino a spezzarsi contro i finestroni della parete opposta, in fondo alla sala. “Ecco qua”, disse suo fratello ai movimenti sussultori dei genitori, impartendo un colpo mortale (e una dura lezione morale) al Digimon-Skull of Evil trattenuto nella mano sinistra; e accompagnando con un pk-kow-pk-kow risentito lo sfracello della sua testa di plastica contro il vellutino della poltrona.
Paralizzato dietro alla scenografia, Eugenio si decise a uscire allo scoperto, mentre Walter e Stefano si guardavano intorno e tra loro: entrambi preoccupati da una qualche forma di punizione generica che, sicuramente, gli sarebbe piombata addosso da uno dei recessi oscuri del teatro.
Nell’affacciarsi, agitato, dal lato destro della libreria, la giacca di lana grigia di Eugenio rimase impigliata alla croce di legno che teneva su il fondale.
“eccolo qua, il responsabile”, disse la signora Moroni, indicando Eugenio alla gogna del direttore (appena arrivato ai piedi del proscenio) e al resto rumoreggiante della platea.
Con uno strattone, Eugenio si liberò dall’impaccio della giacca facendo pericolosamente oscillare la sagoma di cartone in avanti. Per evitare che cadesse – seppellendoli – su Walter e Stefano, oppose resistenza con troppa foga, determinando un contraccolpo tale da far cadere rovinosamente la libreria all’indietro: con un rumore di crollo che lo lasciò stordito, e con le mani rivolte al fondale a terra, come se ne volesse sottolineare il gesto circense: “Et voilàaa”, dicevano le mani di Eugenio, “esperimento riuscito”.
“si vergogni… si deve vergognare! lei è un meschino”, continuava a gridare la signora Moroni, che ormai aveva raggiunto, dopo lungo esercizio, il giusto tono da rumore di fondo. “Si calmi, signora Moroni, la prego”, le diceva il direttore, quattro sedie alla sua destra, nel corridoio centrale faticosamente raggiunto. “ma calmare cosa?”, rispose la mamma di Stefano, alzando la voce. “licenziare, lo deve, quello stronzo là…”: e indicava Eugenio, sul palco.
Attirata dal fracasso della scenografia caduta, scambiandolo per il rombo di cannone fittizio che avrebbe dovuto attirarla in scena, ignara della crisi generale e convinta che le urla facessero parte dello spettacolo, dalla quinta di sinistra apparve a saltelli Elena: il capino artificiosamente reclinato verso destra, un trucco pesante che la rendeva al tempo stesso inquietante e ridicola, un tamburello tra le mani con cui iniziò ad avvisare del pericolo incombente “i cittadini addormentati di Halle” – il bùm-bùm-bùm autistico di Kattrin la muta in Madre Courage e i suoi figli. Ludovico salutò l’arrivo di Elena con un altro applauso sfrenato, Teresa prese a battere i piedi e a scuotere la testa imparruccata in modo preoccupante (intanto i genitori, da sotto il palco, le dicevano: “Fée, Teresa, calmati): Clara, Lorenzo, Marcello e Rosa guadagnarono, facendosi forza l’un l’altro, il fondo interno del palcoscenico, nascondendosi dietro a un baule aperto pieno di vestiti.
“ha capito?… lo deve licenziare”.
Gli occhi di Eugenio si trovarono negli occhi stralunati di Walter proprio mentre il direttore rincuorava la signora Moroni, a voce bassissima, con un “provvederemo, signora… si calmi”. Indeciso fino a quel punto sul da farsi – Kattrin la muta continuava a saltellare a falcate, da un punto all’altro del palco, trascinando con sé il suo bùm-bùm ossessivo – Stefano si incamminò verso il centro della scena lentamente e – da un lato timoroso di veder perduto per sempre, punizione o non punizione, il suo piccolo momento di gloria; dall’altro intimamente, irrazionalmente certo, per come si erano messe le cose, che un suo gesto avrebbe potuto quietare gli animi e placare la madre – si decise a recitare a gran voce la sua battuta risolutiva.
O, del mondo aurora primitiva!
O respiro di vento che arriva
Da sponde tuttora inesplorate…
“e tu scendi da quel palco, imbecille!…”, disse la signora Moroni al figlio. Teresa smise di piangere, Ludovico applaudì.
Sette giorni dopo la morte di suo padre,
Eugenio disegnò la lapide su un quadernino a quadretti di quando faceva le elementari (sul verso rovesciato: dall’altra parte c’erano ancora calcoli al contrario pieni di [½ ∫ √ 3 x 7 + 11 – 49]); la tomba: come l’aveva vista al cimitero il giorno del funerale.
Una pietra smussata alla meglio – così lui: suo padre, aveva sempre detto di volerla – sepolta in terra “per poco meno di un terzo”. Un vaso da fiori in ferro battuto (“due soli fiori, uno per te e uno per tua madre…”) e la data di nascita e di morte. Nessun nome, così che Dio non lo potesse “rintracciare con facilità”.
Da quando aveva smesso di credere nelle potenzialità artistiche del figlio, Tommaso Calveri si era lasciato morire: gradatamente, prima; e poi di colpo, invischiandosi nel miele nero di una depressione ancora poco in voga, nella seconda metà degli anni Settanta (lontana com’era dalle certificazioni cliniche da rivista dei due decenni successivi); che però – confidando in una congenita predisposizione al deterioramento progressivo delle cellule cerebrali – non si era limitata a escludere Tommaso Calveri dal consorzio sociale, ispirandogli un senso di malessere esistenziale diffuso e di inutilità affettiva. Si era invece accanita su di lui, accrescendone da dentro le capacità affabulatorie, rendendo quella macchia oscura – che gli si allargava nello stomaco, a ogni levata di sole, con la foga inerziale del tempo che scorre – un macigno da esportazione; un peso che, oltre a succhiargli le viscere, ricadeva costantemente sulla testa di suo figlio.
Nel 1978, Tommaso si era accorto che il talento di Eugenio era poco più di un miraggio sopravvalutato, un abbaglio di contorno: l’esasperazione velleitaria di una svista privata che aveva trasformato in oasi, e in riparo, poche gocce d’acqua a mezz’aria. E così, fino al 1984, fino al riscatto ultimo dalla malattia (ottenuto al prezzo, gravoso, di una caduta libera dal terzo piano), la depressione di Tommaso – diventata mese dopo mese una figura tridimensionale capace di sostituirsi al padre che lui era stato un tempo – si era nutrita delle offese al figlio: delle violenze linguistiche che era riuscita a scovare, dalle croste più buie della propria natura di macchia, per rendere inaccettabile l’esistenza di Eugenio.
“Sei come un vestito della festa messo troppe volte, Eugenio”. Questo gli diceva, suo padre, quando Eugenio aveva solo dieci anni. “Hai presente il vestito nuovo che si indossa a Natale, o a un matrimonio? Quando lo lasci nell’armadio senza mandarlo in lavanderia, dopo la festa, e poi magari ti serve all’improvviso e lo tiri fuori, sei costretto a rimetterlo così com’è… Be’, figlio mio, è allora che dal vestito riemergono vecchie patacche di cui non ti eri accorto. Lo avvolge un alone di alcol, un retro…odore muschioso… È l’idea incarnata della gualcitura, anche se a vederlo da fuori potrebbe sembrare – potrebbe: ricordati… Potrebbe sembrare in buono stato”. Pausa. “Tu, Eugenio, adesso sei così. È bene che te lo dica io, che sono tuo padre, prima che te lo dicano gli altri. Sei come quel vestito lì”.
Eugenio, a dieci anni, aspettava paziente che il padre terminasse e gli regalava un “sì papà” pieno di rimorso; misto a uno struggimento da competizione e sconfitta: nella speranza che bastasse questo, al padre, per farlo ritornare felice.
E invece a Tommaso non bastava mai. “Troppo tempo, ti ho dedicato, Eugenio. Avrei dovuto capirlo che non eri intelligente come me. Che il tuo talento era un fantasma che vedevo io e basta… Hai soltanto rovinato la mia vita e la mia possibile carriera”.
E tutte quelle frasi, ripetute a oltranza per sei anni, dal 1978 al 1984, sempre più crudeli e gratuite proporzionalmente all’avanzare della depressione – e della malattia cerebrale che la alimentava, aumentandone le possibilità distruttive – si erano affastellate, una in fila all’altra, in quella fine di ottobre dell’84.
Eugenio riusciva a vederle, le frasi di suo padre, mentre si spintonavano tra loro: per entrare nel suo cervello dalle orecchie e ucciderlo, una volta riunitesi per sempre in un esercito berciante di parole. Così, per esorcizzarle, per affossare la loro caparbia volontà di esistere anche dopo la morte di chi le aveva create, Eugenio aveva preso dalla libreria della sua stanza il primo quaderno che aveva trovato. L’aveva appoggiato sulla scrivania e, con una Grinta nera, aveva disegnato la versione stilizzata e minimale del suo ultimo ricordo di Tommaso. “State lì”, aveva detto. “Entrate lì”. E – potere degli esorcismi di carta – tutte le frasi di suo padre gli avevano obbedito. Si erano calate dalle orecchie al quaderno, scorrendogli veloci sulle braccia con la frenesia di soldati cui venga annunciata la licenza prima della battaglia. Dietro di loro, erano scappati via anche i ricordi precedenti la malattia: i sorrisi di Tommaso quando restavano ore, da soli, a dipingere; le spiegazioni lunghe e tortuose con cui cercava di insegnargli una parte. Le volte che l’aveva preso in braccio e portato a dormire, quando si era spento su una sedia, all’improvviso, mentre Tommaso gli parlava. Per non perdere tutto; perché si salvasse una memoria selezionata e sopportabile di quello che era stato – almeno per gran parte della sua vita – Tommaso Calveri, Eugenio coprì il disegno con la mano.
Tra le dita, schiacciata come una fila di formiche in cordata orizzontale, gli rimase appiccicata la frase con cui tutto era cominciato. Le parole che suo padre gli aveva detto quando aveva sei anni, prima di curarne “l’addestramento all’arte”.
“Tu, Eugenio”, gli aveva spiegato Tommaso, “sei la reincarnazione di Bertolt Brecht”.
Davanti al direttore, quello che Eugenio riusciva a capire
era davvero molto poco. Nell’ufficio all’ultimo piano, con la porta chiusa a tre mandate – il direttore s’era messo la chiave nella tasca dei pantaloni, dopo l’ultimo cra-cratch – Eugenio, seduto, con ancora i vestiti di scena addosso, ascoltava in silenzio la ramanzina del “dottor Elvio Picchi”.
“…È davvero una situa∞*¶¡{§¿ incresciosa, Calveri… È, anzi, la dimostra∞*¶¡{§¿ evidente chee– che la nostra disquisi∞*¶¡{§¿ dell’altro giorno è passataaa… è stata– come dire? Fatta cadere nel vuoto, inosservata– Ma mi sta ascoltando?”
Eugenio fece di sì con la testa.
“Bene… Certo, io– insomma, non era mia inten∞*¶¡{§¿ arrivare a una solu∞*¶¡{§¿ di questa gravità in tempi così rapidi, Calveri… Ma la sua ostina∞*¶¡{§¿, davvero… l’incredibile ottutusità, mi lasci dire, con cui lei, lei– non ha voluto minimamente migliorare la sua condi∞*¶¡{§¿… E dopo tutto il tempo che avevamo passato a discuterne… È assurdo, Calveri… veramente assurdo…” Una semipiroetta alle spalle di Eugenio. “E inoltre è una prova della– della sua incapacità di accettare consigli… Nei suoi panni io, quantomeno, avrei provato a riflettere un momento, prima di imbarcarmi in una… una– sì, una provoca∞*¶¡{§¿ di questo tenore… Ma lei sembra non voler capire, signor Calveri. Davvero non vuole capire…”
Già prima di sedersi Eugenio aveva capito, invece, che non sarebbe stato in grado di seguire il ragionamento di Picchi. Sapeva che l’eloquio del direttore era affastellato di sostantivi pericolosi e inarrivabili, per lui, in quel momento della sua vita. Si ricordava con esattezza del gusto di Picchi per la ripresa, per la sottolineatura ostentata. La precisione con cui trovava, in ogni frase, il modo di ribadire i concetti attraverso uno sproloquio di suffissi incomprensibili – per Eugenio. Consapevole, del resto, che la colpa non era, ovviamente, imputabile solo al modo di parlare del direttore. La colpa vera era della malattia.
Così, stretto nelle spalle della sua giacchetta grigia di lana ruvida, i capelli rapati a zero – se li era tagliati quella mattina stessa: ancora non si era abituato al senso di mancanza che la nuova testa gli comportava – gli occhialini tondi con la montatura in ferro dorato comprati in occasione della prima, Eugenio riusciva a cogliere la stizza di Picchi nei passi crocchianti che il direttore scandiva nel parquet dietro di lui; nei bruschi cambi di tono tra una scomparsa della voce e l’altra.
Galleggiando sulla spuma maldimarica dello stordimento, trovava una conferma generale delle decisioni del direttore nei suoi gesti: in poco tempo aveva imparato a sue spese che rivelavano molto di più, se solo li disaccordava dalle parole. “Come quando ci si concentra sul labiale di alcuni attori nei film degli anni Sessanta e Settanta”, pensava, un sorriso di circostanza a uso di Picchi, “e ci si trova
perfettamente: ‘diciòtto, novantòtto– dièci, dùe, diciannòve, cinquàntasèi’… i due fiumi paralleli della vita fortuita e del doppiaggio: il modo in cui la realtà filmata (la verità fittizia che filtra dalle riprese) può essere riscritta, aggiunta, divagata, corretta; e intanto si biforcano le due strade fuorisincrono del significante e del significato; perché poi i numeri detti a caso sono quello che davvero la persona viva, la carne e il sangue e le viscere della persona viva che parla, ha cercato di dire realmente al presente che aveva intorno– l’espediente dello schermo numerico, il ritardo sulle parole, era stato usato da tutti, più o meno, da Tanio Boccia a Federico Fellini; perché l’idea dell’arte di Orson Welles e di Ed Wood jr può anche essere la stessa, diverso è il modo–” Si ricordava, Eugenio, di quando in Straziami ma di baci saziami di Dino Risi il treno si fermava a un passo dal suicidio di Nino Manfredi e di Pamela Tiffin, e il frate domenicano che si affacciava oltre lo sbuffo di fumo gesticolava contro la fine delle speranze: e le sue labbra scandivano due, tre, quattro, cinque, sèeei, sèeette, mentre la voce futura del doppiatore si sostituiva alla verità arbitraria di quei numeri con ‘vede e provvede, la Provvidenza’…
era la malattia che lo costringeva a queste distrazioni a intarsio. Obbligandolo a una fuga momentanea dalle frasi che riusciva a ricostruire, a stento, dopo ogni pausa, in quella danza forsennata che le parole si ritagliavano nella voce di Picchi. Una danza di silenzi ovattati e di musica inesprimibile che stordiva Eugenio e lo rendeva incapace di repliche sensate.
Ipofasia di Dipentelz, si chiamava la malattia. Ellissi selettiva della “memoria immediata”. Regressione alla fase prelinguistica “con deviazione mirata dell’apprendimento”.
“Ha capito, ora, Calveri? Ho ricevuto un’ indica∞*¶¡{§¿ precisa, non posso fare altrimenti…”
Picchi gli stava semplicemente comunicando la ratifica ultima del suo licenziamento. Inevitabile, ormai. Ne avevano parlato una settimana prima (anche se attraverso il paravento burocratico dei se e dei valuteremo), il giorno stesso in cui Eugenio era andato da Picchi a chiedere il permesso per la recita. “Ah, giusto lei, Calveri–”, aveva esordito il direttore. E tra musica e incomprensioni, Eugenio era comunque riuscito ad afferrare che la sua esistenza lavorativa era in bilico tanto quanto la sua vita normale di parlante e di ascoltatore. Questo, malgrado le indubbie doti reattive che l’avevano portato ad affrontare (e a gestire) per mesi, senza farsi accorgere dai bambini e dai colleghi, quello che lui stesso pensava come “il principio di una capitola∞*¶¡{§¿ dolorosa al grottesco irrimediabile della realtà”.
Tre mesi prima della recita, una mattina di agosto,
Eugenio si era svegliato con un’impressione di pesantezza allo stomaco, subito ricondotta – non appena il sole della mattina l’aveva centrato in pieno viso, incidendogli tra le sopracciglia e il naso una versione in negativo e sovraesposta della maschera di Zorro – alla cena messicana della sera prima. Con Vittoria, sua moglie, avevano deciso, per una volta, di dimenticare i calcoli domestici cui erano costretti quotidianamente (i 2380 euro ridicoli dello stipendio mensile di lui, i 1100 euro della cassa integrazione di lei) e di andare a cena fuori a festeggiare l’8 agosto; i diciassette anni del loro matrimonio.
In palese, ribelle affronto alla stagione e agli obblighi alimentari della nuova legge sulla salute, Eugenio aveva sfidato gli dei microbiotici della sua ulcera rettale con una doppia porzione di chili con carne “alle triple spezie”.
Così da convincersi, la mattina dopo, che una seduta dolorosa sulla tazza del cesso sarebbe bastata a cacciargli via la pesantezza; sostituendola con un bruciore focalizzato, magari: ma riparando dietro diagnosi conosciute il disagio fastidioso di quell’impressione che l’aveva svegliato.
Vittoria era addormentata e borbottante accanto a lui, nel letto. Le lenzuola le si erano appiccicate a onde, sulla pelle, come se le avesse espulse lei dal proprio corpo durante la notte. “Prepari tu la cola∞*¶¡{§¿…?”, gli aveva detto; emergendo per un attimo da quel mare sudato in cui s’era avvolta – un movimento innaturale della testa, un doppio battito di ciglia: il coperchio di un portagioie che si richiuda con uno scatto imprevisto sulla mano del proprietario.
“Cosa?”, aveva chiesto Eugenio, con ancora nelle orecchie l’accenno di una musica sconosciuta che si era sovrapposta alla voce della moglie.
“La cola∞*¶¡{§¿…”, aveva ripetuto Vittoria; voltandosi verso il muro e trascinando con sé il groviglio bianco del letto.
Come fosse stato estratto da un forcipe invisibile, il grumo di pesantezza nello stomaco gli era scomparso all’improvviso, lasciando al suo posto un cratere informe dentro il quale cominciava a franare la sabbia di una serie indefinita di terrori remoti e indistinguibili.
Eugenio era sicuro di avere sentito di nuovo la stessa musica provenire dalla voce di Vittoria. Non poteva sbagliarsi. Prima un numero impreciso di sillabe (scomparse, nella sua memoria recente di appena svegliato: soffocate dalle note che ne erano scaturite), poi la battuta, o le battute iniziali di qualcosa. Non avrebbe saputo dirlo con assoluta certezza, perché la musica aveva affogato le parole intorno, espandendosi in un accenno di melodia che l’aveva sorpreso. In più, non appena aveva provato a ritornare a tutt’e due le volte in cui Vittoria aveva borbottato una qualche richiesta, si era reso conto – di questo in modo compiuto – che della musica, delle battute, delle note, aveva una consapevolezza che implicava insieme la natura dei suoni e l’immagine visiva di quegli stessi suoni: numeri, iscrizioni fuoririgo piccolissime. Segni che non credeva di poter distinguere – perché lontani, sbiaditi: come fossero visti da un cannocchiale rovesciato – ma dei quali aveva una percezione esatta. “Come quando ci si sveglia di botto”, aveva spiegato di lì a un paio di giorni al neurologo, “e per un momento, un istante brevissimo, ci si ricorda perfettamente del sogno – dei sogni, di tutte le connessioni che ci hanno portato fino alla… al finale, no? E però tutto, anche la fine del sogno, che ci ha svegliati, scompare senza traccia… Ecco, dottore: a me rimane questa impressione di– di perdita di tutto un mondo che invece una parte di me conosce benissimo e, anzi, lo sa riconoscere, quando lo vede o lo sente, non lo so…”
Seduto sul letto, quella mattina di agosto, aveva costretto Vittoria a svegliarsi e a ripetere quello che aveva detto. La moglie l’aveva guardato, con l’odio familiare di chi è ancora immerso nel sonno e non vorrebbe uscirne nemmeno a costo della vita. “il caffè”, aveva detto, infastidita. “Ho chiesto se facevi tu il caffè…”
Per un solo istante Eugenio si era rasserenato; per poi rendersi conto che il ritorno mancato del fenomeno era solo momentaneo. Che il ricordo nebbioso di quella musica – il suono, le note che lo indicavano – era troppo reale, troppo evidente perché lui potesse davvero dimenticarlo così, considerando quello che aveva sentito come una prosecuzione allucinata del sonno.
“No, Vittoria, perfavore– Le parole esatte… Ripeti le parole esatte…”
Mugugnando, Vittoria aveva scansato le lenzuola spostandole sul lato del letto di Eugenio. A Eugenio era sembrata bellissima, con la camicia da notte trasparente che si era impossessata delle curve morbide del seno; le tette, rilassate, che digradavano sui versanti opposti dei fianchi con la grazia meravigliosa di un disfacimento leggero: gli anni posati sulla carne di Vittoria come un lungo, soffice abbraccio di Eugenio che le schiacciava il seno e rannuvolava le cosce di confini nuovi, più larghi: come se respirassero in cerca di nuove linee di pelle – ∞*¶¡{§¿, sentì Eugenio. Ritornando con uno stolzo dalla fuga lungo il corpo di Vittoria. “Io non dico a letto”, aveva continuato lei, infilando i piedi nelle pantofole – sulla schiena, due fossette sotto le scapole sembravano le cicatrici di un intervento – “ma almeno stamattina, dico: almeno una volta alla settimana…” – un intervento chirurgico, come se le avessero asportato le ali – “la cola∞*¶¡{§¿ la potevi fare tu”.
Eugenio le si era precipitato alle spalle, aggrappandosi a lei di schiena, “Vittoria”, era riuscito a dire, spaventato. “Vittoria…”, e si era stretto forte a lei, come se quello fosse l’unico modo di proteggersi da sé stesso, l’ultimo saluto prima di morire.
C’era voluta l’intera mattina, una mattina di sabato
piena di frenesia e di numeri di telefono (neurologi trovati sulle pagine gialle, l’irrintracciabilità del medico di famiglia, segreterie telefoniche di cliniche private con in sottofondo musica reggae remixata o la marcia trionfale dell’Aida).
Eugenio aveva provato a spiegare a Vittoria la storia della musica – che si riproponeva di tanto in tanto, mentre lei parlava, agitata, in cerca di chiarimenti. Ma, come per tutti i problemi che diventano banali solo una volta trovato il modo per risolverli, Eugenio era incapace di fermare in tempo la moglie indicando con precisione le parole giuste che scatenavano il fenomeno. L’avvento della musica svaporava il resto della frase intorno – prima e dopo – rendendo impossibile rintracciare un punto esatto nel discorso.
L’unica cosa che Eugenio e Vittoria avevano capito era che non era una sola parola a condizionare l’avvio della “battuta” – così la chiamava lui, dopo averle spiegato che intuiva, in un senso che non era possibile determinare, anche la consistenza fisica della visione. Tra la disperazione crescente di Eugenio e lo sgomento assonnato di Vittoria, inoltre, non era stato facile delimitare con cura il campo d’indagine. Avevano provato ad analizzare la circostanza – Vittoria in vestaglia, seduta sul divano; Eugenio in boxer e a torso nudo che si massaggiava le tempie girovagando senzameta da un punto all’altro del salone – constatando che 1. sicuramente c’era una ragione: una scintilla di qualche tipo che scatenava l’incomprensione di Eugenio, anche se non riuscivano a identificarne le cause partendo dall’incertezza descrittiva dell’effetto: “la musica”; e che 2. questa “strana allucinazione auditiva” – Vittoria si ostinava a definirla così, nonostante il diniego ripetuto di lui – poteva dipendere tanto da un principio di esaurimento nervoso del marito, quanto dal primo manifestarsi di una malattia cerebrale ereditaria, visto che era a conoscenza della storia personale di Eugenio e dei problemi che aveva avuto suo padre.
Alla fine, stanca – e preoccupata – dai continui “ripeti, prova a ripetere…” di Eugenio (che non portavano a capo di nulla, visto che l’eco non del tutto spenta della musica si sommava alla ripresa di battuta), l’anima sistematica dell’infermiera – attualmente allontanata dal lavoro ospedaliero – Vittoria Bernelli in Calveri prese il sopravvento. Vittoria sfilò il vocabolario dalla fila di volumi della libreria e cominciò dall’inizio, leggendo a una a una, dalla a in poi, tutte le parole. Ci vollero sei intere pagine di abbandono, volontà di abbarbicare, esasperazioni da abbondanza concluse in un abbraccio (Vittoria che ogni volta alzava gli occhi dai lemmi e fissava Eugenio in attesa di un cenno, muto, di ascolto interiore) prima di arrivare all’esplosione della prova.
“Abbrevia∞*¶¡{§¿”, aveva detto Vittoria. Eugenio l’aveva guardata senza capire, gli occhi e la bocca riempiti da una musica che sentiva solo lui. “Ab-bre-vi-a-∞*¶¡{§¿”, aveva ripetuto lei. Dieci minuti dopo, dopo dieci minuti di tentativi, messe a fuoco sbagliate, parole saltate nell’aria della stanza come note lasciate cadere da un pianoforte della memoria, sia Vittoria sia Eugenio erano riusciti a capire che lo strano fenomeno della musica esplodeva a ogni suffisso -zione (diceva lei); agni∞*¶¡{§¿, perdi∞*¶¡{§¿, vesti∞*¶¡{§¿, ambi∞*¶¡{§¿, stagna∞*¶¡{§¿. Vittoria parlava e gli occhi di Eugenio si colmavano di una ripeti∞*¶¡{§¿ ossessiva e incomprensibile della stessa musica sconosciuta. Neanche pensare, gli riusciva più: se si concentrava sulle parole di sempre, ritrovava quel motivo impossibile da descrivere; anche le frasi di suo padre si trasformavano in uno scoppio di note che schizzava sui ricordi intorno, allagandoli di suoni prolungati. “Tu, Eugenio, sei la reincarna∞*¶¡{§¿ di Bertolt Brecht”.
“Prova a parlare”, aveva detto lei, con calma. “Prova a dire emo∞*¶¡{§¿… Provaci”.
Eugenio l’aveva fatto. Una volta capito qual era il segmento di parole che gli si trasformava in musica, aveva provato a ripetere inerzialmente le sillabe che aveva sempre usato senza fatica. “Emo∞*¶¡{§¿”.
“L’hai detto giusto, Eugenio, hai detto emo∞*¶¡{§¿…”
A Eugenio era venuto da piangere; Vittoria aveva cominciato a dedicarsi alla ricerca telefonica di qualcuno che potesse aiutarlo. Qualcuno che fosse in grado di decifrare il male partendo dall’ossessione di una sola battuta; o due. Anche senza conoscere la musica.
E ora, come dire a Picchi, senza giustificarsi,
che le sue parole gli erano oscure più dei suoi gesti; che gran parte di quello che il direttore scolastico diceva gli era incomprensibile; che Eugenio Calveri – ancora vestito “da Bertolt Brecht”, in previsione della sua entrata in scena alla fine del monologo di Walter: per questo la giacca grigia, gli occhialini e la rasatura – soffriva di una malattia specifica e (per quel che ne sapeva) incurabile?
“Mi vuole dire perché ha voluto essere così offensivo con la signora Moroni, eh? Un tale affronto durante la recita del figlio? Poi da lei, che si atteggia a progressista. Davvero una caduta di stile inconcepibile”.
“Io…”, come sempre, da mesi, Eugenio cercava le parole tra i rimbalzi di suono che gli saltellavano nella testa. “Io non credo che la parola pescivendola possa essere considerata un’offesa o ‘un oltraggio a qualcuno’, anzi, era una… una –
spiega∞*¶¡{§¿
– nasceva da una volontà di spiegare… no… spiegare no… Voleva essere la –
dimostra∞*¶¡{§¿
– volevo dimostrare come sia possibile, ancora, parlare di un insegnamento per tutti, perché la verità”, la testa gli sembrava un gelato fritto al contrario, con la cute ghiacciata e la pastella sfrigolante che gli foderava le pareti interne della scatola cranica, “…era un tentativo di ricordare–”, Picchi intanto lo fissava cercando di mostrare il giusto sguardo di chi non voglia credere a quello che sente, “…ricordare quanto sia importante condividere i progressi della scienza– il resto è stato un tentativo di straniamento, un impulso teatrale che ho…”, mentre parlava, schivando le battute e la musica senza darlo a vedere, si rendeva conto di non poter chiamare in causa i bambini, commentare il gesto estemporaneo di Walter, le tre volte che aveva indicato la signora Moroni; e la fatica raddoppiava. “Ho voluto insegnare ai bambini cosa voglia dire recitare e al tempo stesso dimenticare l’ –
immedesima∞*¶¡{§¿
– evitare di immedesimarsi… Come può anche solo pensare che– che puntare il dito sulla mamma di Stefano volesse essere offensivo? Io– io sinceramente sono allibito, dottor Picchi. Faceva parte della –
drammatizza∞*¶¡{§¿
– della recita… Come può la signora Moroni vergognarsi del lavoro che fa, se è un lavoro onesto?”, la musica cominciò a battergli in testa come se ne volesse uscire; lo costrinse ad alzare la voce. “mi chiedo a che punto avete– mi chiedo cosa sia diventata, questa maledetta –
na∞*¶¡{§¿
– questo stramaledetto paese, per costringere le persone a vergognarsi della miseria o del tipo di mestiere che fanno, maledi∞*¶¡{§¿… Se davvero è stato frainteso, il gesto di indicare qualcuno che è nel testo di Brecht perché ha il diritto sacrosanto di esserci… perché ha il diritto di sapere come stanno le cose, cazzo. ha capito o non ha capito”, Eugenio imitò la voce del direttore, la musica in testa era un trapano lanciato da dentro contro gli occhiali, “dottor Picchi, che si stava parlando della necessità di una istru∞*¶¡{§¿ pubblica, eh?… Che è di questo, che si stava parlando… Del potere; del filtro che viene usato per trasmettere la conoscenza, delle persone come lei che si adeguano… Quando parlo della ridistribu∞*¶¡{§¿ delle ricchezze a scuola io intendo la musica di Kurt Weill e la teoria dei numeri di Dedekind!”
Picchi diventò rosso come i gamberoni che aveva mangiato a pranzo.
Dopo l’ultima -d di Dedekind, però, Eugenio si rese conto che il suo discorso – emotivo, oratorio, raffazzonato, umorale: gli aggettivi gli si elencavano in testa come su un registro di classe – non era compiuto.
La musica che lo limitava, l’ossessione
che non gli permetteva di usare – soprattutto: di riconoscere mentre parlava – le parole esatte che gli servivano, avevano deviato l’ultimo atto della sua presenza a scuola verso le sponde incerte della normalizza∞*¶¡{§¿, della banalizza∞*¶¡{§¿.
Avrebbe dovuto essere più chiaro, spiegare che non solo di disagio per il lavoro in genere, si trattava; non era la vergogna immotivata per il proprio mestiere di pescivendola, la molla che aveva fatto scattare (e urlare) la signora Moroni. Era la vergogna per il proprio reddito. La mamma di Stefano non si sentiva a disagio per essere stata chiamata in causa in quanto “venditrice di pesce”, ma perché imprenditrice “di poco conto”.
Trent’anni di propaganda più o meno esplicita – dall’inizio degli anni Ottanta fino a quell’autunno del 2014 – avevano costretto la maggioranza dei cittadini italiani a un costante raffronto con la propria dichiarazione dei redditi. L’avanzare criminale delle tre fasi di inflazione “al rialzo programmato”, oltre ad allargare esponenzialmente la forbice tra gli inscusabilmente ricchi e i drammaticamente poveri, aveva tagliato di netto qualsiasi possibilità filosofica di non vedere le ristrettezze economiche come una colpa. Anzi, l’equazione eccessiva miseria = indizio di disonestà era stata (se non de iure, sicuramente de facto) ratificata già nel dpf del 2009; addirittura dividendo le aliquote erariali in tre fasce: “di poco conto”, “mediamente tassabili” e “benefattori fiscali”. Lasciando fuori dai calcoli i “miserevoli” e i “fuoriquota”. E riservando ai primi la gogna sociale dell’elemosina privata; ai secondi, la soglia di contribuzione bloccata al 21 per cento “per non legittimare l’odio di classe” e “la persecuzione tributaria”. Il susseguirsi dei quattro governi successivi aveva rimesso in gioco il complesso teorico della riforma, mantenendola però inalterata nella prassi (divisione in fasce compresa).
Questo era il motivo principale – almeno: uno dei due o tre motivi fondamentali – per cui Eugenio aveva chiesto a Walter quel colpo di teatro poi ripetuto. Per questo, anche, a un passo dal licenziamento – perché già prima che Picchi gliene parlasse, Eugenio si era reso conto che, tra la malattia e le prime avvisaglie di inutilizzabilità dei propri compiti lavorativi, la sua esistenza alla Bettino Craxi era segnata – Eugenio aveva pensato di allestire la recita con i bambini. Perché almeno restasse il ricordo di un gesto, tanto da poter ristabilire (anche se nella piccola comunità di una scuola elementare di Ariccia, in provincia di Roma), almeno per un giorno, per un paio di monologhi o tre, quello che Eugenio considerava il giusto peso da riservare alle cose.
Avrei dovuto parlarne, del morire lento delle cose; e dell’abitudine che questo comporta, se non ci si fa attenzione. Dovevo… non dico giustificare, ovviamente, ma vagliare, alla luce di ciò che ha detto, il comportamento della signora Moroni. Avrei dovuto essere più preciso, uscire dalla palude del populismo fine a sé stesso e stendere questo coglione di Picchi al vento della mia logica, un passo alla volta, fino a vederlo sfinito. Ma come si fa a usare le parole giuste, quando una stracazzo di musica sconosciuta ci impedisce anche di pensare, condiziona le nostre frasi, le smozzica in tanti tronconi che rischiano di essere fraintesi; quando non si ha la possibilità di risentirci, e tutto diventa al tempo stesso immediato e inconcludente, ci asciuga le idee in stagni pieni di suoni e di inizi che si ripetono fino a perdere significato, per quanto belli siano; diventano un rumore di fondo che ci accompagna, non si distingue più la voce di dio dal rumore di ferraglia.
Questo, avrei dovuto dire,
pensava Eugenio. E intanto Picchi – con il sudore che gli colava dalla fronte, la pelle del viso tiratissima e rossa come se il sangue si fosse concentrato tutto nella sfoglia sottile tra la fronte e le guance – aveva cominciato a scrivere su un foglio di carta intestata.
“Ora glielo dico, a questo stronzo qua”, pensava Eugenio, “che cos’è l’ipofasia di Dipentelz. Chi era Dipentelz… Glielo dico e poi me ne vado via, senza neanche salutare”.
Laol Sanzen Dipentelz era nato ad Aschaffenburg
sul Meno, in Germania, alla fine dell’Ottocento. “Precisamente nel 1884. L’8 febbraio”. L’aveva detto il neurologo a Eugenio e a Vittoria appena due giorni dopo l’inizio della malattia. Cresciuto negli stessi boschi che avevano visto nascere i fratelli Grimm, aveva da subito dato prova (“a soli dodici anni”) di essere straordinariamente portato per l’analisi matematica e per le “scienze esatte in generale”. Tanto da trovare quella che sarebbe stata definita la Costante di Dipentelz (la prima delle due definizioni specialistiche legate al suo nome); ovvero “una funzione numerica costante che, nella numerazione a base [8], se moltiplicata per un qualsiasi numero naturale maggiore di 2 cui sia stata aggiunta la figura modulare del 7, permette di stabilire l’esponente esatto da attribuire a quello stesso numero di partenza per poter calcolare il numero dei numeri divisibili per lo stesso”.
Eugenio e Vittoria si erano guardati sbalorditi, leggendo l’opuscolo informativo che gli aveva regalato il dottor Sartiani, il neurologo.
Alla fine della prima guerra mondiale, dopo dieci anni di studi a Parigi che l’avevano reso famoso in ambito scientifico e apolide in ambito sociale, “tanto da essere considerato uno dei primi obiettori di coscienza conclamati della storia: anche Russell aveva il massimo rispetto per lui”, Dipentelz aveva deciso di trasferirsi a Boston e lì, sulla costa orientale degli Stati Uniti, perfezionare alcune applicazioni pratiche delle sue ricerche – “si deve a lui anche uno dei primi e più innovativi abbozzi di ‘programmi informatici’ fatti tra il 1918 e il 1921. Dipentelz aveva capito che introducendo una variabile finta che permettesse il ritorno reiterato all’inizio del programma, la macchina calcolatrice avrebbe potuto continuare a elaborare gli stessi dati in eterno”. Eugenio aveva disegnato un punto interrogativo a forma di pupilla marrone. “Diceva che se solo si fosse riusciti a mettere tutti i dati del mondo in una macchina calcolatrice – le chiamava così, lui – si sarebbe potuto inserire la variabile fittizia ‘di ripristino’ nella prima e nell’ultima riga del programma: così il mondo non avrebbe avuto mai fine, l’eterno ritorno sarebbe stato giustificato in modo analitico e la scienza avrebbe permesso alla filosofia di – lui lo diceva in tedesco – non pisciare fuori dal buco dell’orinatoio, prestando solo le intuizioni”.
Una mattina di ottobre del 1922, però, seduto a fare colazione nella cucina della sua casa di Boston, mentre alla radio annunciavano il nome del nuovo capo del governo italiano, si era appalesata per la prima volta la malattia che avrebbe preso il suo nome.
“Dopo la riunione fatta lo scorso lunedì 16 ottobre nella città di Milano, in Italia, un non foltissimo gruppo degli appartenenti al movimento fascista ha marciato su Roma senza che né il re né il Parlamento prendessero provvedimenti. Anzi: il re, Vittorio Emanuele iii, ha affidato l’incarico di capo del governo al leader fascista…”
E qui, Laol Dipentelz sentì uscire dalla radio – una grossa Marelli giallonera che aveva portato con sé dall’Europa – un poderoso rutto. Un’emissione sorprendente: tanto che Dipentelz “avvertì una curiosa sensazione di pesantezza allo stomaco”; evidentemente per il disagio trasposto: per la compartecipazione emotiva alla figuraccia dello speaker di turno – un imprevisto aerofago che, molto probabilmente, gli sarebbe costato la carriera alla rko. Ma Dipentelz non aveva ancora finito di dispiacersi per la sorte segnata del radiocronista (“un destino brillante sporcato da un hamburger alle cipolle maldigerito”) – radiocronista che, professionalmente (Dipentelz si era trovato ad ammirarlo, quest’uomo impassibile davanti alla sciagura gastrica), continuava a leggere le news sull’Italia senza imbarazzo – non aveva ancora finito di commiserare un animo tanto nobile e rigoroso, che il fenomeno si ripresentò, identico a prima, mortificando d’un tratto l’orgoglio momentaneo regalato dallo scienziato allo speaker. “Il re ha inoltre affidato al nuovo capo del governo–”
Lo stesso rutto, pensò la mente catalogatrice di Dipentelz. Lo stesso, identico rutto. (Addirittura, Dipentelz ne ebbe una visione nebulosa. Nelle sue memorie la descrisse: “la rappresentazione schematica di un’onda sonora come potrebbe raffigurarla un bambino: )))))))… Un’onda sonora che ‘prende fiato’ in sordina e poi si propaga, da un punto in poi dell’emissione, con un’intensità costante e duratura”). Scosso dal fenomeno, sempre chiedendosi come fosse possibile che il radiocronista non accennasse neppure a una scusa di qualche tipo, né sembrasse minimamente sconvolto dall’effetto causato in lui dall’ultimo pasto della giornata.
Inoltre, raccontò Dipentelz a un intervistatore nel 1948, poco prima di morire: “mi ero reso conto che c’era qualcosa di… di anomalo nell’episodio della rko. Quella stessa mattina, una volta arrivato nel mio studio, al mit, chiesi al mio compagno di stanza, il professor Loewensthal – un fuoriuscito, come me, con cui studiavo le applicazioni della mia costante sul calcolo logaritmico a base otto… gli chiesi se aveva sentito il radiogiornale delle undici alla rko… Lui mi disse, mi rispose di sì, anzi – preoccupato per la nomina, in Italia – disse quello che per lui era il nome del nuovo capo del governo e io sentii di nuovo lo stesso rutto… lo stesso rutto dello speaker… Fu allora che capii che qualcosa non andava in me… Che non erano loro a ruttare, né lo speaker né Loewensthal – anche se all’inizio fu devastante sentir ruttare un uomo compìto come Abraham Loewensthal: un ricordo memorabile, tuttora…”
Così, da autodidatta della neurologia e della psicanalisi, Laol Dipentelz trascorse i successivi anni della propria vita a studiarsi. Partendo da una suggestione casuale della Psicopatologia della vita quotidiana di Freud di cui era già a conoscenza, il caso del paziente che aveva invitato i colleghi a ruttare (aufzustossen) anziché a bere (anzustossen) alla salute del proprio capoufficio, e risalendo così, di induzione in induzione, lungo le catene dei lapsus fino alla patologia cerebrale, Dipentelz riuscì a isolare e a catalogare la propria malattia, venendo a poco a poco in contatto con tutte le persone che ne erano affette, senza saperlo, e che si credevano invece semplicemente pazze (fino ai tre quarti del xx secolo la dicitura più adoperata per glossare qualsiasi affezione psichiatrica).
Laol Sanzen Dipentelz riuscì a stabilire che la propria malattia non era di natura funzionale, ma andava invece a colpire una minuscola parte del lobo temporale sinistro. Si trattava di una malformazione neurologica congenita, spesso generata da un’anomalia di tipo diverso dei genitori del malato; ma non era trasmettibile ai figli. L’ipofasia di Dipentelz era un fulmine isolato nelle catene genealogiche. Uno e solo uno poteva soffrirne, in un qualsiasi ceppo familiare, nel corso di almeno dieci o undici secoli: dopo questo smisurato salto all’indietro nel tempo i dati non erano più quantificabili scientificamente.
“E pensi”, aveva spiegato Dipentelz all’intervistatore, “che tuttora io non so, malgrado i rutti di cui s’è circondata la mia vita nei ventisei anni successivi a quel mattino di gennaio, quale sia il vero nome del dittatore italiano. Per me – sia a voce che per iscritto – resta e resterà sempre soltanto un rutto nella mia storia personale e nella vita dell’umanità”.
Il dottor Sartiani, il neurologo che aveva accettato di ricevere con urgenza Vittoria e suo marito, una volta venuto a conoscenza dei sintomi di Eugenio, era uno dei massimi esperti di disturbi “dell’interpretazione e della comprensione”. Dopo una visita di dieci minuti a Eugenio, un colloquio pieno di “la sua fissa∞*¶¡{§¿”, “dovrà abituarsi a trovare una nuova considera∞*¶¡{§¿ di sé”, il dottor Sartiani aveva diagnosticato con precisione rassegnata il tipo di malattia, l’ipofasia di Dipentelz, appunto, riempiendo la borsa di Vittoria di opuscoli informativi, fascicoli di riviste specialistiche; e dedicando i successivi cinquanta minuti dell’incontro a una lunga chiacchierata su Laol Dipentelz e le particolarità curiose dei disturbi che generava.
“Sarò da subito chiaro con lei, signor– Calveri… La malattia non può essere curata, perché è la sua natura fisiologica a impedirlo. Per quel che ne sappiamo, il segmento di parola che la condiziona, ∞*¶¡{§¿, non è – almeno in base alle ricerche dello stesso Dipentelz e ai dati in nostro possesso – riconducibile a un qualche trauma pregresso… E qui sta la chiave della sua nuova vita, signor Calveri. Vede, nel mondo ci sono solamente– c’erano, solamente, fino a oggi… fino a lei, 3429 casi accertati della malattia. Lei è il numero 3430. Io stesso mi premurerò di avvisare immediatamente i miei colleghi per posta elettronica…”
Il nervosismo dell’incontro aveva portato a Vittoria un sorriso di compiacimento; come se quella classificazione in qualche modo alleviasse il peso della notizia certa. Se ne era però accorta immediatamente, tossendo. Eugenio era ammutolito, guardava lei e il dottore cercando di scoprire il trucco, l’indizio che l’avrebbe condotto di lì a poco alla fine di uno scherzo.
“Dunque… La– La musica che sente… La conosce, signor Calveri?”
“Be’… No. Non mi ricorda nulla in particolare”.
“E da quello che ho capito lei ne ha anche una visione… come vogliamo definirla? Grafica?”
“Sì sì… grafica. Mi sembra di– intravedere, oltre la musica, una… scrittura musicale, una battuta, delle note, dei numeri… una serie di indicazioni…”
“Bene… Insomma, abbiamo isolato il tipo… Dunque: l’ipofasia di Dipentelz è stata chiamata così – da Dipentelz stesso – perché in qualche modo limita la possibilità di parlare– di ‘dire’, no? Ma agisce in modo selettivo e – mi ascolti bene – casuale su alcune porzioni di linguaggio… Per banalizzare con un esempio che però, stia attento, non è preciso: è come fosse un tipo di dislessia ossessiva e mirata. Lei, in un certo senso, è fortunato, perché l’ipofasia investe una parte delle parole di cui lei era già pienamente cosciente, prima dell’insorgere dei primi sintomi… Quindi, non dico che non servirà una forza di volontà ferrea, però– lei può, imparando a gestire l’“attacco” della musica… trovare nuove strade, sostituire le parole che le… le suonano in testa, con altre parole. Sarà difficile, certo, ma non è impossibile. Consideri la malattia un… lei è credente?”
“No”.
“Va bene… La consideri comunque una prova, un modo (di cui magari non sentiva il bisogno, lo capisco) per– per confrontarsi con la vita…”
“…”
“…”
“Sì, lo so. Vi sembrerà assurdo, però è l’unico modo, mi creda. L’ipofasia comporta una regressione alla fase prelinguistica dell’apprendimento… Sa, quando si è bambini, si impara a poco a poco a ‘decodificare’ i… suoni che provengono dagli adulti, dall’esterno. Si tratta di un lavoro preparatorio durante il quale il bambino impara ad accumulare e poi– e poi a selezionare i suoni. Ecco: provi a pensare che alcuni… suoni, nel suo caso il segmento ∞*¶¡{§¿, siano stati, più o meno due giorni fa, quando le è capitato la prima volta, ‘decodificati’ dal cervello in un modo nuovo, regredendo per un attimo – una sorta di ictus della comunica∞*¶¡{§¿ e della comprensione, una pausa… Pensi che il suo cervello, quella minima parte del lobo sinistro che è intaccata dall’ipofasia di Dipentelz, è tornato, per un istante… indelebile… alla fase prelinguistica dell’apprendimento”.
Eugenio lo fissava, incapace di intervenire, ormai persuaso dell’inesistenza di una qualsiasi cura. Vittoria se n’era accorta e aveva cercato la sua mano, da una sedia all’altra. Aveva intrecciato le dita con quelle di lui senza che Eugenio se ne accorgesse; le era sembrato di manipolare della carne da cuocere. Un petto di pollo, una grossa polpetta di carne macinata.
“Così, rielaborando i suoni che per lei, fino a più o meno l’altroieri, avevano quel suono ed erano portatori di quei significati… li ha ricomposti, riscritti, così da deviare una comprensione inerziale verso una nuova interpreta∞*¶¡{§¿ dei messaggi… Mi segue?”
“Non… Non molto, dottore”.
“Ah, mi scusi… Le farò alcuni esempi. Dipentelz. Dipentelz non aveva mai sentito, in vita sua, il nome di Benito Mussolini. E però (lui pensava fosse successo proprio al momento della cola∞*¶¡{§¿) scusi… durante il… breakfast… il suo cervello ha subito una regressione autoindotta, è tornato – una minima connessione di neuroni in un tempo infinitamente piccolo – a un momento della sua vita in cui i suoni dovevano ancora essere codificati… La connessione di suoni manifestatasi in quel momento – questo, le ripeto, ha a che fare con Dipentelz, non con lei – è stata riscritta. Il cervello ha attinto a una serie di dati già presenti nella memoria di Dipentelz (il rutto) e ha sostituito, da lì in avanti, non solo la… comprensione di quella sequenza di suoni, ma anche la possibilità di identificare i suoni sostitutivi… Infatti Dipentelz non è mai riuscito a descrivere, se non approssimativamente, le particolarità di quel rutto”.
Vittoria aveva chiesto chiarimenti al posto di Eugenio, ormai nel pallone aerostatico della sua tristezza galleggiante.
“Scusi, dottore”, l’aveva interrotto. “Vuol dire che– che Dipentelz… ed Eugenio, hanno… cancellato parti del loro linguaggio, le hanno sostituite con altre parti?”
“Più o meno, signora Calveri… Ma non è esatto. L’ipofasia impedisce di dire, pensare, leggere – è la… componente visiva del disturbo che fa questo… la– alcune sequenze di suoni del linguaggio che siano in qualche modo portatrici di significato per il… il paziente affetto dalla malattia. Il cervello, vede, riscrive, non cancella. Trasforma senza distruggere, perché sa in partenza che sta operando in sistemi comunicativi già codificati… crediamo sia una forma di– di difesa inconsapevole. Insomma, è capitato che suoni comunicativi in una o più lingue siano stati trasformati in rutto, o in musica– mai viceversa. Per ora, comunque… Perché a voler essere precisi, rutto e musica (soprattutto: visto che è un linguaggio in sé), sono parte della comunicazione linguistica… Insomma: non è mai capitato che la riscrittura interessasse porzioni di linguaggio incomprensibili in una data lingua: nella lingua del malato, o in una lingua qualsiasi conosciuta dal malato”.
“Ma scusi, mio marito non sente più ∞*¶¡{§¿ , che da sé non significa nulla…”
“Mi permetto di contraddirla, signora Calveri… oltre all’omofonia affettiva – lei potrebbe chiamare ∞*¶¡{§¿ il fratello di sua madre cui è molto legata, no?”
Vittoria era stata costretta ad annuire; Eugenio era ormai lontano dallo studio del neurologo, in una terra di confine fatta di deserti e di rotolacampo in cui, ogni tanto, un qualche vento da nord, ghiacciato e insistente, si alternava con la musica che l’aveva invaso. Eugenio camminava da solo lungo un muretto di sassi, un margine desolato raggiunto dalle voci ovattate di sua moglie e del dottore.
“Oltre a questo, il segmento ∞*¶¡{§¿ determina il significato delle radici di parole cui s’accompagna, no?”
Vittoria aveva guardato Eugenio, Eugenio aveva sentito la musica arrivare da dietro una duna di sabbia.
“Calveri– Signor Calveri…”
“Eugenio–”
“…?”
“Non… non si preoccupi, signora, una… specie di distra∞*¶¡{§¿ ‘protettiva’ è causata dall’ipofasia. E anche lei, signor Calveri, imparerà a gestirla con il tempo. Anche se non le nego che dovrà– dovrà prima accettare del tutto il… cambiamento. Poi– scusi se sono brutale, ma è meglio cominciare subito la terapia di adattamento. Lavorare, anche solo parlare con gli altri, leggere un libro, specialmente all’inizio, per lei sarà una fatica difficilmente sostenibile. Come diceva Laol Dipentelz, ‘questa piccola por∞*¶¡{§¿ di mondo rischia di diventare il tuo solo mondo, se non capisci come reagire alla malattia’. E le ripeto che lei è fortunato, in un certo senso, tra i malati… A un paziente, in Norvegia, è capitato di sostituire il nome del proprio figlio con un grido di terrore; più o meno simile, ha detto, all’urlo di Doris Day in L’uomo che sapeva troppo…”
Vittoria aveva provato a stringere di nuovo le dita della mano di Eugenio. Lui l’aveva guardata negli occhi come se cercasse una frase consolatoria; una frase che lei non aveva saputo trovare, mentre il dottor Sartiani prendeva una scheda precompilata dal cassetto della scrivania.
“La forma che ha assunto in lei l’ipofasia, signor Calveri, dovrebbe essere del tipo cosiddetto ‘a podio’ o ‘a scala di Hølmem’… una forma – non dico leggera, ovvio – ma certo più lieve di altre patologie. Se non ho capito male, la sua… musica… annebbia la capacità di comprensione anche delle parti del discorso… intorno, no?”
“Sì, più o meno… mi risulta difficile… capirle… o ricordarle, se comunque riesco a– a sentirle…”
“Una risonanza? Potrebbe definirla una specie di risonanza?”
“È come se la musica– tracimasse da… fuori, da una parte all’altra della– della battuta…”
“Sì sì, non si preoccupi di precisare, ho perfettamente chiara la situa∞*¶¡{§¿…”
Il dottore aveva mostrato a Eugenio e a Vittoria la prima pagina della sua scheda. Dopo tre disegni abbastanza simili, una serie di curve ondulate di diversa grandezza, ce n’era un quarto, l’ultimo,
“Vede? Questo è quello che corrisponde di più alla descmm– al suo caso… a quello che le accade: le linee di entrata e di uscita, il picco, il rettangolo di contenimento del fenomeno, della musica… Poi il ritorno, diffuso… la doppia linea… va bene, però queste sono cose tecniche, giusto per spiegarle…”
Vittoria avrebbe voluto invecchiare di dieci anni tutto insieme, vedersi allungare e imbiancare i capelli davanti al neurologo, sentire la pelle avvizzirsi e le rughe allargarsi e crepare sul viso come su di un parabrezza a forma di faccia; sarebbe stata in grado di sopportare tutto questo, all’improvviso, uno scatto in avanti della sua vita di dieci anni – anche a costo di ritrovarsi morta, decomposta, già in avanzato stato di calcificazione: perché chi può davvero sapere cosa ci riservi il futuro, di qui a dieci anni? Chi comincia a fare patti aleatori con il tempo, il campionario di rivisitazioni dei ma e dei se, non può davvero conoscere il numero dei giorni che riempiono il suo portafoglio; chi lo fa, gioca con il niente di cui è composto il tempo quando lo si pensa; eppure, si diceva Vittoria, “potrei barattare gli anni a disposizione, i mesi, i giorni, tutto il tempo, sì: tutto il tempo. Se anche non fossi in grado di saldare il conto dei dieci anni perché me ne restano molti di meno, mettere sul banco tutto il tempo che resta sarebbe comunque una giocata accettabile, dal Tempo, e lo farei”, si diceva Vittoria, “se solo riuscissi, poi, a togliere dagli occhi di Eugenio quell’impressione di estraneità; di chi si senta perduto e si costringa a guardarsi dall’esterno per proteggersi, evitare il ridicolo della disperazione. Sì: tutto, ma non quell’espressione svuotata sotto gli occhi, quella certezza di avere perduto la propria vita e di essere rimasti a guardarla da lontano, perché non c’è rimedio”. Aveva stretto la gabbia di dita di Eugenio con forza: lui aveva preso l’indice di lei con l’indice dell’altra mano, l’aveva alzato a tagliola e poi l’aveva fatto scattare. Per prendere in trappola il tempo che gli si affacciava davanti, forse. O solo perché il polpastrello di Vittoria schioccasse sulla pelle del dorso come un grosso peso di piombo lasciato cadere in acqua; la lenza pronta per gli anni a venire.
“Ora mi scusi, signor Calveri, ma è meglio preparare la sua cartella clinica”. Sartiani aveva inforcato gli occhiali, percorso dall’alto in basso la sfilza di domande già pronte. “Vediamo, ah sì… mi spieghi meglio. ‘Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia; o di infermità mentale?’…”
Quando Eugenio era bambino, suo padre
Tommaso, prima ancora che la depressione e la disfunzione cerebrale lo portassero al suicidio, aveva regalato a chi gli era vicino un disegno variegato di comportamenti bizzarri.
Cresciuto con una madre molto vecchia – era stato l’unico figlio nato vivo dopo una teoria avvilente di quattro aborti spontanei e di due fratelli maggiori morti subito dopo il parto – Tommaso Calveri aveva passato l’infanzia e l’adolescenza in Val d’Orcia con la signora Fedra, l’improbabile nome (eppure molto diffuso, nel contado di Forgiano Orcese) della nonna di Eugenio. Cinquantasettenne al principio della seconda guerra mondiale, con un marito più vecchio di lei di undici anni (Evaristo Calveri, contadino in una delle fattorie del marchese Aretani), la signora Fedra, all’inizio, aveva vissuto l’ennesima gravidanza come un impaccio momentaneo del quale – data la sua storia clinica precedente e l’età – si sarebbe liberata al più presto. Era diventata invece “un grave problema” poi, quando l’ostinazione prenatale di Tommaso l’aveva costretta a scarrozzare per nove mesi il pancione di rito, dal marzo al dicembre del 1941, continuando a lavorare forsennatamente nei campi senza che questo distogliesse di un’acca l’attaccamento alla vita (e alle sue viscere) del futuro padre di Eugenio.
A diciassette anni, nel 1958, Tommaso aveva abbandonato per sempre la fattoria dove i suoi genitori lavoravano ancora, avviticchiati alla campagna come tralci secchi in un racconto di Tozzi, per andare a vivere a Roma.
Insieme con i mestieri di fortuna che si era procurato – apprendista idraulico, stagnaro, cassiere in una tabaccheria ai Parioli, ascensorista all’Hotel Nazionale – Tommaso aveva cominciato a frequentare il mondo del teatro di rivista dello Jovinelli, le fiere di paese nei borghi vicino Roma, i primi esperimenti off che si concentravano tanto nelle cantine jazz intorno a piazza Barberini quanto nei localini periferici della capitale. Aveva imboccato da solo, in sostanza, una strada che si era illuminata a poco a poco mentre la percorreva. Diventando nell’ordine – lui, con il solo “secondo avviamento professionale” nella testa – lettore appassionato dei classici della letteratura e del teatro, cinefilo prima timido poi sempre più consapevole, fiero estimatore della pittura contemporanea, comunista. Era nelle sezioni del pci (senza essere iscritto), nelle bibliotechine di quartiere, nei pidocchietti di Monteverde Nuovo o della Magliana, che nelle pause dal lavoro alimentava la sua inesausta bramosia di conoscenza. Tanto da diventare lui stesso, in poco tempo, artista e promotore d’arte.
Nel 1965, a ventiquattro anni, quando ormai era stato assunto a tempo pieno come commesso alla upim di piazzale Dunant, Tommaso riuscì a fondare anche la piccola compagnia filodrammatica Vladimir Vladimirovi∑ Majakovskij, “prove tutti i giovedì e le domeniche dalle sette alle nove”, nei locali del teatro della chiesa di Nostra Signora della Salette. E lì, nel 1968, quando il resto del mondo vibrava della stessa furia solare degli attori della Majakovskij, aveva conosciuto Delia Germani, sua futura moglie e madre di Eugenio.
In chiunque, tra gli attori e le attrici della compagnia, in quel periodo di storia dispiegata sul pianeta come un telo protettivo su una serra di girasoli, Tommaso proiettava una luce inquieta: la passione dell’artista autodidatta, la giovinezza faticosa e senza affetto; tutta un’intelaiatura reticolare che ne sorreggeva il fascino come fosse una pietra preziosa e incatalogabile stretta tra le maglie fredde dell’oro bianco della sua giovinezza tormentata. E in quella rete era caduto il pesce Delia, stregata dalla parlantina miracolosa di Tommaso e dalle sue profferte di matrimonio.
In uno stanzino dietro l’oratorio, un pomeriggio piovoso di novembre, era stato chiamato al mondo Eugenio, la terza volta che Tommaso e Delia avevano fatto l’amore, con un sì joyciano che aveva schiacciato la guancia di lei contro la grata di una cassetta porta-attrezzi.
Dopo un matrimonio felice e riparatore, nel gennaio del ’69, i due sposi non avevano dovuto fare altro che trovare una casa di due stanze in affitto a via Ozanam, aspettare l’estate seguente, comunicare ai genitori di Tommaso e alla mamma di Delia – la vedova dell’appuntato dei carabinieri Augusto Germani – la nascita gradita del loro primo nipote.
Trascorsero così sei anni pieni di lavoro e di passeggiate domenicali a villa Sciarra, una puntata veloce a Forgiano Orcese per le esequie di nonno Evaristo, il lavoro alla upim di Tommaso, le prove – e le tournée primaverili, in giro per i paesi dei Castelli Romani – della Majakovskij. E furono anni intensi, per Tommaso, pieni di letture e di nuovi convincimenti culturali. Il buddhismo, la lettura corale del Siddharta di Herman Hesse (lui e Delia seduti davanti al letto di Eugenio, la sera), lo zen.
Nuove scoperte che però non sostituivano, anzi: secondo Tommaso completavano tutti i mondi che la vita precedente gli aveva solo “lasciato intuire”.
Tra il 1969 e il 1975, l’anno d’esordio di Eugenio al teatro di Madonna della Salette, correnti irrazionalistiche avevano “sì scrollato, ma non divelto” la visione del mondo di Tommaso e di Delia Calveri. Anzi: rivestite dalle spinte inimbrigliabili dei nuovi fermenti, le vecchie convinzioni si erano rinsaldate, rinvigorendosi di suggestioni inattese e di sconfinati orizzonti filosofici carichi di promesse. Eugenio era vissuto, sin da piccolissimo, tra mostre nei musei e cinemini d’essai, lunghi pomeriggi di prove di allestimenti d’avanguardia – durante i quali la madre e il padre attiravano la sua attenzione con rumori sconcertanti e bellissimi, distraendolo per lunghi momenti misteriosi dalle sue attività di tre-quattrenne seduto nel passeggino.
Il bambino, insomma, era stato investito di una sorta di predestinazione inerziale: per Tommaso e Delia era l’ombra concreta del mondo interiore che, rigo per rigo, si andavano coltivando a vicenda.
Tanto che, impressionato da una blanda maestria infantile per il disegno a pastello e per quella che considerava “una disposizione prodigiosa per l’imitazione”, Tommaso si era convinto delle doti semidivine del figlio; fino a immaginarlo uscire dalla culla della sua gioiosa, incosciente ignoranza del mondo, con in mano le serpi velenose di quel passato che si andava sgretolando dietro ai suoi genitori.
Eugenio non avrebbe dovuto aspettare molto, pensava Tommaso, per gridare al suo tempo il proprio genio inarrivabile, saltando a piedi uniti – piedi minuscoli, ancora – tutta la fatica che aveva dovuto sopportare suo padre; tutta la sfortuna che gli aveva limitato il tempo, costringendogli l’arte in rappresentazioni dilettantesche senza futuro.
Una mattina, qualche settimana prima del debutto dello Zio Vanja che stavano allestendo con la Majakovskij, Tommaso aveva rivelato a Eugenio la grande scoperta cui l’avevano condotto i suoi studi attenti e particolareggiati. Suo figlio era la reincarnazione di Bertolt Brecht.
Tommaso Calveri – con la quieta complicità di sua moglie – aveva sviluppato una personalissima teoria sulla reincarnazione.
“Vedi, Eugenio… La trasmigrazione di un’anima da un corpo all’altro – io ci ho pensato a lungo – non avviene nella banalità del passaggio da un ultimo respiro a un vagito”. Il ricordo che Eugenio aveva della spiegazione paterna si fondava sulla ripetizione assidua che ne era stata fatta negli anni, più che nella memoria oggettiva di quel lontano pomeriggio in cui – di questo si ricordava bene – era molto più distratto dal filamento verde di lattuga che suo padre Tommaso aveva tra gli incisivi, mentre gli parlava.
“No… Io credo, ne sono convinto… che lo spirito vitale di un uomo che sta morendo, tutti i suoi sogni e le sue paure, la vita che è stato, si concentrino nell’estremo dei suoi respiri ma poi– poi, questo grumo di vita che parte… ha bisogno di tempo… Ha bisogno necessariamente di un tempo caldo di sospensione… Forse è da qui, tra l’altro, che ci vengono idee collettive dell’esistenza di una qualche zona purgatoriale, dopo la morte… E allora cos’è che ho pensato, eh?” Il tono di voce di Tommaso, cadenzato in modo bambinesco e però foriero di tante verità incomprensibili, trascinava Eugenio in un vortice di gente che soffia sul vetro delle finestre l’inverno.
“Ho pensato che per– ricostruire il giusto nesso tra le reincarnazioni di una persona… bisogna affidarsi prima di tutto a un certo istinto. Una specie di impulso naturale irrefrenabile che ci conduca verso qualcosa di definito… E così io mi sono reso conto di essere irresistibilmente attratto dalla contemplazione di te che guardi, capisci? Quel tuo sguardo curioso sulle cose: come se ti aspettassi sempre che, da sole, si– si mettano a parlare per spiegarti il loro segreto più nascosto… E anche il rigore con cui muovi gli oggetti, lo scoppio delle risate dopo un lungo periodo di serietà… La cura meticolosa che riservi alle parole che dici… e anche… anche la capacità che hai di mettere in relazione parole apparentemente lontane tra loro, spalancando all’improvviso feritoie di senso che prima non esistevano… Mi ricordava qualcosa, tutto questo, sai? Qualcosa che, fino a un po’ di tempo fa, non riuscivo a definire con precisione, come… come se cercassi il sinonimo di una parola sconosciuta di cui però afferravo il significato”. La madre, Delia, li aveva raggiunti in salotto: Tommaso sul divano e Eugenio sul tappeto, che faceva andare avanti e indietro un escavatore giocattolo arancione. Si era appoggiata di schiena allo stipite della porta, le mani impegnate in una lotta centripeta con uno straccio.
“…Vedi, Eugenio… pensando a lungo alla questione della sospensione cui un’anima sicuramente si adegua, dopo la morte di un corpo… riflettendo sul ricovero tiepido di cui ha bisogno, mi sono detto, anche parlando con la mamma, che probabilmente non c’è riparo più appropriato del grembo di una donna, no?… No?” Si era voltato verso Delia, che aveva sorriso di sì.
“Ecco… Quello che penso è che… per capire quali siano le nostre reincarnazioni precedenti non ci si deve basare, per esempio, sulla coincidenza tra una data di morte e una di nascita. Sarebbe come voler dire che il tempo e l’ordine universale si fondano su una fretta meccanica che non mi persuade… No, Eugenio, io credo che un’anima fugga da un corpo morente per cercare di ripararsi in un grembo… E anche questo non basta. Deve trattarsi del grembo di una donna in un momento particolare della sua vita, l’attimo in cui passa da una vita all’altra, l’istante finale della sua prima ovulazione…”
Eugenio aveva scaricato un groviglio di soldatini capovolgendo il cucchiaio dell’escavatore.
“…Cosa che spiegherebbe anche il perché di altri fondamenti dell’inconscio sociale come la primogenitura, e al tempo stesso risponde alla domanda cruciale dei detrattori della metempsicosi; il quesito per cui finora non c’era mai stata risposta senza ricorrere agli insetti, alle piante, agli animali… Solo il primo figlio di una donna raccoglie il retaggio di un’anima antica. Gli altri, tutti gli altri sono anime nuove, appena generate dalla manipolazione armonica dell’energia universale. Per questo diecimila anni fa eravamo poche migliaia di persone, in questo pianeta, e ora siamo miliardi… Tu sei un bambino intelligente, riesci a capirmi se ti dico queste cose…”
Eugenio aveva lanciato un soldatino sul tavolo della sala, inscenando un arrembaggio alla fruttiera. Tommaso aveva ammiccato a Delia, orgoglioso.
“Anche tutte queste rappresentazioni sceniche che fai, con i soldatini, testimoniano della – non ti spaventare, Eugenio – della tua vita passata… Perché, come ti dicevo, proprio mentre capivamo bene, la mamma e io, come funziona la trasmigrazione di un’anima da un corpo all’altro… come si insedi, prima, in un grembo femminile al momento del menarca… io mi sono ricordato dove avevo già visto quel tuo sguardo, quella tua espressione…” Tommaso si era alzato, era andato verso la credenza, aveva aperto un cassetto. Aveva tirato fuori un libro, segnato a una pagina specifica con un pezzo di carta. Era tornato a sedersi sul divano e aveva mostrato a suo figlio una foto di Bertolt Brecht. “Eccoti qua, Eugenio. Lo vedi? Lo stesso modo di fissare intento, la stessa linea del naso – certo, in te è una linea ancora solo accennata, ma prova a pensarti a trent’anni, l’età che aveva lui… l’età che avevi tu in questa foto…”
Eugenio aveva guardato fisso la fotografia in bianco e nero. L’uomo dai capelli rasati sembrava prenderlo in giro. Un’ombra sotto il mento, una piega screpolata delle labbra: non riusciva proprio a riconoscere sé stesso – come suo padre gli stava chiedendo di fare – in quell’uomo vecchio che non si degnava nemmeno di ricambiare le sue occhiate sospettose.
“E poi pensa: dopo che mi è tornata in mente questa foto, sono andato a rivedere la data della morte di Brecht nell’enciclopedia. È morto il 14 agosto del 1956. Lo stesso giorno in cui tua madre ha avuto le sue prime mestruazioni, a dodici anni… è vero o no?…” Delia aveva confermato dalla porta con un altro cenno della testa.
“Tu, Eugenio, sei la reincarnazione di Bertolt Brecht… e guardacaso, ti chiami Eugenio… Eugen… Il suo secondo nome… E questo né io né tua madre lo sapevamo, prima di informarci per bene…”
Da quel giorno di rivelazioni, era cominciata la carriera teatrale di Eugenio e la sua “crescita culturale costante”. Mentre il padre sfruttava ogni istante di libertà dagli obblighi lavorativi per scrivere un saggio che non vide mai la conclusione, Menarchia, Eugenio era costretto a un tour de force formativo. Lezioni di tecniche di pittura impartite da un attore della compagnia Majakovskij, con tanto di esercizi all’aria aperta e peregrinare festivo per i musei con blocco da disegno e carboncino. Lezioni di pianoforte dalla signora Dominici, vicina di casa diplomata al Conservatorio. Lettura intensiva dei classici sotto il diretto controllo di Tommaso, che presiedeva anche alla corretta preparazione artistica negli altri campi.
Va detto che Eugenio si divertiva moltissimo, soprattutto nell’imparare a memoria le sue parti teatrali (Tommaso e Delia leggevano per lui, a voce alta, le battute che avrebbe dovuto recitare, poi lo facevano ripetere una, due, tre volte); trovava estremamente gradevole passare così tanto tempo con il padre e gli altri attori della compagnia. Senza contare che Tommaso riusciva a inventarsi allestimenti che lo prevedevano in scena dall’inizio alla fine. Mescolanze sperimentali di Jarry e dell’Opera Buffa settecentesca; cronache del Corriere della Sera frammiste a passi dei Carmina Burana – con tanto di accompagnamento intrecciato di Orff e di Rita Pavone. La rivisitazione di Nostra Signora dei Turchi che ottenne un discreto successo, a Roma e dintorni, e che indignò Carmelo Bene. “Una crudeltà inammissibile”, aveva detto a un amico di Tommaso che gliel’aveva immediatamente riferito. “Mettere a confronto un bambino così piccolo con me, che sono un classico… Non è per l’età, ovviamente: è il paragone cui lo costringono”.
Questo, per circa tre anni. Finché cominciarono le prime avvisaglie della depressione di Tommaso e il crescente fastidio pedagogico di Delia. Se infatti all’inizio si era mostrata d’accordo, con il marito, che tutto era “per il bene di Eugenio” e che “anche i De Filippo erano praticamente nati in teatro”, con il tempo la foga registica di Tommaso le aveva fatto cambiare idea. Un breve periodo di dubbi sulle reali intenzioni di lui a proposito della carriera del figlio e sulla sorte stessa del proprio matrimonio.
Dubbi che si trasformarono presto in certezze disperanti, quando Tommaso cancellò d’un tratto le attività divertite di Eugenio, poggiando un velo nero sulla vita matrimoniale dei coniugi Calveri. Un lancio della spugna lungo sei anni; sei anni di “sopportazione di Tommaso” dettata dall’antico affetto – visto che Delia non avrebbe potuto lasciare suo marito da solo.
Una sera di febbraio del 1978, dopo avere annullato
la prima dell’Amleto al Teatro Amatoriale Tartaglia di Palestrina (Eugenio avrebbe dovuto interpretare le parti di Amleto e di Ofelia, recitando di profilo e truccandosi diversamente le metà destra e sinistra del corpo); dopo avere definitivamente sciolto la compagnia Majakovskij, comunicandolo per lettera a tutti gli attori della filodrammatica, Tommaso annunciò di avere ricevuto “un’altra telefonata dall’evangelista Giovanni”.
Una lunga telefonata, spiegò a Delia e a Eugenio, in cui gli si rivelava l’imminenza ineludibile della fine del mondo. “Un rettangolo nero cadrà sul pianeta”, gli aveva detto l’evangelista, “e allora guardatevi dagli oggetti che parlano: perché è da essi che scaturirà la fiamma scura della dannazione”.
Da quella prima avvisaglia esplicita del male che l’avrebbe portato alla tomba – e alla lapide disegnata da Eugenio – i suoi colloqui via cavo con l’evangelista presero a intensificarsi. “È ovvio che voglia parlarmi. Ho sempre avuto la massima stima, per lui: il Vangelo, l’Apocalisse… E poi quella chiusa meravigliosa… «ora dichiaro a chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro: se uno vi fa delle aggiunte, Dio gli farà subire le piaghe descritte in questo libro; e se uno toglie qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio sottrarrà la sua sorte dall’albero della vita e dalla Città santa descritti in questo libro…» Eugenio… è l’atto fondativo del diritto d’Autore!”
Insieme con la deriva mistica dei suoi colloqui telefonici con l’apostolo, erano iniziati gli insulti e le recriminazioni al figlio. Inoltre, sulla base delle rivelazioni quotidiane di cui diceva di essere gravato da Giovanni, aveva cominciato a nutrire diffidenza per la tecnologia in genere. Guardava con sospetto il frigorifero; chiudeva a chiave l’aspirapolvere nello sgabuzzino: per evitare che lo inseguisse “quando meno se l’aspettava”. Cominciò a delirare tutta una serie di invettive all’indirizzo di quella che chiamava l’“evoluzione oggettuale inconsapevole”. “Nessuno di noi, Eugenio… Nessuno di noi, in questa famiglia, è in grado di capire come gli oggetti funzionano… Non saremmo in grado di metterli a posto o di ricostruirli, se smettessero all’improvviso di accendersi e di lavorare, eppure ne siamo asserviti… Siamo dipendenti, Eugenio, da meccanismi di cui non possediamo le chiavi interpretative. Se una qualche fine dovrà arrivare, se è questo che mi sta spiegando l’evangelista Giovanni, be’: è da loro che dovremo carpire il segno. Perché stanno diventando loro, gli oggetti che non comprendiamo, migliori di noi”.
Trascorreva lunghe ore davanti al televisore spento; o lo accendeva a notte inoltrata, molto dopo la calata della rete della rai sul cielo nuvoloso di fine-programmazione. Restava in silenzio a fissare la sabbia frizzante dello schermo fino all’alba, poi si alzava dal divano, girava la manopola e andava a dormire.
Delia, che era riuscita a trovare lavoro come segretaria in uno studio commerciale, era talmente stanca, la notte, da non accorgersi nemmeno di quando il marito si ficcava sotto le coperte, piano piano; e si lasciava crollare in un breve sonno tormentato da visioni: tutte più o meno dominate dalla figura ridacchiante del figlio; e così dolorose, per Tommaso, da diventare spesso causa di lacrime e rantoli che svegliavano Eugenio, nella brandina dell’ingresso. Messa lì per lui da quando il divano-letto del salone non era più utilizzabile.
Un mattino d’inverno del 1980, poco prima delle otto del mattino, con Delia che versava il caffellatte nella tazza di Eugenio e si asciugava il palmo della mano sulla vestaglia, Tommaso li aveva raggiunti in cucina, si era versato del caffè in un bicchierino di vetro.
“Il segno. Forse comincio a capire”.
Durante la notte, mentre fissava lo schermo bricioloso, dalla nebbiolina avevano cominciato a delinearsi alcune figure. “Una specie di tribuna politica, con tutte queste persone che parlottavano tra loro”. (Le persone, comparse sullo schermo all’improvviso, sarebbero tornate spesso: tutte le notti, più o meno, dei successivi quattro anni.)
Con il tempo Tommaso era riuscito a spiegare a Delia e a Eugenio – che avevano accolto la rivelazione nel modo solito con cui ascoltavano le parole di Tommaso: in silenzio – chi erano quelle figure e perché si erano sostituite, nell’iter profetico, al caro, vecchio evangelista Giovanni; muto (e irrintracciabile) dacché quei cinque uomini erano apparsi nella vita dei Calveri.
Quattro di loro erano i Cavalieri dell’Apocalisse,
spiegava Tommaso, a mano a mano che andava avanti con le sue ricerche e i suoi tentativi di interpretazione. “Mi parlano, mi spiegano le cose…”, diceva.
Sullo schermo, ripresi in un’inquadratura a tutto campo che a volte si accompagnava a primi e primissimi piani, c’erano Paul Nipkow, Karl Ferdinand Braun, John Logie Baird e Vladimir K. Zworykin. Moderatore e loro dio privato, Jöns Jacob Berzelius; che poi era anche l’unico che si rivolgesse direttamente a Tommaso chiamandolo per nome; il solo che, qualche volta, usciva dal riparo grigio del televisore e si accomodava in salotto a dialogare con l’ex commesso della upim di piazzale Dunant.
Paul Nipkow aveva depositato, il 4 gennaio 1884, il brevetto del disco rotante che porta il suo nome. “Il disco di Nipkow”, gli aveva spiegato Berzelius arrotolandosi una sigaretta, “una volta attivata manualmente la rotazione, permette di vedere un’immagine attraverso i filamenti di luce che penetrano nei fori disposti ad arte sulla superficie piatta del disco in movimento. Un procedimento meccanico, certo, ma che ha dato ottimi frutti… Il primo è stato il ‘tubo a raggi catodici’, nel 1897, inventato da Karl Ferdinand Braun.
Nell’ottobre del 1925, invece, anche sulla scorta degli esperimenti di Nipkow, l’inventore scozzese John Baird è riuscito a trasmettere, da una stanza all’altra, il viso di un ragazzo. La prima immagine a distanza. Ha costruito un apparecchio gigantesco, illuminato da una serie incredibile di lampadine… Una luce accecante che produceva, tra l’altro, un calore insostenibile: una vera e propria fornace di luce… E questo ragazzo si è sottoposto a quel calore, Tommaso: si è lasciato bruciare da quella luce finché nell’altra stanza non è apparsa, come uno spettro, la sagoma di un angelo, un viso in forma di luce in cui i colori dell’iride si sono incendiati in un unico bianco tremolante. Le persone che hanno assistito al fenomeno, Tommaso, si sono avvicinate tremando al telo sul muro, hanno sfiorato con le dita quella vita fatta di luce… Una luce che veniva dall’interno e cadeva fuori, bada bene: erano già abituati al cinema, alle immagini in movimento, Tommaso. Gli spettatori di Baird conoscevano già le immagini in movimento, il raggio polveroso del proiettore alle loro spalle… Avevano imparato già che il passato può essere imprigionato tra le immagini e poi proiettato una, due, mille, infinite volte… Quello che non conoscevano, invece, ciò che li bruciava da dentro e li costringeva a tremare di fronte a quel miracolo appena nato, era la distanza del presente. Il presente, catturato da lontano e poi condotto per mano fino a loro. Capisci, Tommaso? Loro erano abituati alla morte catturata dalle pellicole, erano pronti a sostenere l’infinità ripetuta della morte. Quello che li devastava, ora, era vedere da lontano la vita mentre succede, capisci? Rendersi conto per la prima volta che c’era un’altra vita, un’infinità di altre vite lontane che accadevano insieme a loro e di cui non avevano mai avuto una percezione definita. Fu questo a terrorizzarli, Tommaso. L’idea che una volta proiettato il presente da lontano, non ci si poteva più sottrarre alla responsabilità di prevederlo… Il ragazzo sorrise, Tommaso. Un impercettibile movimento delle labbra spaccate dal calore, poi l’apparecchio si spense, Baird si precipitò nell’altra stanza per sapere se l’esperimento era riuscito. E li trovò tutti in piedi, le mani e le braccia tese in avanti come sonnambuli. Il ragazzo aveva sorriso, in un luogo che non li vedeva presenti. E loro lì, a sfiorare con le dita quel fantasma di luce ancora vivo. Si aspettavano la morte e la memoria; una nuova, perfezionata capacità di cristallizzare il tempo e di rivederlo – e di impararlo – meglio ogni volta, e invece erano stati spaventati dallo spazio, dall’infinità di sorrisi nascosti che si ripetevano dovunque, in quel momento, nell’ora della loro vita dimezzata, lasciandoli per la prima volta inevitabilmente consapevoli e incapaci di accettarlo. Tutta un’eternità di uomini per imbrigliare la morte, e il passato, per poi capire che era il presente il vero demone introvabile rimasto a ridere sul bordo bucherellato del tempo”.
Baird aveva accennato un inchino alle parole di Berzelius.
“Permette che mi presenti, signor Calveri?”, aveva chiesto un uomo gentile a Tommaso: un primo piano che riempiva lo schermo. “Mi chiamo Vladimir. Vladimir Zworykin”.
“Zworykin”, aveva spiegato Berzelius, “tra il 1923 e il 1931 si è occupato delle stesse ricerche di Baird. Nel 1923 costruì l’iconoscopio e il cinescopio: gli apparecchi elettronici per trasmettere e per ricevere le immagini a distanza. Ma la prima versione realmente soddisfacente del cinescopio è del 1931. Si tratta di ricerche che si mescolano e si completano tra loro, Tommaso. Nel ’29 già si vendevano, nel Regno Unito, i primi ‘Televisor’ di Baird…”
I quattro uomini, dentro lo schermo, si guardavano tra loro facendosi cenni al tempo stesso rispettosi e risentiti. Quasi fossero persuasi anche loro di essere elementi di una catena storica che li accomunava; e senza la quale, pur nella loro genialità personale e riconoscibile, non potevano esistere.
“E lei chi è, signor Berzelius?”, aveva chiesto Tommaso. Berzelius gli aveva dato una pacca sulla spalla – più la pressione ostinata di una carezza, in realtà – aveva spento la sigaretta nel portacenere; poi si era aggiustato le falde spiegazzate della marsina ed era rientrato nel televisore.
“Jöns Jacob Berzelius è un chimico svedese vissuto tra il xvii e il xviii secolo, capito?”, aveva spiegato Tommaso a Eugenio una mattina, dopo un breve periodo di frequentazione notturna di Baird e degli altri, e lunghe ore trascorse a spulciare libri ed enciclopedie. “Già, ma che vuoi capire tu… Va bene. Berzelius ha cominciato le sue ricerche studiando gli effetti chimici della corrente elettrica. Ha scoperto il cerio, il torio, ha isolato il silicio e il titanio. È stato il primo a elaborare la nomenclatura chimica che usiamo ancora e riuscì a catalogare quarantacinque pesi atomici su quarantanove elementi noti al suo tempo!… E sai perché Nipkow e Braun e Baird e Zworykin lo considerano il loro portavoce, eh?… Io ci ho pensato. È perché tra le altre cose è stato lui a scoprire il selenio. È stato lui il primo a inventariarlo, ‘Se 34’, Eugenio, nel 1817…”
Tommaso era rimasto folgorato dalle incredibili connessioni trovate tra il selenio, “la pietra lunare, Eugenio, capisci? La pietra lunare…”, e la teoria della luce a distanza che Berzelius gli aveva rivelato. Passava ore a riflettere sul bianco passivo della luna, il disco bianco di Nipkow e lo spettro angelico di Baird.
“E poi il selenio è l’elemento naturale più usato contro i radicali liberi, capisci? Contro l’invecchiamento. Lo usano nella prevenzione dai tumori e per evitare i problemi della cataratta. Cura la sterilità… Senti quante cose, Eugenio… Il selenio è la pietra lunare della vita e dell’eterno presente… È la pietra di Berzelius, il brandello di luna da cui è cominciato tutto…”
Eugenio e Delia si limitavano ad annuire e a telefonare di frequente al medico che aveva in cura Tommaso. Che si era convinto, visita dopo visita dei suoi spettrali compagni notturni, che Berzelius, Nipkow, Baird erano stati mandati da Giovanni. Erano loro la strada che l’avrebbe portato al segno finale prima dell’apocalisse.
“Perché non mandarmi anche Philo Farnsworth, eh? O Kenjiro Takayanagi? O qualche tecnico della nbc degli anni Venti, un ingegnere dei Bell Telephone Laboratories? Perché proprio loro quattro e Berzelius?”, Eugenio aspettava sempre la solita risposta. “Perché la risposta è qui, Eugenio. È qui”, e batteva a palme aperte sulle pagine gialline della Bibbia di casa.
“Nell’Apocalisse di Giovanni, nel sesto capitolo… I quattro cavalieri, secondo la tradizione, sono– il primo, sul cavallo bianco, ‘la peste’… Secondo alcuni le ‘bestie feroci’, vabbe’… Vogliamo dire ‘la ferocia della peste’? diciamolo, figlio mio… E questo è Napkow… la ferocia malata con cui la luce gira nel suo disco di selenio. Poi c’è Braun, il secondo. La guerra, su un cavallo rosso: i raggi catodici in un tubo, i lampi rossi della guerra, il vortice. Tre: Baird. La fame sul cavallo nero, la fame che cavalca il disco di Napkow e lo brucia di luce: la fame di presente, la voglia di mangiare lo spazio e il tempo. Ultimo Zworykin, la morte del presente nell’avanti e indietro ripetuto della trasmissione e della ricezione… Mi stai seguendo?…” Eugenio alzava distrattamente la testa dal quaderno dei compiti e diceva di sì. “Ecco. Zworykin è l’ultimo dei cavalieri, sul cavallo verdastro dei circuiti ossidati, e Giovanni dice «e l’Inferno lo seguiva»; e poi «fu data loro autorità su un quarto della terra»… E infatti se ci pensi bene, anche se tutto il mondo che conosciamo non se ne rende conto, in questo 1982 che stiamo vivendo, i televisori non sono diffusi… ma anche l’elettricità, in genere… non sono diffusi che su un quarto del pianeta… Non ti sei mai chiesto perché di tutte le più grandi innovazioni tecniche dell’umanità si conosce il nome dell’inventore, e se invece chiedi a qualcuno: ‘Chi ha inventato la televisione?’ – dico: la televisione – rimangono tutti a bocca spalancata senza sapere che dire, eh?… Non ti sei mai reso conto, poi, che il motivo è che non c’è un solo nome, ma una serie di nomi che concorrono alla stessa cosa… Come peste, guerra, fame, morte: tutte insieme sono solo una parte dello stesso scenario con una chiusura a effetto. Così la catena di nomi che si è data appuntamento al 1931, al momento del cinescopio, è una serie di anelli saldati l’uno nell’altro. Se solo ne salti uno perdi di vista la visione d’insieme”.
Tommaso si infervorava, aveva la stessa espressione dell’Immacolata del Murillo; le sue componenti dilavate e smussate dagli anni, quella laica, quella irrazionale, venivano trascinate di peso dalla malattia verso le terre inesplorate dell’estasi; nella voce di Tommaso Calveri si sentivano le note diaccie di chi è convinto di vedere la verità.
“E poi la Donna rivestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, Eugenio… La luna che è stata calpestata, sminuzzata… Ogni pietruzza di luna è stata sbriciolata in milioni di granelli… Tutta la luna che c’è stata, il deposito di sogni per centoventi secoli di umanità, sgretolata nelle pietre di luna di Berzelius, la ‘corona di dodici stelle’ che le cinge la fronte…”
“…”
“…”
“Sì papà, va bene. Ti dispiace se vado in cucina a studiare?”
“Ma che cosa vuoi studiare tu, grande delusione della mia vita…”
Per quattro anni, Tommaso aveva disvelato a poco a poco la natura profetica delle sue scoperte tanto a Delia e a Eugenio quanto ai quattro più uno che lo andavano a trovare la notte. Ricevendo da Berzelius sorrisi di incoraggiamento; mormorii di approvazione da Baird e da Napkow, timidi sorrisi da Zworykin. Solo Braun si chiudeva in un impermeabile, teutonico rigore che non lasciava trapelare alcun indizio.
Dal 1980 al 1984, attraverso studi di numerologia e chiacchierate filosofiche, Tommaso si era convinto dell’ineluttabilità della fine ormai prossima. E aveva isolato una serie di dati numerici. Il 1884, l’anno del brevetto di Napkow. L’ottobre dell’esperimento sfolgorante di Baird. Il 1817 della scoperta del selenio, il suo numero atomico, il 1923 del cinescopio, il 1897 del tubo di Braun. Aveva notato la costanza di ripetizione della figura dell’otto, del quattro e del sette.
Finché, nell’ottobre del 1984, il 16 ottobre (“sei più uno sette”), quando l’Italia intorno cercava – in una smania millenaristica condivisa – la resa oggettiva della metafora di Orwell (e la ristampa del libro annunciava, sin dalla copertina, “l’anno che stiamo vivendo raccontato 36 anni fa nella più famosa delle profezie”); mentre i cinematografi della penisola celebravano i fasti di Amadeus di Forman e il primo Ghostbusters, negli Stati Uniti Ronald Reagan accoglieva il secondo mandato tra le braccia, i fermenti rivoluzionari della libera repubblica del Nicaragua subivano le pressioni ai fianchi dei Contras, “il rettangolo nero” di cui aveva parlato l’evangelista Giovanni al telefono cadde davvero sul pianeta; e l’apocalisse sembrò manifestarsi realmente, anche se per il solo Tommaso Calveri. Che, di passaggio da una stanza all’altra carico di libri, vide il televisore – che Delia e Tommaso stavano guardando – oscurarsi, prima: un velo nero improvviso che spense le trasmissioni. Poi sabbia grigia da cui s’affacciò il viso sorridente di Berzelius.
Tommaso fece cadere a terra i libri, camminò fino alla sedia più vicina. Sempre fissando la tribuna politica di Napkow e compagni, si piazzò a sedere accanto alla moglie e al figlio.
Per cinque giorni, da quella sera di martedì fino alla domenica successiva, Tommaso restò seduto sulla poltrona marrone dell’ingresso, guardando suo figlio dormire, andare a scuola e tornare; Delia uscire da casa e rientrare. Rimase ad ascoltare di tanto in tanto i vicini, sul pianerottolo, mormorare tra loro: “Ma questa è proprio ’a fine der monno, ma io nu’ lo so…”
La sera di domenica 21 ottobre, quando sentì Delia dire dal salone che le trasmissioni erano ricominciate. Quando la vide percorrere piano piano l’ingresso fino a lui, dicendogli con un sorriso – perché credeva di fargli piacere – che la tv aveva “ricominciato a trasmettere”, la malattia di Tommaso Calveri capì che l’apocalisse era arrivata ed era stata ritirata; che Dio si era rifiutato di giudicare il mondo che aveva trovato e che adesso erano, da quel momento in avanti, semplicemente cazzi loro; o che, forse, il giudizio c’era già stato e Dio aveva pensato non valesse la pena di scomodare l’inferno; quello era già un inferno bastante. L’inferno che seguiva Zworykin e il suo cavallo verdastro era identico alla sua vita di prima.
Senza, però, nemmeno l’agonia dell’attesa; privata della compagnia di Berzelius e compagni, che non si erano più fatti vivi dopo quell’ultimo sorriso di martedì.
Tommaso decise che non valeva la pena di indugiare oltre. Camminò fino alla finestra del salone, la spalancò. Eugenio e Delia lo seguirono fino all’ultimo con lo sguardo, pensando volesse prendere una boccata d’aria dopo giorni di immobilità più o meno assoluta.
Invece Tommaso salì sul davanzale. E si gettò, a braccia larghe, contro l’asfalto di via Leon Battista Alberti. Una ventata piena di gocce fredde prese Delia sul naso, quando si affacciò a guardare.
“Vogliamo ricominciare la recita”, bàmm-bàmm-bum,
bùmbum. “Vogliamo ricominciare la recita!”, bum bubùm- bum bum bum bum… “Voglià-mo-ri-co-min-cià-re-la-rè-cì-tà!”
È Elena, dietro la porta chiusa dello studio di Picchi. Ha portato con sé il tamburello di Kattrin la muta e lo sta usando con foga. La sfoglia celestina dell’uscio la separa da Eugenio e dal direttore; intervalla il bum-bum del tamburello con strattonate frenetiche alla maniglia.
“Aprìiite– Vogliamo ricominciare la rè-cì-tàaa…”
Picchi si alza dalla scrivania e, dopo pochi passi veloci e esasperati, tiene la maniglia della porta con una mano. “Elena, sei tu?”, fruga nella tasca dei pantaloni.
“Sìiiiii”, grida la bambina. Quando il direttore riesce a infilare la chiave nella toppa e a spalancare la porta dell’ufficio, Elena è ancora alle prese con le ultime i.
“che ci fai qui? Dove sono i tuoi?”
“Non ci sono. Vogliamo ricominciare la recita”. Eugenio si alza dalla sedia e si porta alle spalle di Picchi.
“Non si può ricominciare– la recita è interrotta”, le dice il direttore.
Elena guarda Eugenio.
“Maestro Calveri, perfavore. Giù stanno tutti aspettando. Walter è seduto sul palco e non vuole scendere”.
“…”
Picchi si affaccia dallo stipite della porta e vede il corridoio buio, a destra di Elena.
“Chi ti ha fatto salire qui?”
“Nessuno. Sono venuta su da sola”.
“…”
“Maestro Calveri, perfavore…”
“…”
“Il maestro è impegnato con me. Ora torna giù. Noi arriviamo subito”.
“…”
Elena arretra un po’ e ricomincia a battere con la bacchetta sul tamburello.
“Dovresti– Dovresti tornare giù e dire che la recita è finita”. Eugenio si sta chiedendo perché continua a parlare. Dovrei
fare come ha fatto Brecht con il comitato per le attività antiamericane, quando venne interrogato, il 30 ottobre del 1947; quando cominciarono a chiedergli se era comunista e lui prese a rispondere qualcosa come “non conosco il vostro bell’idioma”… “Non capisco”… “Non parlo la vostra lingua”… Bertolt Brecht in giacchetta grigia e camicia di flanella bianca, McCarthy che lo guarda con odio e lui gli risponde con il sorriso stampato dei puri di cuore a comando. Così, dovrei fare, visto che non serve parlare, certe volte, bisogna rispondere alle stronzate che ci dicono con il silenzio… Quanto silenzio abbiamo, di cui non sappiamo che fare, e lo buttiamo via lasciandoci portare dalle parole lungo una spirale di suoni senza respiro. Le pause, dovremmo imparare il valore delle pause, come nella musica. Il modo che la musica si dà perché si crei il bilanciamento esatto tra il flusso di suoni e i respiri di silenzio. E invece… avevo deciso di tacere, assecondare fino all’ultimo questa mia necessità di silenzio, avevo deciso di rispondere a Picchi con lo zero assoluto del suono, magari concentrandomi su tutti gli ∞*¶¡{§¿ che riuscivo a pensare – a ripeti∞*¶¡{§¿, magari. Avevo deciso di trovare un asilo dolce, un modo mio per proteggermi, mentre Picchi scriveva; e invece è bastato sentire il tamburello di Elena dietro la porta; è bastato che parlasse lei, per farmi dimenticare tutti i propositi di rigore. Non ho potuto regalarle quel poco di silenzio che le sarebbe servito, per capire che la recita non ricomincerà più, e invece
non è riuscito a stare zitto.
“Maestro, parlo io con Elena. Lei torni seduto: c’è da firmare alcune cose”.
“Non capisco la sua lingua, direttore”.
“Eh?” Picchi lo guarda infastidito. Gli indica la sedia. Eugenio resta in piedi accanto a lui, si toglie gli occhiali e li infila nella tasca interna della giacca. Si passa una mano sulla testa: è come se ci fossero piccoli chiodini che spuntano dalla pelle. Gli riesce di seguire i contorni dei suoi capelli tastando le zone di ombra tra l’attaccatura e la fronte.
“Calveri… E tu Elena, per favore, aspetta lì, seduta”, gli indica la panca nel corridoio. “Ora scendiamo insieme”. Torna alla scrivania lasciando la porta aperta. Finisce di compilare un modulo; Eugenio si avvicina alla finestra e guarda fuori. Sul campo di calcetto la terra si muove a mulinelli, disegna geni della lampada di pulviscolo e sabbia. Si ricorda di quando credeva che i mulinelli nell’aria fossero come il vortice nella vasca da bagno, quando toglieva il tappo; e ogni volta correva a vedere dove fosse il buco nell’aria che aveva fatto sparire la polvere dopo una trottola di danze.
“Io– Io davvero mi chiedo come abbia fatto, lei, Calveri, a diventare insegnante ausiliario in questa scuola”.
Nel 1994, a venticinque anni, Eugenio
si era laureato in lettere con una tesi in storia del teatro dal titolo La ribellione indolente di Mercuzio. Un lavoro di un anno e mezzo in cui si interpretava la morte di Mercuzio, in Romeo e Giulietta, come un suicidio progettato dal personaggio.
Un passo introduttivo, in particolare, era stato contestato dalla commissione d’esame. “Mercuzio cerca la morte per mano di Tebaldo sin dall’inizio della tragedia, delegando a Romeo l’atto finale del gesto: perché Romeo copre, materialmente, la spada di Tebaldo nel preciso istante in cui infilza il petto di Mercuzio. La morte successiva del cugino di Giulietta per mano di Romeo – il vendicatore ‘pilotato’ – non è altro che la realizzazione postuma dello scherzo architettato da Mercuzio perché la tragedia sia. Se si dovesse descrivere in una sola frase lapidaria quanto l’autore abbia voluto travestirsi da personaggio, si potrebbe dire: Shakespeare è Mercuzio”. A nulla erano valse duecento pagine di connessioni e agganci tra il Prometeo di Eschilo e il personaggio shakespeariano; i parallelismi tra la struttura delle invocazioni alle muse di ventuno poeti inglesi d’età elisabettiana e la storia della regina Mab raccontata da Mercuzio: la commissione non era stata persuasa. La stessa epigrafe da Cardarelli, «Io son come Mercuzio tra Capuleti e Montecchi / risibile figura», era stata presa da uno dei professori, che in un remoto passato aveva polemizzato con lo stesso Cardarelli – per essere poi definito dal poeta “lo scivolo di scolatura dietro il bastione dell’intelligenza” – per una “palese provocazione”. E, anzi, quell’io son con cui, di fatto, la tesi cominciava, era stato interpretato come un “ridicolo, infantile attacco liceale”; e la “quadrupla catena di immedesimazioni”, da Shakespeare a Eugenio passando attraverso Mercuzio e Cardarelli, dichiarata “un’arroganza fuori luogo”. Il voto finale era stato centotré, la vedova Calveri – sua madre Delia – si era comunque commossa e aveva gettato via un pensiero pietoso per Tommaso, lontano dalla sua vita quanto Mercuzio lo era dalla tesi di suo figlio.
Dopo la laurea, Eugenio aveva trovato lavoro come commesso in una libreria di Frascati.
Un lavoro provvisorio che – a sua detta – gli avrebbe permesso di temporeggiare qualche mese senza stare con le mani in mano. Una provvisorietà che era durata due anni: periodo di tempo durante il quale Vittoria era entrata nella sua vita con tutta l’irruenza di una Fiat Tipo lanciata contro di lui a quaranta chilometri orari. Vittoria l’aveva investito in un tiepido pomeriggio di aprile del 1996, dieci giorni dopo le elezioni vinte dall’Ulivo, imprigionandolo in ospedale il tempo esatto per perdere il posto di lavoro, una volta scaduto il contratto che gli veniva rinnovato ogni sei mesi.
Però: forse lo smisurato senso di colpa; forse l’istinto infermieristico della giovane infermiera – appunto – Vittoria Bernelli (al San Giuseppe di Albano Laziale); forse il curioso scambio di battute che c’era stato con Eugenio poco prima che svenisse: “Oddio, oddio mio, si è fatto male?”… “Non– si preoccupi… sto abbastanza bene… Solo… mi sembra che qualcuno si sia portato a casa la gamba destra”; Vittoria ed Eugenio si innamorarono l’uno dell’altra nello stesso tempo e con gli stessi modi. Iniziale sospetto empatico, attrazione fisica rimossa, attrazione fisica ostentata e infine consumata nella Tipo galeotta; radiosa esaltazione del proprio stato interiore; progetto di convivenza, convivenza; matrimonio. Si erano sposati sedici mesi dopo l’incidente, giorno più, giorno meno. L’8 agosto del 1997.
Senza più il lavoro in libreria, ma con una nuova euforia dettata dalla presenza accanto a lui di Vittoria, Eugenio aveva cominciato a inviare curriculum in tutte le scuole di Roma e dintorni; si era iscritto al Provveditorato agli Studi ed era riuscito a ottenere – poche, all’inizio – saltuarie supplenze come professore di italiano nelle scuole medie.
Nel 1999 aveva partecipato all’ultimo concorso pubblico nazionale nella storia dell’istruzione repubblicana, entrando in graduatoria – un punteggio non molto alto, in verità – e intensificando (di poco) il numero e la durata dei suoi giorni di insegnante.
Il 2000 era stato l’annus horribilis della sua vita familiare. Sua madre Delia era morta in gennaio. In maggio, Vittoria aveva avuto un aborto spontaneo dopo tre mesi di gravidanza. A Eugenio era venuto in mente che, vista la storia lontana di sua nonna Fedra, forse era il seme dei Calveri a essere cattivo: c’era qualcosa di poco stabile, una sorta di squilibrio della fertilità che aveva a che fare con la paura del futuro, evidentemente, più che con la biologia. Ma era stato il pensiero di un giorno e mezzo, perché un’infezione postoperatoria, dopo il raschiamento, aveva quasi ucciso Vittoria. Dopo una settimana di terrore in cui Eugenio si era scoperto a fare scongiuri contraddittori, dichiarazioni a voce alta di eventuali accordi con demoni meridiani e simili, “a patto che sua moglie vivesse”, Vittoria si era effettivamente salvata. Ma le era stato asportato l’utero.
La commissione d’inchiesta, nei mesi successivi (il periodo di tempo durante il quale Eugenio e Vittoria scaricarono l’angoscia di non poter avere più bambini nei progetti di vendetta contro i responsabili), riuscì a stabilire che, “il motivo scatenante l’infezione era da ritrovarsi negli strumenti clinici”, diceva la perizia, “non ben sterilizzati”; ma anche che era impossibile risalire ai veri responsabili del danno, “essendosi perduta la pratica relativa ai nomi e alle registrazioni del personale paramedico che aveva presieduto, materialmente, alle attività preparatorie” per le operazioni di quel giorno “in particolare”.
Costretti a odiare per tutta la vita un’entità senza connotati che gli aveva tolto i figli che non avrebbero mai avuto, Eugenio e Vittoria si strinsero ancora di più l’una all’altro, sopravvivendo ai tre anni successivi in un modo che avrebbe potuto dirsi felice.
Vittoria, dopo l’operazione, aveva ottenuto il trasferimento in altra sede: al San Giovanni di Roma; Eugenio, sempre precario, era comunque riuscito ad avere un paio di supplenze annuali di fila. Così che la loro vita coniugale si divideva tra il lavoro e brevi soggiorni in Abruzzo, dove ancora abitavano i genitori di lei.
Tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, dopo anni di prove generali, la Riforma della scuola riuscì a dare l’ultima spallata al sistema già traballante dell’istruzione pubblica, dimezzando di nuovo i fondi per la ricerca e l’insegnamento e causando smottamenti progressivi dalla prima elementare fino all’ultima sessione universitaria.
Il progetto “equiparazione totale”, varato dal ministero, prevedeva un accorpamento (e un insediamento) indiscriminato dei docenti delle scuole private nelle scuole pubbliche; e trasformava in insegnante di ruolo chiunque avesse avuto, per almeno tre anni consecutivi, una “nomina attiva” in una qualunque scuola italiana “autorizzata a impartire lezioni di ogni ordine e grado”. Un’equiparazione totale, questa, che vide la colonizzazione selvaggia di tutte le cattedre pubbliche da parte di qualsiasi insegnante che – docente privato per ripiego o per consanguineità con i presidi d’istituto non aveva importanza – avesse educato per “non meno di due ore alla settimana” una scolaresca di “sette persone o più”. A discapito, ovviamente, di tutti i precari pubblici, anche vincitori (o piazzati) del concorso del 1999, che – non ancora “di ruolo” – si videro scavalcati dai loro colleghi “più in linea con il nuovo corso meritocratico della storia”.
Non solo: in base alla nuova legge, non erano necessari, in sé, lauree o diplomi di specializzazione. Riecheggiò il grido “Vale più la pratica che la grammatica”, rinfacciato dal governo in carica all’opposizione di sinistra come “un loro parto degli anni Sessanta e Settanta”. Mutuando il concetto di “libera docenza ordinaria” dalle università (e applicandolo anche a tutti gli altri cicli scolastici primari e secondari) venne ratificato per legge il principio dell’autonomia iudicandi del direttore di ogni scuola.
Così da aprire le porte dell’insegnamento a chiunque, a insindacabile giudizio dei direttori e dei presidi, sembrasse in grado di “educare e formare bambini e ragazzi dai 5 ai 23 anni”. In una lunga intervista rilasciata al Foglio in quei mesi cruciali, Ferdinando Adornato – uno degli estensori del Manifesto programmatico dell’equiparazione – spiegò a chiare lettere: “Se Ungaretti ha potuto insegnare Letteratura italiana all’università La Sapienza di Roma senza essere laureato, perché ad esempio io non dovrei insegnare diritto internazionale nei licei; o storia dell’arte al Politecnico, visto che frequento con passione entrambe le materie da anni?”
Naturalmente, Eugenio fece da subito parte della larghissima fetta dei “tagliati fuori” per decisione ministeriale. Per tutto il 2006 e il 2007 riuscì a barcamenarsi tra supplenze saltuarie in due istituti diversi – distanti tra loro una trentina di chilometri – e speranze di revisione strutturale della Riforma, presto vanificate dalla crisi di governo del 2008 e dagli aggiornamenti costituzionali del 2009.
Nel settembre del 2009 Eugenio, dopo parecchi mesi di disoccupazione forzata, si trovò costretto ad accettare il ruolo di “insegnante ausiliario” per il teatro e le attività ricreative – una nuova qualifica professionale tutelata da contratti di lavoro semestrali – contemporaneamente, in una scuola media e in una scuola elementare di Roma.
Un lavoro, questo, che era stato molto utile alla famiglia Calveri; soprattutto in quel periodo di “rialzi programmati” del carovita. Nel 2010 (l’anno della “privatizzazione dissociata”), l’ospedale di Marino in cui Vittoria era stata trasferita d’ufficio, in seguito alla ristrutturazione del San Giovanni di Roma, venne chiuso per mancanza di fondi. E si ricorse – per lei e per tutto il resto del personale – a una forma di cassa integrazione leggera. Un terzo dello stipendio mensile, “a patto che ci si dichiarasse reperibili almeno otto ore al giorno per chiamate urgenti (in istituti ospedalieri a non più di dieci chilometri dal proprio luogo di abitazione)”.
Così erano trascorsi altri tre anni in cui Eugenio e Vittoria si erano dedicati alla blanda sopravvivenza: concentrandosi sulle spese utili, limitando gli acquisti voluttuari come libri e compact disc; facendo una lista rigorosa delle uscite mensili: il cinema ogni venti giorni; ristoranti o pizzerie una tantum, sfidando l’incoscienza casuale dell’umore.
Fino all’avvento dell’ipofasia di Dipentelz nelle loro vite, il momento più memorabile di quel triennio era stato quando, nel 2012, Eugenio era stato costretto dalle ristrutturazioni a cambiare scuola e ad accettare l’incarico di insegnante ausiliario alla Bettino Craxi di Ariccia.
Perché c’è sempre una storia universale di sottofondo,
nelle vite particolari degli individui. E l’esistenza “a recupero costante” di Vittoria e di Eugenio non era dissimile da quella di moltissimi loro connazionali. Il settanta per cento, a voler dare retta ai dati – soggetti peraltro a un ribasso pilotato – divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Riforma della scuola era solo uno degli aspetti della vita del Paese: e la storia recente della fine dell’istruzione pubblica solo uno dei rivoli che, interrogativi e sculettanti come bisce in un cesto da incantatori, confluiva poi nel fiume largo e fluido della storia italiana d’inizio secolo.
Tra il 2006 e il 2014 si erano alternati alla guida del Paese sei governi e otto presidenze del consiglio, tra “premier esecutivi” e primi ministri aggiunti.
Nella primavera del 2006 la maggioranza uscente era stata battuta di misura dall’opposizione di sinistra; per due anni il governo aveva, timidamente, cercato di riconsiderare, almeno, le decisioni prese dalla coalizione appena sconfitta. Ma, tra liti di partito e impossibilità strutturale di capire che l’elettorato di base della maggioranza in carica non era quello moderato, il governo riuscì a resistere – appunto – appena due anni: fino al 2008; quando si spaccò in una tale congerie di microalleanze che si dovette ricorrere alle elezioni anticipate. Vinte, di nuovo, dalla destra con oltre il sessanta per cento dei consensi. Rinfrancato da un tale plebiscito, il nuovo governo in carica iniziò una serie di modifiche strutturali della Costituzione. Abrogò definitivamente i titoli provvisori, aggiunse precisazioni in chiave ipercattolica degli articoli inerenti la famiglia (specificando le distinzioni sessuali, prima lasciate implicitamente fuori dalla lettera del testo). Soprattutto innescò, a partire dal 2009, il meccanismo a orologeria che avrebbe condotto alla Grande Riforma Fiscale. Alla nuova ripartizione delle fasce erariali. All’idea delle tre fasi di inflazione “a rialzo programmato”.
Giulio Tremonti, rinominato a sorpresa ministro dell’economia, aveva ideato un piano di sviluppo a suo dire “semplice e risolutorio”. Bastava, secondo Tremonti, calcolare il tasso d’inflazione e “aumentarlo surretiziamente di due punti ogni anno per i tre anni successivi”. In questo modo, spiegava il ministro, “la popolazione italiana si adeguerà, gradatamente, a sacrifici sempre più intensi che però, di qui a poco, porteranno al risanamento integrale delle finanze dello Stato”. Ribaltando diametralmente le già fallaci teorie economiche degli anni precedenti, il ministero dell’economia aveva deciso di sottoporre il Paese a uno sforzo insensato e – dal punto di vista strettamente tecnico – privo di fondamento. Con inevitabile crollo, in Italia, del potere d’acquisto dell’euro e timidi accenni di dissenso da parte della Comunità Europea che rimasero, comunque, inascoltati.
Il contraccolpo della Grande Riforma Fiscale costrinse la maggioranza a un doppio rimpasto di governo tra il 2010 e il 2012. Il tempo giusto per mettere mano all’ultima delle grandi opere, la ricomposizione del sistema elettorale.
Sul modello delle squadre di calcio, venne proposto il sistema del “premierato oligarchico”. Le strade vennero tappezzate di manifesti inneggianti a questo modulo “più democratico e liberista”. Al premier esecutivo designato – espresso dalla coalizione vincitrice – si sarebbe affiancato il primo ministro aggiunto: a scelta, il candidato più votato o il leader dell’opposizione. “Questo”, aveva detto Silvio Berlusconi, “garantirà una maggiore, più ecumenica, governabilità”.
Il nuovo corso creò evidentemente problemi iniziali di adattamento. Nel giugno 2012 Giuliano Amato si insediò come premier della maggioranza e Silvio Berlusconi come primo ministro aggiunto. Ma le pressioni dell’estrema sinistra portarono Amato, da lì a un anno, alle dimissioni. In luogo del ritorno alle urne, il presidente della Repubblica consigliò un rimpasto di maggioranza. Tanto che il posto di premier vacante venne assegnato a Enrico Letta. Recisa via per sempre la componente di estrema sinistra dell’esecutivo, Letta – sotto il sole sbiadito del febbraio del 2013 – sembrò l’anestesia adatta per la febbre malarica che andava covando nella palude bicamerale.
E la biga Letta-Berlusconi resisteva ormai da venti mesi alle redini del governo di unione nazionale permanente. Questo, malgrado la crisi economica e sociale più disastrosa e duratura della storia repubblicana.
Eugenio e il dottor Elvio Picchi scendono le scale
lentamente. Il direttore è un gradino più basso di Eugenio, tiene Elena per mano e cerca di assecondare i passi di lei con dei movimenti a ventaglio del polso: come se fosse un domatore con una frusta invisibile stretta nel pugno. Eugenio pensa a Bertolt Brecht; alla sua afasia vittoriosa, con il comitato per le attività antiamericane. Nella tasca della giacca c’è la sua “comunica∞*¶¡{§¿ ufficiale di rescissione unilaterale del contratto”; così recita, agli occhi e alle orecchie di Eugenio, la dicitura stampigliata in alto a sinistra, poco prima del “Caro dottor Eugenio Calveri”.
Elena raggiunge per prima il pianterreno e si libera dalla mano pelosa di Picchi. Corre verso l’entrata del teatro, in fondo al corridoio, subito dopo le scale che portano in palestra.
Picchi si gira verso Eugenio e gli chiede se intende tornare in teatro o preferisce andarsene a casa.
“Oppure vuole prima cambiarsi?”, chiede il direttore, facendo una rapida passata con gli occhi sul vestito da Brecht. “Capisco che può risultare particolarmente imbarazzante, questa situa∞*¶¡{§¿… Sicché non la biasimo, se volesse andare via da qui senza… senza salutare”.
Per un lungo istante emozionato – di questo si rammarica, perché si rende conto di non riuscire a nascondere un imbarazzo che non nasce da timore reverenziale (che non ha mai avuto per nessuno, nemmeno per suo padre), né dal fastidio per il licenziamento – per un lungo istante emozionato ragiona sul da farsi; e si rende conto che quasi mai
nella mia vita, ho concluso quello che avevo deciso di portare a termine. Non dico l’amore o gli affetti, e neppure le cose realmente importanti, che magari ho sempre finito, realizzato, anche se in ritardo… compiuto, terminato, nonloso più: a furia di cercare le parole, ne trovo troppe. Parlo di tutte le miriadi di pretese accessorie che ho soltanto abbozzato; dilungandomi mentalmente, magari, sulla prepara∞*¶¡{§¿, sull’idea futura di me una volta tradotto in realtà quello che stavo solo pensando. Un viaggio necessario, un’autodisciplina di cui sentivo la mancanza, un ritorno, una maledetta recita di addio del cazzo. È più un’impressione, a conti fatti
che la realtà effettiva delle cose. E comunque ha deciso cosa fare. Supera Picchi, scansandolo con il solo frusciare del vestito. Questo è l’ultimo atto alla Bettino Craxi, l’epilogo che va ricordato.
La scuola elementare Bettino Craxi era
una delle poche scuole pubbliche rimaste dopo il 2010. Il progetto di “privatizzazione dissociata” aveva investito tanto l’istruzione quanto la sanità, beccando in pieno la famiglia Calveri su tutt’e due i fronti e – da una griglia statistica all’altra – la gran parte del mondo intorno a Eugenio e a Vittoria. La dissociazione di ogni singolo ente dalla struttura statale implicava un pagamento “a riscatto” ridicolo – “ma sicuro”, aveva vaticinato il ministro dell’economia – da parte dei vari consigli d’amministrazione autonomi che cominciarono a radicarsi come muschio sulle macerie della vecchia gestione.
Un pagamento che concedeva un immediato distacco dalla sfera del controllo pubblico; e garantiva piena indipendenza decisionale ai singoli istituti, ospedali o scuole che fossero. In realtà, il pagamento “ridicolo ma sicuro” era servito per fare cassa solo il primo anno, ed era stato invece subito restituito con gli interessi attraverso il “finanziamento completivo” del governo.
Così, come una varicella sulla schiena della nazione, le scuole e gli ospedali pubblici o si erano trasformati in aziende private o avevano chiuso i battenti per mancanza di fondi. In compenso i finanziamenti ad hoc decisi dalla Presidenza del Consiglio, in quattro anni, avevano permesso la creazione di isole differenziate impermeabili tra loro: scuole cattoliche, scuole islamiche, scuole protestanti, scuole valdesi; in più era stata quasi caldeggiata una forma avvilente di autoghettizzazione etnica: tanto da favorire la formazione di istituti scolastici filippini, nigeriani, sloveni, albanesi. La multietnicità, considerata da più parti “un’utopia ingestibile”, era stata pressoché annullata dal bianchetto vidimatore delle decisioni governative.
E così la Bettino Craxi, attivata con finanziamenti interamente statali nel 2011, benché ancora parte della piccola enclave sparsa a gestione statale, era ormai in dirittura d’arrivo nella pratica di privatizzazione. Picchi aveva parlato con Eugenio proprio di questo, il giorno in cui lui aveva chiesto di poter organizzare la recita.
“Di qui a poco la scuola diventerà una scuola privata. Forse cattolica, dobbiamo ancora decidere… E lei, lei capisce, Calveri… Un insegnante ausiliario per il teatro e le attività ricreative, sinceramente non ce lo possiamo proprio permettere. Certo: se lei fosse disposto a qualificarsi come semplice… collaboratore… non lo so, una qualche formula part-time più delineata… Ma di questo– di questo parleremo più in là, certo… Per ora organizzi pure la sua recita con i bambini. La nostra ambi∞*¶¡{§¿ è proprio quella di offrire il meglio, no? E se lei… via Calveri”, aveva sorriso, atteggiandosi già a manager aziendale, “se lei amerà la Bettino Craxi la Bettino Craxi amerà lei… no?”
Quando Eugenio aveva chiesto se, almeno, dopo la ratifica della privatizza∞*¶¡{§¿, la scuola avrebbe cambiato nome, il direttore era sembrato cadere dalle nuvole. “Come cambiare nome, Calveri?… E perché?”
Negli ultimi quindici anni c’era stata una rielaborazione
continuata della realtà; si era arrivati a una riscrittura di quel passato prossimo che Eugenio considerava il male su cui poggiavano le scelte per il futuro. In particolare, la figura di Bettino Craxi era stata oggetto di una costante riabilitazione che l’aveva trasfigurato, da latitante a padre della patria, fino all’inaugurazione di scuole e piazze a suo nome.
Tutto era cominciato nel 2005. Nel novembre di quell’anno si era rifatta viva, attraverso i media, Vincenza Tommaselli, quella che negli anni Novanta del xx secolo era stata definita la “Enza di Bettino”: la segretaria fidatissima del leader del psi, reduce da una serie di condanne per corruzione e favoreggiamento. L’ultima, nel 2000 (quando almeno un briciolo opportunista di buonsenso avrebbe consigliato una certa cautela speculativa): una truffa fatta – a suo dire – “per amore”, con la complicità del fidanzato, Vincenzo Cutullè, un calabrese della Costa Azzurra molto probabilmente affiliato alla ’ndrangheta.
“Sono stufa”, aveva dichiarato l’ex carcerata Enza Tommaselli al giornalista di Studio Aperto, “stufa marcia di sentirmi trattare come una delinquente comune. E soprattutto sono stufa di vedere tante persone fare la bella vita mentre– mentre la memoria del povero Bettino viene infangata quotidianamente”. Poi aveva tirato fuori un fazzoletto incredibilmente vasto – questo era l’unico aggettivo disponibile allo spettatore, vedendo quel rettangolo di stoffa bianca coprire interamente l’inquadratura, come fosse uno di quei teli con cui un tempo si coprivano gli specchi di casa perché non imprigionassero, per sempre, l’anima degli appena defunti. Si era soffiata il naso e – con lo stesso fazzoletto – si era asciugata gli occhi.
Allo sfogo di Enza si erano aggiunte le parole commosse dei figli di Craxi, Bobo e Stefania. Il sacerdote di Brescia don Gianni Mondini, già promotore di un pellegrinaggio ad Hammamet nel 1999, aveva aggiunto fuoco al fuoco, tuonando dalla parrocchia di San Giacinto contro i “sepolcri imbiancati che avevano reso il povero martire Bettino Craxi un capro espiatorio”, stabilendo così, in un solo intervento mediatico, il guinness di frasi fatte bibliche in una sola emissione di fiato. Da più parti cominciarono a essere riciclate affermazioni fatte dai leader di partito qualche tempo prima che Craxi morisse. Le parole di Berlusconi vennero ripetute sui giornali a quasi sette anni dalla loro prima resa: “Gli ero amico e lo frequentavo. Vi assicuro che non mi sono mai accorto di avere a che fare con un uomo ricco… Certo, la signora aveva abiti bellissimi per le occasioni mondane, ma erano vestiti prestati da stilisti amici, Valentino e altri”. Chiunque provasse a ricordare che Craxi non era un esiliato, ma un latitante, veniva guardato di malocchio: come non si rendesse conto che la storia andava avanti: e una volta sanate le ferite, le cicatrici abbelliscono la pelle di esperienza.
Tra il 2007 e il 2008, mentre cominciavano a proliferare le prime pubblicazioni revisioniste – La colpa dei padri di Paolo Guzzanti, Io lo conoscevo bene di Giuliano Amato: tutti pubblicati da Mondadori con prefazioni di Gianni De Michelis o di Giuliano Ferrara – alcuni paesini della Lombardia, in aperta “rappresaglia contro il recente sentire comune”, cominciarono a dedicargli le prime vie. Un padre di Milano, addirittura, decise di chiamare il primogenito Bettinocraxi, inscenando una manifestazione di protesta davanti all’ufficio anagrafe, dopo il timoroso rifiuto burocratico di un impiegato.
Ma la riconsacrazione definitiva avvenne in televisione, quando fu riproposta un’intervista del 30 settembre 1999 fatta a Craxi da Sandy Marton, il cantante estivo che aveva spopolato negli anni Ottanta con “People from Ibiza” e “Camel by Camel”. Quattro mesi prima della propria morte, il latitante socialista si paragonava a Edmond Dantès, dilungandosi sulle sue lacrime di rabbia e di nostalgia. L’intervista, trasmessa in prima serata su rai 5 e inserita in uno “Speciale Craxi” curato da Giovanni Minoli, ottenne uno share del 47%, affogando tutte le remore che ancora comunque resistevano, caparbie, in pochi irriducibili detrattori (come Eugenio e Vittoria).
Eugenio aveva un conto aperto pubblico e uno privato con Bettino Craxi. Se provava a riflettere con cura sull’inizio di quella che considerava la fase di non-ritorno della società italiana, vedeva con nettezza gli anni Ottanta, l’onda lunga del psi, l’edonismo reaganiano riproposto nelle mode d’accatto dei nuovi ricchi della Brianza e del bergamasco. La Milano da bere, il caf, il veloce attecchire dell’idea che gli uomini possano essere comprati: e i non comprabili sono delle escrescenze sociali, delle anomalie refrattarie ai cambiamenti antropologici.
In tutto questo – che poi era stata la sua giovinezza disperata – Eugenio vedeva il cancro propedeutico che aveva cambiato le piccole weltanschauung quotidiane della maggioranza delle persone; anzi: non cambiate: legittimate a oltranza soprattutto nelle loro varianti più calcolatrici e trasformiste. Ed era stato questo il la al trentennio successivo, il pensiero curvo che, una volta accettato, era destinato a ritornare ciclicamente; come un difetto cui si è affezionati e del quale, addirittura, non dà fastidio vantarsi.
Era stato Craxi a firmare nel 1984 i nuovi patti lateranensi; il puntello su cui poi – forzatura dopo forzatura – i governi che l’avevano proseguito si erano appoggiati per arrivare alle “privatizzazioni dissociate”.
Era stato Craxi, dopotutto, a premere il bottone del suicidio di Tommaso, quel 21 di ottobre del 1984. Con la complicità di Silvio Berlusconi.
Eugenio entra di nuovo nel teatro,
scosta le tende di velluto rosso (gualcite, bucate in parecchi punti: lise e sciupate come promesse ripetute troppe volte) e cammina lungo il corridoio tra le poltrone. Parecchi genitori sono ancora lì, parlottano in piedi, vicino ai termosifoni, appoggiati alle uscite di sicurezza. Quando Eugenio entra, Teresa e Ludovico gli si fanno incontro e gli chiedono della recita. Teresa porta ancora addosso la sua parrucca da Jenny delle Spelonche. Walter è sul palco, seduto a gambe incrociate. Con una mano si aggiusta la barba finta, la preme sulle guance per far attaccare meglio la parte adesiva.
Lo sta aspettando. Eugenio pensa a sé stesso in silenzio e rivede suo padre: quando lo guardava dalle quinte nello stesso, identico modo in cui Walter sta guardando lui.
Il 16 ottobre del 1984, la data apocalittica
che Tommaso Calveri si era trovato addosso, era il giorno in cui alcuni pretori del Lazio, dell’Abruzzo e del Piemonte – precisamente di Roma, di Torino e di Pescara – avevano decretato la disattivazione degli impianti televisivi della Fininvest. Secondo una legge dello Stato confermata da tre sentenze della Corte Costituzionale, solo alla rai era concesso di trasmettere in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Alle reti private – come quelle del tycoon Berlusconi – era riservato esclusivamente l’ambito locale. Sicché, violando la legge, le reti Fininvest erano state oggetto di decreto penale prontamente fatto rispettare – quel 16 ottobre – dagli uomini della Guardia di Finanza.
Venuto a conoscenza dell’oscuramento parziale delle sue trasmissioni, Silvio Berlusconi si era prodotto in un “tutto o niente” sansoniano: fino a spegnere di sua spontanea volontà tutte le trasmissioni dalle Alpi a Capo Passero.
Pronto per un viaggio a Londra, il giorno dopo il presidente del Consiglio Bettino Craxi punta i piedi; comincia a strillare che non si può trattare così un suo amico che non fa niente di male, fa vedere Dynasty e Dallas, se non si riaccende la luce in Piemonte, nel Lazio, in Abruzzo – e in parte delle Marche – la luce resterà spenta in tutt’Italia. O cacciate i pretori o me ne vado via io, bercia il presidente del Consiglio; e parte per Londra.
Dal Regno Unito convoca il Parlamento in seduta straordinaria per il sabato mattina, si decide un decreto. La sera del 21 ottobre 1984 Silvio Berlusconi si rilassa, riaccende la tv. E in quella serata di apocalissi rinviate, Tommaso Calveri trova l’asfalto di via Leon Battista Alberti.
Se c’era una data da ricordare, per spiegare la metafora della fase di non-ritorno, la data era quella. Quando un’intera nazione era scesa in piazza per protestare contro la sua stessa Costituzione. E si era confusa la libertà con il privilegio: tutti zitti, ad aspettare che riprendessero le trasmissioni, ad accettare come vere le affermazioni di chi, cittadino tra gli altri, amico tra gli amici che battevano i piedi e trattenevano il respiro, quando non erano accontentati, aveva appena cominciato a pulirsi il culo con la carta costituzionale e le decisioni dei pretori.
Ora Eugenio è salito sul palco
in silenzio. Non ha ancora parlato. I bambini gli hanno fatto domande e lui non ha avuto risposte, per loro. Dall’alto del proscenio si accorge che il direttore è molto infastidito; si aspettava che se ne andasse. Gli ha concesso un ultimo saluto ai genitori e ai bambini; ora invece Eugenio è salito sul palco, accanto a Walter. Walter si è alzato in piedi. Eugenio comincia a parlare.
“Non era– Non era mia inten∞*¶¡{§¿ offendere nessuno, naturalmente, con questo spettacolo. Mi spiace anzi vedere che né Stefano, né sua madre sono ancora qui– Vedete… Io stesso non mi rendo ancora conto di come sia stato possibile arrivarci, fino a qui… Se provo a riflettere su tutti i passaggi, dal– dal monologo di Walter in poi, mi si appanna tutto in una… in un’unica nebbia confusa… la stessa sensa∞*¶¡{§¿ di quando si è stati svegli a lungo, da soli, senza parlare con nessuno… E tutti i rumori sono distinti, ma arrivano da un punto lontano del tempo, più che dello spazio, come se ci rivelassero il senso segreto di ogni loro a rumorosa… come se ce la indicassero mentre succede.
Io… capisco che molti di voi si aspettavano qualcosa di completamente diverso. Eravate qui per assistere alla recita dei vostri figli e invece vi siete trovati invischiati in un’altra storia – in tutta un’altra serie di storie, un’interse di storie l’una con l’altra che si sono inseguite nella vostra testa fino a qui… Vedete, il motivo per cui ho pensato, una settimana fa, di preparare questo spettacolo, dipende dal fatto che già sapevo di dover lasciare il mio lavoro in questa scuola… E ho pensato, appunto, di organizzare per me – e per i bambini, non crediate. Soprattutto per i bambini, perché gli restasse un bel ricordo… un ultimo ballo…
Io e mia moglie, sapete – ve lo dico, anche se la mia è una piccola storia, che non c’entra, con lo spettacolo e con voi e con i vostri figli, se non di sfuggita… Io e mia moglie Vittoria, vi dicevo, abbiamo una canzone. Non è che ci siamo conosciuti, la prima volta che ci siamo visti, sulle note di questa canzone, no. Lei mi ha investito con la macchina… è così che ci siamo conosciuti… Ma quando ero all’ospedale e lei– lei mi veniva a trovare, praticamente tutti i giorni… Ogni volta che andava via: alla fine dell’orario di visita, sapete?… Io le canticchiavo dal letto ‘Save the Last Dance for Me’ e lei mi faceva di sì con la testa, mi sorrideva e se ne andava via – è così che ci siamo innamorati… Ed ecco, sarà una fissa∞*¶¡{§¿ che m’è presa, non lo so… Forse una convin∞*¶¡{§¿ senzasenso… Ma, vedete… in tutte le culture, da sempre, si… celebra la fine di un ciclo con una danza… la fine di un’epoca, la fine di una vita… a poco a poco le danze magari sono diventate gesti rituali e se n’è persa tutta la loro componente… fisica… ma c’è sempre una danza intorno alla fine delle cose– un valzer sul ponte del Titanic che affonda, gli orixa che si rotolano per terra e parlano dall’orlo di un mondo all’altro… Anche l’ultima danza, l’ultimo ballo che si riserva alla persona che si ama, è quello più importante, perché la cosa più importante è essere insieme alla fine. Degli inizi sono capaci tutti. Chiunque può iniziare. Quello che conta è arrivare alla fine e tenerla sospesa nell’ultimo presente che ci resta.
Questo spettacolo, signore e signori, aveva l’inten∞*¶¡{§¿ di farvi ricordare… No, ricordare non è la parola giusta… Scusate ma io sono uno di quelli che mette molta atten∞*¶¡{§¿ nelle parole che usa– per questo non mi piace pensare che la signora Moroni, e suo figlio, mi ricorderanno come qualcuno che li ha offesi… Dicono che, nell’Ottocento, i valzer che ora ci sembrano stantii, e ridicoli, venissero considerati balli particolarmente lascivi.
Forse era qualcosa che ha a che fare con il tempo che passa, e la musica, quando non viene condivisa e resta nell’aria, le mancano le parole. Forse era di questo che io e i bambini volevamo parlare. Poi il tempo e la musica ci hanno portato da qualche altra parte… Fino a me che vi parlo così, travestito da Brecht, quando invece era previsto tutto un altro finale– avrei dovuto parlarvi di questi… di questi tempi bui, dell’unica musica che condividiamo davvero… mi sembravano così tante le parole da dirvi: e alla fine vi ho parlato di me. E di mia moglie Vittoria…”
Nella sala, i genitori lo guardano meravigliati. La musica che Eugenio ogni tanto sente gli mette la febbre negli occhi; e tutti, il direttore, i padri e le madri dei piccoli attori, si sentono prendere da una paura retrospettiva che gli mozza il fiato. Hanno affidato a quest’uomo i loro figli – la madre di Teresa le toglie la parrucca di testa e le ravvia i capelli come se stessero prendendo fuoco.
“Scusate. Pensavo di chiarire ogni cosa, parlando. E invece non sono riuscito a trovare le parole giuste. Solo questa musica che mi si ripresenta in continua∞*¶¡{§¿ e che vi lascia storditi”.
Walter gli si avvicina e gli tira una spalla della giacca.
“…”
“…”
“Cosa c’è?”
“Basta così, maestro Calveri”.
Una sera, pochi mesi prima che Tommaso morisse,
lui e Eugenio erano seduti sul divano, guardavano la televisione. Mtv non esisteva ancora, c’era solo Videomusic, e a un certo punto avevano trasmesso il video di “Breakin’…There’s No Stopping Us”. Tommaso aveva cominciato a bofonchiare qualcosa, poi aveva alzato le braccia al cielo e detto che tutto questo era stato inventato da Kurt Weill. Eugenio fissava i ballerini dimenarsi in schizzi frenati del loro stesso corpo in movimento: si rotolavano sui glutei, imprimevano scariche elettriche alle braccia dalle punta delle dita, lungo le spalle, fino al dorso dell’altra mano, come giocatori di basket che si facessero passare un pallone invisibile lungo il filo orizzontale della schiena
“Che cosa?”
“Questa musica, queste schegge frenate di musica… La danza pausata che fanno – è stato Kurt Weill”.
“…”
“Quando ha portato l’organo di barberia in scena… Hai presente ‘Mack the Knife’? L’organetto che suona, la manopola che gira, gira, un movimento meccanico che produce musica… Se freni il braccio e torni indietro… Se ripeti lo stesso movimento pausato due, tre volte, l’effetto è lo stesso. Pensaci”.
Eugenio aveva cominciato a pensarci.
“Che poi ‘Mack the Knife’ l’ha riscritta, praticamente, Louis Armstrong, un pezzo di jazz… E invece ‘Alabama Song’… Musica rock, il lato a del primo long playing dei Doors…” E l’aveva accennata. “Oooh mo-oon… from À-lla-baaama… Senti? Senti che ci sono già tutte le cadenze che verranno riprese nel futuro?… Senti la luna? Eh?”
Ora Walter è seduto accanto a lui su una panchina nel cortile della scuola. Da un lettore cd portatile Ute Lemper canta “Nannas Lied”, la canzone con cui avrebbero dovuto chiudere lo spettacolo, alla fine del monologo di Eugenio: un brano da Terrore e miseria del Terzo Reich che Eugenio non reciterà mai più.
Eugenio si è cambiato i vestiti; e anche Walter, malgrado il trucco che non ha lavato via bene dalla faccia, indossa un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica. È protetto da un piumino con il collo di pelliccia sintetica. Accanto a lui, sulla panchina, un grosso borsone grigio che contiene Galileo: la tunica, il medaglione, i sandali, la barba posticcia.
Il vento semina strade bagnate sulla testa rasata di Eugenio.
“Ma insomma, quando arrivano i tuoi?”
“Tra una mezz’ora, mi sa… Quando doveva finire la recita”.
“…”
“Mia mamma lavora come segretaria… A quest’ora è al lavoro”.
“E tuo babbo?”
“…”
“Tuo papà”.
“Papà è a Roma”.
“…”
“Maestro… Volevo dirle che a me m’è dispiaciuto di non finire la recita, mi piacevano quelle parole che m’ha fatto imparare…”
“Grazie, Walter. Sono contento”.
“Sì, erano belle. Un po’ strane ma belle parecchio”.
“…”
“…”
“Lo sai Walter che tu mi ricordi me quando avevo la tua età…”
“…”
“…”
“E questa è una cosa bella o una cosa brutta?”
“Non– Non lo so… Per te com’è, bella o brutta?”
“…”
“…”
“Io non lo so, maestro Calveri. Io non lo so com’eri tu alla mia età”.
All’uscita dalla scuola aveva riacceso il cellulare. L’aveva chiamato Vittoria per sapere com’era andata. Lui aveva detto che non voleva che lei vedesse lo spettacolo; che si sarebbe emozionato: non voleva che lo vedesse fare Brecht. Ora era convinto che le fosse dispiaciuto, non esserci. Le aveva detto Ti amo, lei aveva detto Anch’io.
“Tu sei molto più bravo, Walter”.
“…”
“…”
“Grazie”.
“Di niente, è la verità”.
“Maestro… volevo dirle che adesso grazie a lei conosco tutta quella storia dei pianeti che diceva il libro… Tutta la storia della rota∞*¶¡{§¿ e della rivoluzione”.
“Cosa?”
“…”
“Cos’hai detto?… L’ultima parola– l’ultima parola che hai detto, ri–”
“–rivolu∞*¶¡{§¿… Perché?”
Giordano Meacci (Roma, 1971) ha pubblicato per Rizzoli Fuori i secondi e per minimum fax il reportage Improvviso il Novecento. Pasolini professore (2015) e la raccolta Tutto quello che posso (2005). Un suo racconto è incluso nell’antologia La qualità dell’aria, ripubblicata nel 2015. Il suo primo romanzo, Il Cinghiale che uccise Liberty Valance (minimum fax), è stato finalista al Premio Strega 2016. Con Claudio Caligari e Francesca Serafini ha scritto Non essere cattivo (2015) di Claudio Caligari.




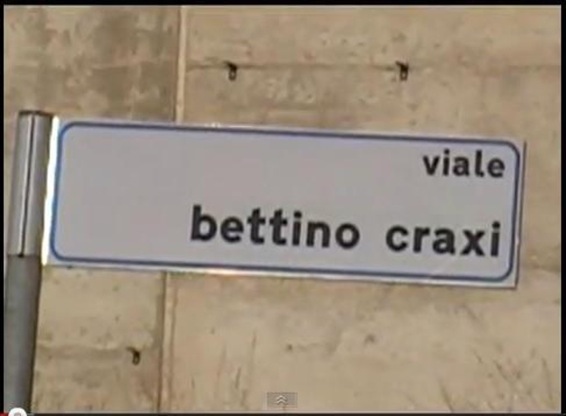


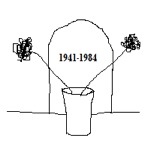
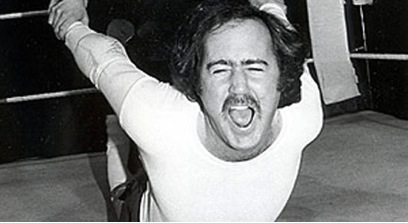
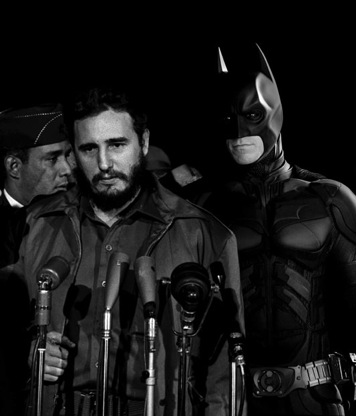
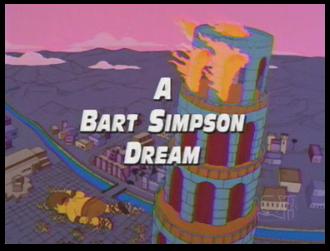



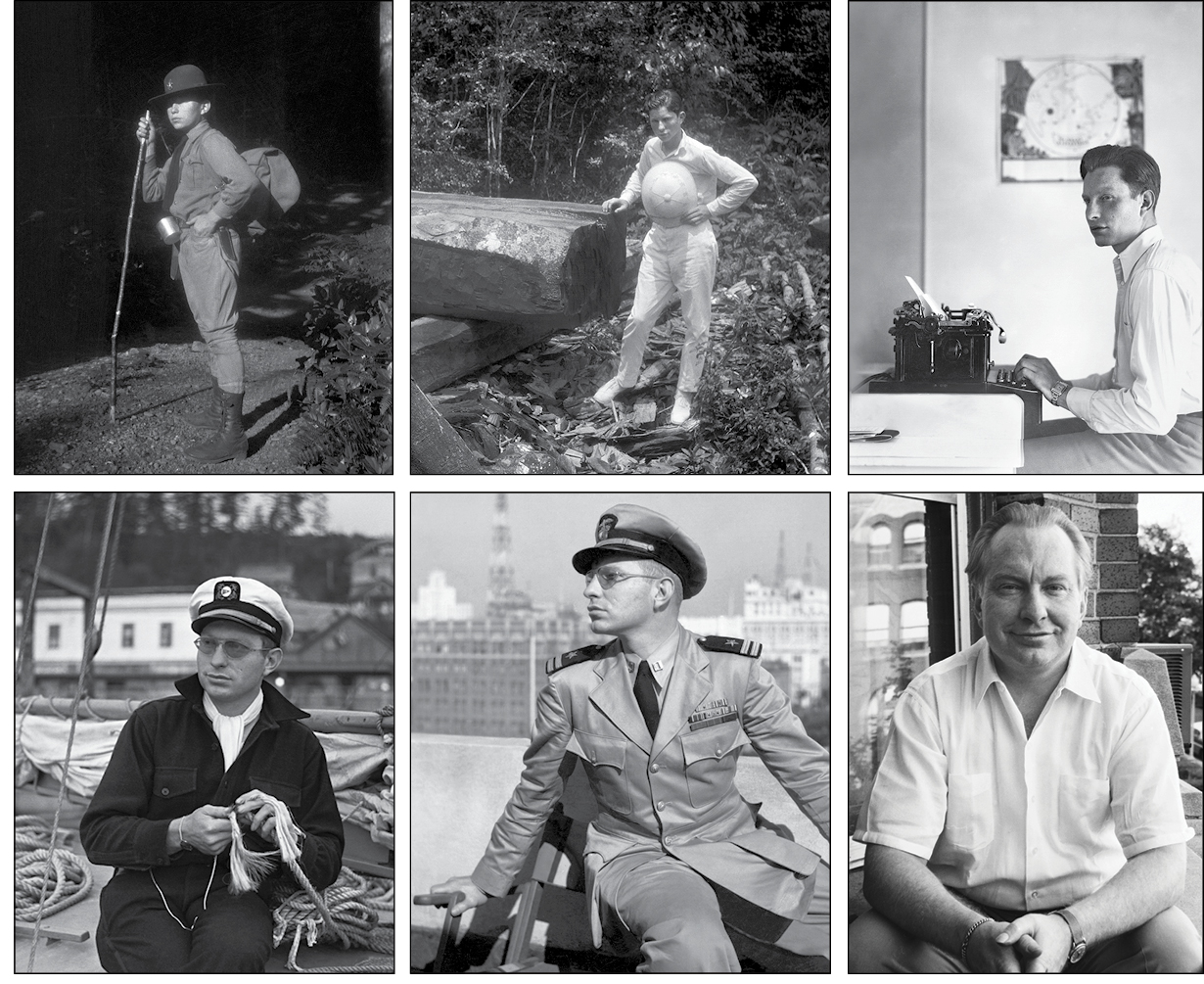



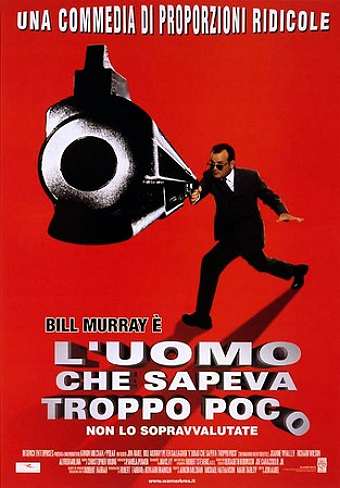
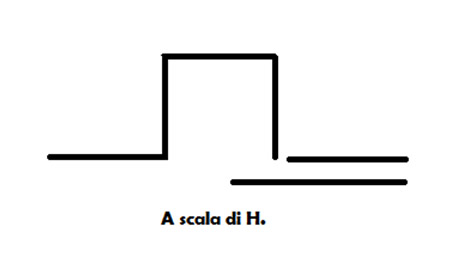


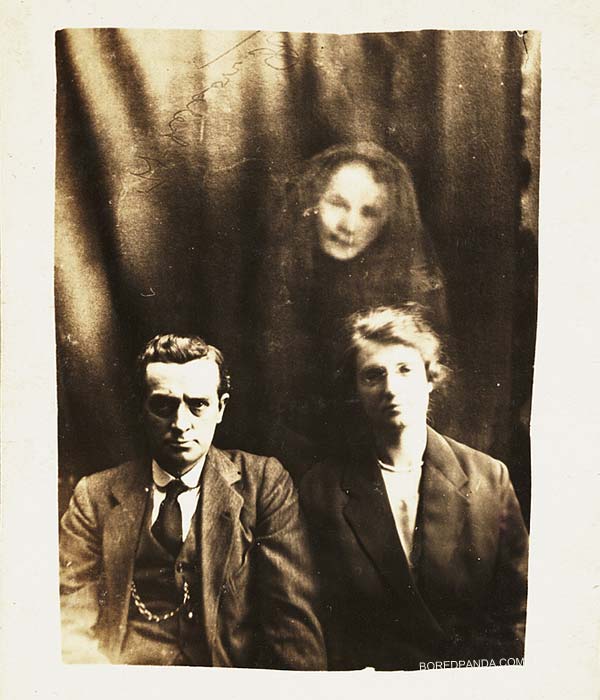



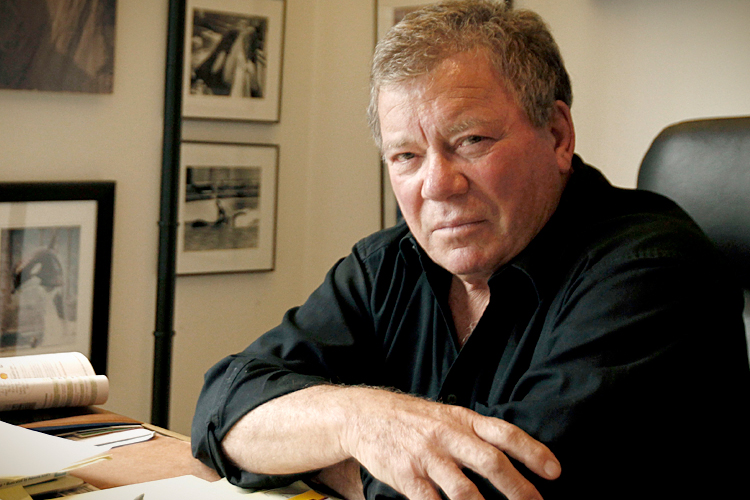
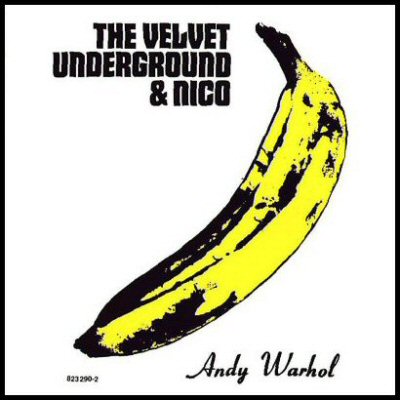
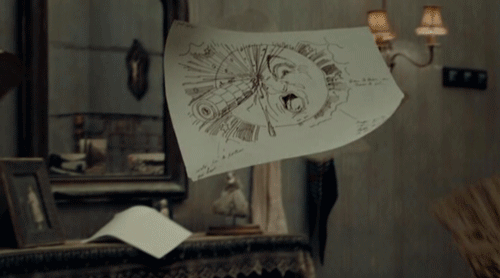


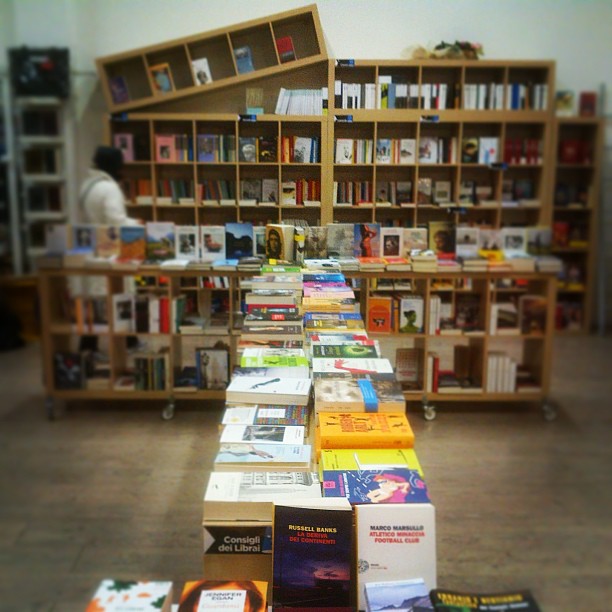



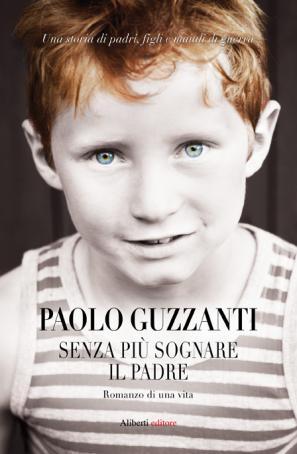


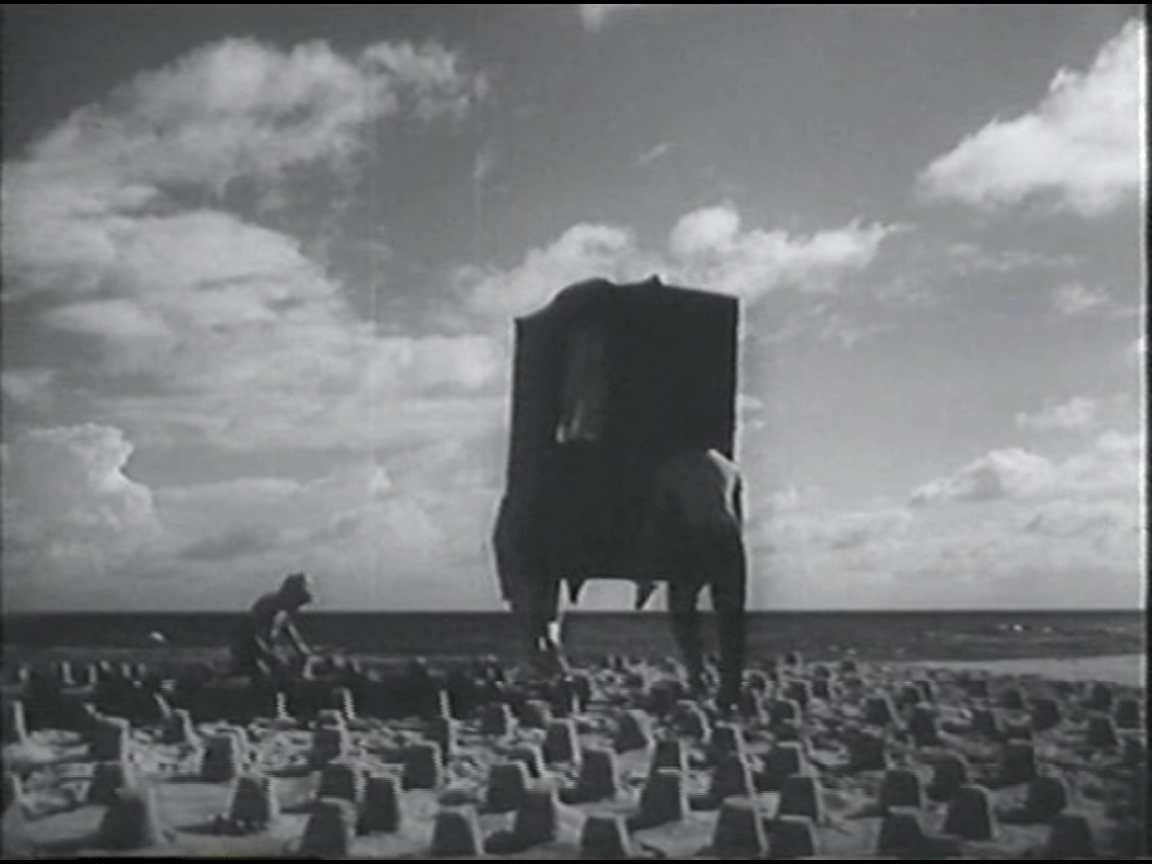






Grande racconto Giodo! Ti voglio bene!