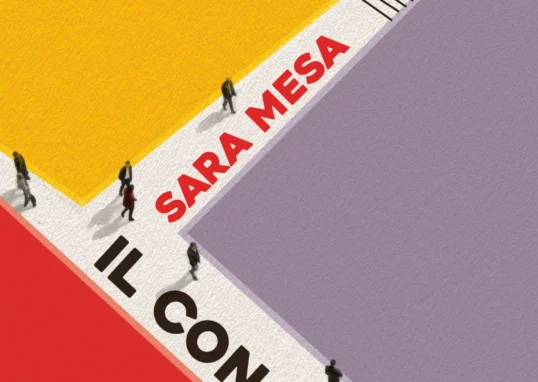Pubblichiamo un estratto dal saggio di Sabina Strings Fat Phobia, uscito per Mar dei Sargassi. Ringraziamo editore e autrice.
L’epidemia originale
Morire letteralmente di fame: pezzo grosso di New York stramazza alla vista del cibo. Perché?. Con questo titolo melodrammatico, se non addirittura bizzarro, l’edizione del New York Times del 16 febbraio 1894 pubblicava un articolo che si apriva così: “A New York, migliaia di donne e di uomini muoiono di fame pur avendo denaro sufficiente a permettersi prelibatezze!”. L’anonimo autore del pezzo proseguiva riportando le parole di quello che veniva definito un noto medico sulla condizione del benessere fisico e della dieta americana. Stando al dottore, la faccenda era gravissima: “Si stanno lasciando morire di fame, vi dico… lentamente, ma inesorabilmente”, affermava, specificando che, malgrado molti appartenessero alla media e alta borghesia, gli afflitti avessero un aspetto “emaciato [e] come segnato dalla consunzione” .
L’articolo metteva in risalto la profonda apprensione per la sana e robusta costituzione americana nel diciannovesimo secolo. Furono soprattutto i medici a darsi il tormento per le figure definite come pallide, macilente, spigolose, diffusesi, a loro detta, in tutto il paese. Più di uno descrisse con orrore “le casse toraciche rinsecchite, gli arti lunghi e smunti, i muscoli flaccidi e il passo malfermo [che] si incrociano a ogni angolo” . L’essere magri era, a quanto pare, da considerarsi al pari di un’epidemia.
In quegli anni, in cui si guardava ai corpi gracili come a un fallimento della società americana, i corpi femminili pallidi, deperiti e scarni destavano particolare preoccupazione. Allarmati dalla loro fragilità, stimati professori stilavano angoscianti programmi sul tema della loro debolezza. Ne sono un esempio gli scritti di uno stimato e prolifico medico del New England, il dottor William Alcott, parente alla lontana della celebre scrittrice Louisa.
In un trattato del 1885, The Young Woman’s Book of Health, Alcott lamentava il fatto che “i nostri figli, e tra loro le femmine, crescono in una comunità priva di autentico appetito” . Si raccomandava con gli americani di badare a quella che lui definiva “un’intera generazione di donne educate alla tenerezza, alla delicatezza, a soffrire di nervi, di fiacchezza e mancanza d’appetito” . Essere “alte, magre e delicate”, sosteneva, non avrebbe preparato le giovani alle circostanze della vita . Il dottor John Harvey Kellogg, avventista del settimo giorno noto, all’epoca, per il suo sanatorio di Battle Creek in Michigan ma non ancora celebre come produttore di cereali per la colazione, nella sua Ladies’ Guide in Health and Disease concludeva: “Soprattutto in questo paese, nelle città o nei piccoli centri, si riscontra di norma una significativa carenza dello sviluppo fisico nelle ragazze” . Il bel sesso americano avrebbe dovuto rivoluzionare la propria dieta, argomentava Kellogg, perché i corpi scheletrici e “da vespa” erano conseguenza delle loro pessime abitudini alimentari. Era più di una mera questione estetica o di salute . La magrezza, nelle giovani americane, era da considerarsi come minaccia alla nazione.
Un articolo datato 1888 del Washington Post dal titolo Le ragazze stanno rimpicciolendo? dichiarava: “La media per le ragazze oscilla tra i 63 kg e, in qualche caso, 36 kg o anche meno […]. Il dato per l’Inghilterra e la Germania è più alto […]. 36 kg di femminilità non bastano di certo”. Aggiungeva, poi, l’autore: “Le nostre signore continueranno a deperire e deperire ancora, fino a scomparire. È già accaduto a Boston. La stirpe americana […] non riesce a tenere testa allo straniero sostenuto da una solida impalcatura di ossa. Gli irlandesi hanno scacciato in gran numero gli yankee dal New England” . Il peso delle donne americane era, per molti, un pugno in faccia alla nazione. Si trattava, però, veramente di disinformazione in materia di alimentazione, come spesso veniva suggerito? Munite delle giuste informazioni, le donne avrebbero messo su carne e, dunque, ottenuto forza, salute, bellezza? Le prove suggeriscono il contrario. Molte donne benestanti provavano, invece, a restare magre proprio mentre i medici conducevano ripetuti attacchi alla magrezza in quanto malsana . Come osserva la storica Adele Clarke, le donne dell’alta società si lasciavano “sciupare con stile” . Dietro la moda slanciata, contrapposta al giudizio uniforme della medicina, dovevano chiaramente esserci altri fattori. Se in tanti consideravano la magrezza una pecca per l’America, fra i seguaci di quella moda l’essere magri era, bensì, indice di superiorità morale, patriottica ed etnica.
Tale tendenza è manifestamente riscontrabile nell’articolo di Harper’s Bazaar del 1896 intitolato Le nostre donne sono scheletriche?, che comincia con una riflessione sui corpi esili: “È tuttora opinione comune che le americane siano ossute e giallastre”. L’anonimo artefice dell’articolo contesta questa credenza con l’argomentazione che, anche se le donne più povere potevano essere considerate malnutrite, pochissime tra le appartenenti alle classi agiate erano talmente magre da risultare aguzze come le loro antenate. Oggi , prosegue convinto l’autore, sulle gote delle donne c’è “un roseo colorito uniforme” e più carne sulle ossa, tutte prove del “successo pieno e impareggiabile” dell’esperimento americano .
Nonostante esalti la rinnovata e lodevole “rotondità” nella silhouette delle signorine moderne, l’autore tradisce la preferenza per un tradizionale fisico americano esile. Dei mutevoli profili femminili, scrive: “Non si sfugge alla constatazione, nelle assemblee metropolitane, che la leggiadria e la flessuosità femminili che resero nota la repubblica siano ormai in declino e che su di essa incomba l’estremo opposto” . È significativo che si descriva la grassezza come “incombente”. L’autore restituisce il sentore della premonizione legata all’eccesso di peso. La corpulenza, a quanto pare, oltre ad attentare all’identità estetica del paese, richiama alla memoria le cattive abitudini alimentari e l’immoralità dell’élite europea. Ancor più grave, i corpi estremamente grassi o “gonfi” vengono accostati ai primitivi provenienti dall’Africa .
L’autore scandisce per filo e per segno al suo lettore: “Il corpo robusto, corpulento, strabordante” non è mai desiderabile “tranne che per i selvaggi d’Africa”. Ciò solleva parecchie questioni. Anzitutto, cosa spinse qualche americano benestante a credere che i corpi magri, specie se femminili, fossero preferibili da un punto di vista estetico e costituissero, allo stesso tempo, un simbolo dell’identità nazionale? Come ha fatto il grasso a divenire segno di corruzione? Come si è stabilito il nesso tra grasso e “africanità”, tra grasso e l’essere nero? Infine, se l’establishment medico del secolo precedente aveva temuto le figure esili delle donne (dell’élite bianca), come e quando cominciò a considerare il grasso, soprattutto nelle donne nere, la più grande minaccia alla salute pubblica, come avrebbe fatto tra la fine del ventesimo e l’inizio del ventunesimo secolo con “l’epidemia di obesità”?
Nel presente libro analizzo la storia e il retaggio della propensione per i corpi magri e dell’avversione per i corpi grassi, prestando particolare attenzione alle contingenze di genere, classe, etnia e salute. Questo testo si inserisce nel dibattito decennale sulla predilezione per la magrezza e la grassofobia statunitensi. Una grossa parte del dibattito verte sull’enfasi posta sulla magrezza “femminile” . Sebbene la maggioranza degli autori dimostri che l’avversione per il grasso e il favore per la magrezza appaiano con più evidenza tra le donne benestanti e bianche, in pochi si sono soffermati sul ruolo giocato dal ceto e dall’etnia nello sviluppo di tali tendenze. Sull’argomento è stato dimostrato che la grassofobia prende di mira solitamente le donne di colore, in particolare le donne nere , con un reddito basso. Altre studiose, come Sander Gilman, Jennifer Morgan e Janell Hobson, hanno mostrato come i corpi delle donne nere siano stati a lungo trattati come “eccesso” .
Eppure, ancora in pochi si sono azzardati a spiegare come il grasso sia stato storicamente associato al colore nero della pelle. Fat Shame, libro del 2011 di Amy Farrell, spicca per aver evidenziato il passato razzista condiviso dallo stigma della grassezza e dall’ideale di magrezza. Il volume non si addentra, tuttavia, nello sviluppo di tali connotazioni razziste e neppure spiega la centralità, al loro interno, del rifiuto del nero. Dalla letteratura esistente si apprende, inoltre, pochissimo sul ruolo della morale. Il fondamentale Born Again Bodies: Flesh and Spirit in American Christianity di R. Marie Griffith (2004) risplende, in questo senso, per il suo avvincente approfondimento degli ammonimenti cristiani contro l’ingordigia e la grassezza.
Malgrado ciò, pur avendo svelato che, nel corso del diciannovesimo secolo, i corpi atletici venivano usati per consolidare le pretese di superiorità della razza, il modo in cui queste relazioni abbiano potuto svilupparsi e poi essere divulgate nel pensiero americano resta una domanda aperta. Il presente lavoro prende le mosse dai molti studi esistenti poiché fornisce una storiografia dei bias a favore della magrezza e grassofobici. In altre parole, mentre studi disparati si sono soffermati sugli antefatti storici dietro i nostri preconcetti odierni sulla taglia del corpo, nessuno, per quanto ne sappia, ha intrapreso un’analisi che prenda in esame le figure coinvolte nel loro diffondersi o i fattori politici e socio-culturali che contribuirono al loro rafforzarsi. Questo libro si riferisce a questa lacuna come primo plausibile studio sulla storia della grassofobia e sul feticismo occidentale per la magrezza, con enfasi sulle questioni interrelate di genere, etnia e morale coinvolte nel loro avanzamento.
Secondo la mia argomentazione, sono due gli avvicendamenti storici e critici che hanno contribuito alla feticizzazione dei corpi snelli e alla fobia di quelli grassi: il successo della tratta transatlantica degli schiavi e la diffusione del protestantesimo. La retorica scientifica della schiavitù legata alla razza tracciava un nesso tra grasso e “ingordigia” africana. La religione, poi, dissertava sull’empietà del mangiare troppo.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente