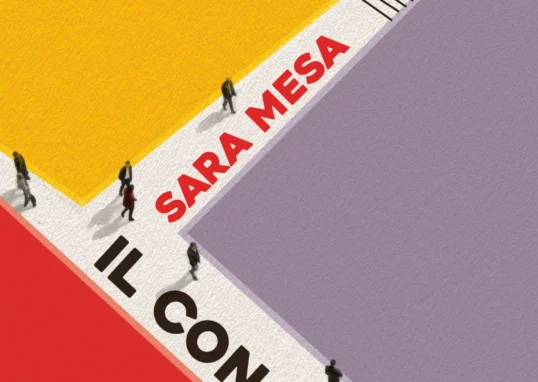Merce comunicativa, non catechismo etico
di Paolo Landi
È evidente che quando si parla di Oliviero Toscani, non si può ridurre il suo apporto al mondo della comunicazione al solo ruolo di fotografo. Toscani è stato – e resta – una figura centrale nella costruzione dell’identità visiva e valoriale di Benetton, quando era uno dei brand italiani più noti al mondo, in classifica con Coca Cola e Nike. Ma quella stagione – colta, industriale, politica – ha oggi il sapore del passato: la radicalità di Oliviero, così come l’umanesimo industriale olivettiano, appaiono irreali o comunque irrilevanti nella comunicazione contemporanea, dominata dagli algoritmi, da estetiche intercambiabili e da retorica vuote. Ma, mi pare, proprio in questa apparente inattualità risiede la forza di Olivetti e Toscani, che sono invece ancora in grado di parlarci: ambedue hanno saputo usare la pubblicità come un linguaggio culturale e non solo come strumento di persuasione. In un mondo che ha normalizzato una sorta di cinismo comunicativo, ricordare queste esperienze è un atto critico, il contrario della nostalgia. La collaborazione tra Toscani e Benetton ha rappresentato molto più di una semplice campagna pubblicitaria. È stata una rivoluzione del linguaggio pubblicitario, una strategia di posizionamento radicale che ha trasformato la pubblicità di una marca di abbigliamento in un mezzo per veicolare messaggi sociali, politici e culturali in un momento in cui il mercato globale stava cambiando: i consumatori non cercavano più soltanto un prodotto, ma un’identità, una visione del mondo con cui identificarsi. In questo contesto, Toscani ha capito prima di molti che il brand doveva smettere di parlare solo di sé stesso per diventare parte attiva di una conversazione sociale più ampia. La comunicazione “non convenzionale”, in cui l’abbigliamento quasi sparisce dalle immagini, lasciando spazio a temi dirompenti: il razzismo, l’aids, la guerra, l’immigrazione, la pena di morte; una scelta, apparentemente azzardata, che era in realtà frutto di una strategia precisa. Grazie a Toscani, Benetton è diventato un caso unico di “brand activism” ante litteram. Molto prima che i marchi iniziassero a sposare cause sociali come strategia di marketing, Toscani aveva già intuito che un marchio globale poteva – e doveva – prendere posizione. La coerenza della visione, la forza delle immagini, l’internazionalità dei temi trattati hanno reso Benetton un brand riconoscibile, con una voce propria, inconfondibile. In un’epoca in cui l’identità di marca era spesso costruita su concetti astratti come “qualità” o “stile”, Benetton comunicava idee, valori, posizioni etiche attraverso una scelta di stile esteticamente mirabile, e anche questo aspetto ha la sua rilevanza. Visivamente, la comunicazione di Toscani era molto semplice: fondi bianchi, soggetti centrali, il logo dell’azienda sempre a destra, posizionato precisamente a metà del layout. Toscani riteneva il lavoro grafico sull’immagine fondamentale e collaborò per lunghi anni con Salvatore Gregorietti. A un certo punto affidò a Massimo Vignelli (1931-2014), celebre per aver realizzato la pianta della metropolitana di New York, il compito di realizzare una sorta di “bibbia” che mettesse ordine nei numerosi marchi dei licenziatari Benetton. Ma Vignelli era molto distante dal concetto di pubblicità come la intendeva Oliviero e la collaborazione, a lavoro ultimato, si chiuse. Da un lato, il brand veniva costantemente associato a tematiche urgenti e attuali; dall’altro, si imponeva nella memoria collettiva in modo indelebile. Toscani credeva profondamente nel potere della comunicazione come forma di impegno civile. Per lui, un marchio aveva la responsabilità di usare la propria visibilità per stimolare il pensiero critico, per dare voce agli esclusi, per abbattere stereotipi. Questo approccio ha fatto scuola, influenzando generazioni di pubblicitari e cambiando per sempre il modo di intendere il rapporto tra azienda e società. Certo, questo tipo di comunicazione non è stato privo di rischi. Le polemiche frequenti, le critiche dai media, persino le azioni legali, hanno accompagnato molte delle campagne di Toscani. Eppure, è innegabile che Benetton abbia tratto enormi benefici in termini di notorietà, differenziazione e posizionamento competitivo. Ancora oggi, il brand è identificato con quella stagione creativa e coraggiosa, più che con qualsiasi prodotto specifico. Oliviero non è stato solo il fotografo di Benetton: è stato l’architetto di una visione, l’autore di un linguaggio nuovo, il regista di una strategia che ha trasformato la pubblicità in una piattaforma culturale. La sua opera con Benetton ha segnato una svolta epocale. Ma quando la pubblicità, come nel caso di Toscani, smette di essere un semplice strumento al servizio del prodotto (magliette, maglioni, accessori), e diventa un contenuto autonomo, deliberatamente creato per generare valore in sé, come se fosse un altro bene da consumare, cosa accade? In pratica, Toscani non si limitava a illustrare ciò che Benetton vendeva: creava immagini forti, cariche di significato, che diventavano esse stesse oggetti culturali, discusse nei telegiornali, esposte nei musei, analizzate nei corsi universitari. Abbiamo visto che questa trasformazione ha due conseguenze fondamentali: la pubblicità diventa linguaggio e identità del brand; Benetton smetteva di vendere semplicemente vestiti, vendeva un’immagine del mondo, un certo tipo di sensibilità. Le campagne diventavano parte integrante dell’offerta del marchio: per acquistare Benetton, in un certo senso, bisognava accettarne il messaggio, condividerne la visione. Questo rendeva la comunicazione non più accessoria, ma centrale nel posizionamento del brand. Una critica di «Le Monde Diplomatique», uscita in quegli anni, ci fece molto riflettere: il giornalista Pierre Guislain si chiedeva se fosse da augurarsi che le imprese cominciassero a destinare i loro budget milionari a sostenere cause sociali. Perché – era la domanda scomoda – cosa accadrebbe se qualcuno impiegasse il suo budget non per fare pubblicità contro il razzismo, ma per fomentarlo? Se invece di attirare simpatia verso i migranti la pubblicità li additasse come portatori dei peggiori mali? Alcuni critici di Toscani ne mettevano in evidenza “il moralismo pubblicitario”, una sorta di paternalismo attraverso il quale l’azienda “educa” il consumatore, gli dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma Toscani non predicava: non offriva soluzioni, non proponeva modelli comportamentali. Mostrava la realtà in modo crudo e a volte sgradevole, suscitando disagio, non approvazione. In questo modo, evitava di collocarsi su un piedistallo morale. Non diceva “guarda come siamo bravi”, ma piuttosto: “guarda cosa succede nel mondo”. Spettava al pubblico reagire. La sua ultima campagna, per esempio, quella dei condannati a morte, non era, a ben vedere, una campagna “contro” la pena di morte, era una campagna “sulla” pena di morte: guardando quegli undici ritratti (tra cui quello di Jerome Mallet, che fu giustiziato pochi mesi dopo essere stato fotografato) qualcuno poteva dire: “Giusto friggerli sulla sedia elettrica, questi assassini”, qualcun altro: “Scandaloso che uno stato democratico si faccia assassino alla stessa stregua di chi ha ucciso”. Quella di Toscani era merce comunicativa, non catechismo etico.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente