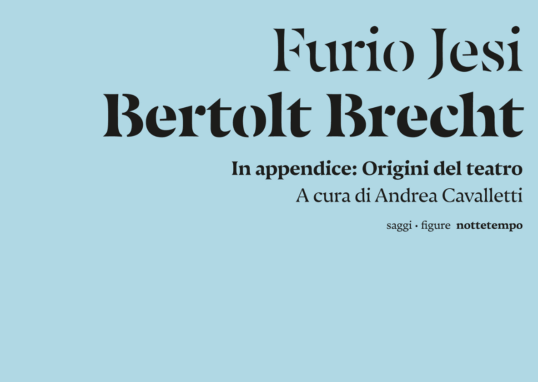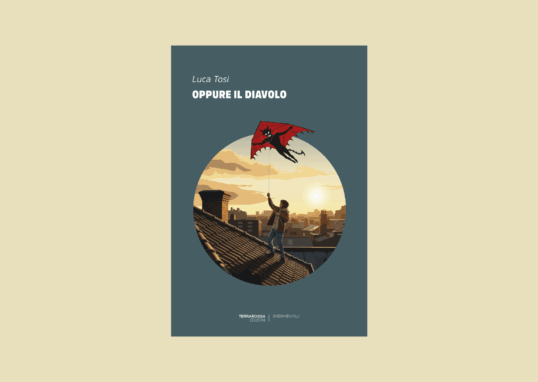Pubblichiamo un estratto da “UPPA. Cronache groenlandesi” di Piergiorgio Casotti, pubblicato da Italo Svevo nella collana Biblioteca di Letteratura Inutile.
*
La notizia è di ieri. Un iceberg grande settanta volte Manhattan si è staccato dalla calotta antartica ed è alla deriva nel mare di Weddell. Nome scientifico, A-76.
Quasi istintivamente, come un richiamo a cui è impossibile disobbedire, entro nella stanza in cui tengo archiviati i miei progetti passati: una fila di scatole di cartone riciclato, tutte dello stesso tipo e colore, allineate su un ripiano della libreria. Ne cerco una in particolare sulla cui etichetta, scritta con pennarello blu, si può leggere la sigla GR. Mi siedo, un respiro profondo: i viaggi a ritroso nel tempo non sempre sono strade che si percorrono incolumi.
Il contenuto è ancora ordinato. In cima ritrovo una collanina fatta con la mascella di una balena e alcune polaroid tenute assieme da un elastico giallo rinsecchito. Ritratti di amici lontani. Ai lati, impilate, due buste di carta rinforzate, poi tre quaderni per gli appunti infilati negli angoli e molti fogli. Su alcuni ci sono nomi scarabocchiati, annotazioni prese di fretta. All’interno di uno dei quaderni, scritti in rosso, numeri probabilmente telefonici sembrano codici nucleari. Sfogliando scopro altri appunti, disegni e liste barrate di cose da fare e intenzioni. Alcune pagine sono state strappate. Nel mezzo un fiorellino secco e schiacciato che ha mantenuto il suo intenso colore viola. A fianco, appuntato su una pagina vuota, commestibile-tè.
Nelle buste di carta conservo i blocchetti di fotografie in bianco e nero. Provini, un centinaio di immagini non più grandi di un pacchetto di sigarette. Sono quello che stavo cercando. Le sfoglio e le ordino secondo una logica improvvisata sul momento. Nel farlo cresce la consapevolezza che ognuna di quelle immagini porta con sé qualcosa che va oltre la sua rappresentazione statica. La documentazione di un luogo scordato da Dio ma al centro del mondo, oggi più che mai. Se solo riuscissi a ordinare le idee, ne avrei di cose da raccontare su quel che ho visto e vissuto da quelle parti.
GR sta per Groenlandia.
Nel mio caso, Groenlandia dell’Est.
\
\
\
Michael è di ritorno con un carico di birre. Tra poco arriveranno anche Kasper, Jimmy con la sua fidanzata Martha e qualcun altro, forse Albert. Li aspetto sdraiato sul divano della sala. È sabato pomeriggio. Con me ci sono Hilda e un’altra ragazza che non ho mai incontrato prima. Hilda era uno di quei tanti corpi abbandonati sul divano di Michael, quella sera di qualche mese fa. Nessuna delle due parla inglese, ma come al solito cerco di fare un minimo di conversazione attraverso gesti coordinati di faccia e mani.
Hilda scarabocchia qualcosa su un foglio di carta. Si gira verso di me, sorride e mi mostra la mano destra come per giustificare l’uso della mancina. La mano è rattrappita, le dita rigide e contratte. Non l’avevo notato. Poliomielite o qualcosa del genere? Con un gesto della testa le faccio intendere che non capisco. Hilda, di tutta risposta, forma una pistola con la mano buona, punta la sua spalla destra e dalla bocca esce il rumore di uno sparo. Puf. Vuole essere sicura che abbia capito, così si toglie felpa e maglietta e rimane in reggiseno. Lì dove puntava la pistola un’enorme cicatrice tonda, larga come un pugno, mi travolge lo sguardo. Il muscolo è assente, sostituito da una rientranza che ricorda una depressione terrestre. Sotto quella pelle stiracchiata e incartapecorita doveva esserci un bel buco. Scuoto la testa. Le chiedo dove è successo, e quando. Indica fuori dalla finestra in direzione del porto e con le dita delle mani compone il numero venti: a vent’anni. Si siede sul divano e carica un fucile immaginario che si punta sotto la gola. Poi fa il gesto dell’elica di un elicottero con l’indice della mano, lei che si spaventa e il fucile che scivola di lato. Reykjavík, mi dice, mimando contemporaneamente un aereo. Si toglie i pantaloni. Una lunga cicatrice le attraversa l’interno della coscia sinistra: una spessa e fibrosa linea rosa che dall’inguine scende fino al ginocchio. Le hanno prelevato un tendine per salvare il braccio. I am sorry, le dico. It’s ok, mi risponde sorridendo. Crazy. Con Google Translate mi dice di andare a casa sua. House, father, mother, son. Domani, forse.
Scopro che Hilda abita a pochi metri da Ole, qualche casa più giù. L’interno dell’appartamento è minuscolo e spoglio di tutto. Quel poco che vedo sembra ciò che resta di un trasloco. Roba vecchia, inutile, da lasciarsi alle spalle. Su un lato della sala ci sono un divano a due posti, due sedie e una vetrinetta di legno compensato con una piccola televisione a tubo catodico appoggiata su una mensola. Nessun soprammobile, nessuna fotografia, nessun bicchiere, nessun fiore finto. Niente di niente. Né sulla vetrinetta né sui davanzali. L’altra metà della stanza è sgombra. Ci sono soltanto due materassini appoggiati al muro, ancora ricoperti dalle lenzuola. Anche le pareti sono spoglie. In questa casa abitano Hilda e suo figlio, il fratello, la madre e il padre. I genitori dormono in questa stanza.
Sbircio nella cucina. Alcune persone sono raccolte attorno a un tavolinetto basso. Parlano e ridono, forse giocano a carte, protetti da una cortina di fumo troppo compatta per essere penetrata dallo sguardo. L’odore che mi arriva è quello di hashish. Dalla sala Hilda scuote la testa sorridendo, non devo entrare, poi si fa scivolare sul divano, raccoglie una chitarra e inizia a cantare a mezza voce al ritmo di due accordi. Lì vicino, il figlio nudo gira in tondo strisciando sul pavimento. Anche lei ha un quaderno sul quale scrive le sue canzoni. Un quaderno anonimo con una copertina rossa che tiene appoggiato sul tavolino. Invita il figlio sul divano. Lui si avvicina. Hilda lo abbraccia, lo bacia ripetutamente sulle guance e lo stringe ancora. Ride di gioia.
Gli ospiti se ne sono andati da poco e Hilda mi accompagna in cucina per conoscere i genitori. Sono seduti vicino alla finestra, illuminati dalla luce esterna. La testa china del padre è nelle mani della moglie, la quale fruga minuziosamente tra i suoi capelli. Sembrano anziani ma avranno poco più di cinquant’anni. Isortoq, dice Hilda. Mi sorridono senza rompere il loro incastro. Hilda apre il frigorifero, che è vuoto. Si tocca lo stomaco con la mano. Google mi dice che andranno (andremo) tutti a pesca tra poco.
Oggi il luogo prescelto è il centro del fiordo, a qualche centinaio di metri dal molo. Mentre mi avvicino, sono catapultato in una California ricoperta di ghiaccio, alle trivelle petrolifere che scorrono lente ai lati delle sue autostrade abbaglianti. Un su e giù stanco, un moto perenne. Tale è l’immagine di quelle figure scure, immobili su uno sfondo monocromo, che sollevano e abbassano l’avambraccio in movimenti controllati e mai eccessivi.
I pescatori già presenti sono sparsi su una vasta area e ben distanziati l’uno dall’altro. Alcuni di loro sono in piedi vicino alla linea di confine tra lo spesso strato di ghiaccio bianco su cui poggio i piedi e un altro grigio e pericolosamente cedevole, il grease ice. Pescano o maneggiano gomitoli di filo trasparente con lo sguardo rivolto all’oceano. Nessuno parla. Molti lavorano a mani nude, hanno i guanti appoggiati su un secchio o sul pianale della slitta al loro fianco, una sigaretta in bocca e una nuvola che si irrigidisce all’istante di fronte agli occhi. Rimaniamo poco più di un’ora e rientriamo con due sacchetti neri pieni fino all’orlo.
Resto per la notte.
\
\
\
La notizia del suicidio di Peter mi ha sconvolto. Tutto ciò che credevo di aver appreso in questo mio tempo groenlandese sta vacillando, è al punto di rottura. Le ipotesi, le congetture, i dubbi, le certezze (poche) che mi ero portato in Italia, tutto quanto, si reggevano su esperienze spurie e parziali. Mi rendo conto che in questi anni ho affrontato il suicidio soltanto attraverso i suoi superstiti o per interposta persona. Le cose sono diverse, ora che ho perso un amico.
Decido di andare a visitare la sua tomba. La valle sta cambiando pelle. Un fitto manto verde e i primi fiori stanno ricoprendo le zone umide attraversate dal torrente che scende dal lago. Nel tratto che lambisce il cimitero due ragazzini sguazzano nell’acqua poco profonda. Mi fermo a osservarli con stupore e invidia per la loro capacità di resistere al freddo. Rimangono immersi per un tempo infinito. Il più basso ha una maschera da subacqueo appiccicata alla faccia e un tubo per respirare. Ogni tanto si immerge e gira la testa a sinistra e a destra. A volte allarga le braccia a forma di semicerchio e scuote l’acqua con le mani. A pochi metri da lui, contro corrente, l’amico tiene in mano un retino da pesca per catturare i pesci che il subacqueo indirizza nella sua direzione. Nelle emergenze tenta di bloccarli a mani nude. Mi avvicino a loro. I due ragazzi escono gemendo. Tremano. Poi si avvolgono in teli di cotone e iniziano a ridere.
Anche il cimitero sembra riemerso dal letargo. Sulle tombe sono posate corone floreali di plastica dai colori sgargianti. Una ode silenziosa alla vita e alla luce ritrovata. Ce ne sono molte disseminate in ogni direzione. Si fondono meravigliosamente con i colori della valle. Su alcune tombe i fiori sono arrugginiti e spezzati, le loro croci sbilenche e consumate. Passo al setaccio ogni metro quadrato del cimitero ma non riesco a trovare Peter. Lo spazio è anonimo. Potrei chiedere indicazioni al fratello o a qualche amico, ma decido di rispettare l’oblio. Una cosa, però, decido di fare, e mi incammino verso la stazione di polizia. Voglio chiedere informazioni su quanto accaduto a Peter lo scorso autunno.
Ricordo ancora l’ultimo giorno in cui ho visto Peter vivo. La mattina del 30 luglio, l’ultimo giorno a Tasiilaq prima del mio rientro in Italia. Era la tipica giornata estiva groenlandese. Indossavo un pile da montagna nero che non impediva al sole di intiepidire il mio corpo. La luce era brillante e dava alle cose un contrasto ricco di organicità. Ero con Kaale fuori dal Pilersuisoq grande, una sosta abitudinaria durante le nostre passeggiate infinite e senza meta. Peter mi chiama da dietro le spalle. È con la sua fidanzata, sono circondati da sacchetti gonfi di provviste. Stanno aspettando un taxi per tornare a casa. Lui si avvicina e mi offre di andare con loro. Rifiuto e lo informo che partirò il giorno seguente. Peter si gira verso la fidanzata rimasta indietro. Un rapido sguardo, oggi direi d’intesa, poi si rivolge di nuovo a me con un gran sorriso e mi dice che ha una bella notizia: diventerà padre.
Quel giorno e i fatti che sarebbero poi accaduti nei mesi successivi (allora non potevo prevederlo) avrebbero rappresentato uno spartiacque nella mia vita groenlandese e segnato le fasi finali del mio lavoro fotografico. Sarebbe esistito un prima e un dopo, un nuovo calendario, forse un nuovo modo di percepire e interpretare il tempo e gli accadimenti, i rapporti umani. A un anno di distanza, al mio ritorno a Tasiilaq di inizio estate, Kaale e Ulla sarebbero già andati in Danimarca, per non tornare mai più. Kaale avrebbe continuato gli studi, Ulla si sarebbe ricongiunta con la madre a Copenaghen senza prospettive chiare sul suo futuro. Iluna sarebbe rimasta incinta e con la famiglia avrebbe pianificato di trasferirsi a Aalborg, in Danimarca. Di Kista non avrei più avuto alcuna notizia mentre Nuka se ne sarebbe andata a Qaqortoq per studiare alla efterskole. In quell’anno a venire molti dei miei amici sarebbero diventati grandi, alcuni sarebbero scomparsi e con loro anche il tempo della spensieratezza di un’intera generazione (e la mia). In Groenlandia i diciotto anni segnano il punto di svolta. Il luogo in cui ti trovi dopo quel giorno marchierà il corso della tua vita in modo indelebile.
If u grow up here and have no exceptional talent… it’s a tough life.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente