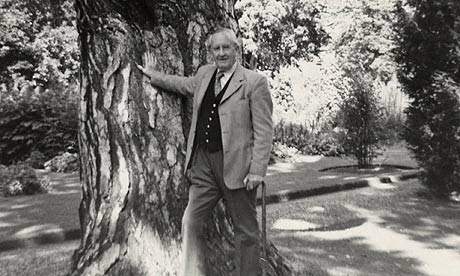
Ritto sull’orlo, come un nuotatore pronto a tuffarsi, c’era il buon uomo. Ma non era il buon uomo che si aspettava Lucy, ed era solo. George si era girato al rumore del suo arrivo. Per un attimo la contemplò, come se fosse una creatura caduta dal cielo. Vide la gioia radiosa della sua faccia, vide i fiori lambire come onde azzurre il suo vestito. I cespugli sopra di loro si richiusero. George si avvicinò rapidamente…
E. M. Forster, Camera con vista
I. Come chiameremo le nostre nature
Poesia e profezia sono l’ombra che futuro e passato gettano assieme sovrapposti sul presente. Per prima cosa, dunque, una poesia:
Consiglio a un profeta
di Richard Wilbur
Quando verrai, come presto dovrai, nelle strade della nostra città,
folli gli occhi ad affermare l’ovvio,
Non proclamando la nostra caduta ma implorandoci
In nome di Dio di commiserare noi stessi,
Risparmiaci qualsiasi parola sulle armi, la loro forza e portata,
I lunghi numeri che fanno balzare la mente;
I nostri cuori lenti e sconsiderati saranno lasciati indietro,
Incapaci a temere ciò che è troppo strano.
Né ci spaventerai con discorsi sulla morte della razza.
Come potremmo sognare questo posto senza di noi? —
Il sole è solo fuoco, le foglie imperturbabili intorno a noi,
Uno sguardo di pietra sul volto della pietra?
Parla del cambiamento del mondo stesso. Sebbene non possiamo concepire
una cosa inimmaginabile, sappiamo a nostre spese
come la nuvola sognata si sgretola, le viti sono annerite dal gelo,
come muta la vista. Potremmo credere,
se ce lo dicessi, che il cervo dalla coda bianca scivolerà
in un’ombra perfetta, divenuto compiutamente schivo,
l’allodola eviterà la portata del nostro sguardo,
il pino si scioglierà
sulla fredda sporgenza, e ogni torrente brucerà
come un tempo Xanto, la sua trota guizzante
stordita in un batter d’occhio. Cosa dovremmo essere senza
la parabola del delfino, il ritorno della colomba,
queste cose in cui abbiamo visto noi stessi e parlato?
Domandaci, profeta, come chiameremo
Le nostre nature quando quella lingua viva sarà tutta
Dispersa, quel vetro oscurato o infranto
In cui abbiamo detto la rosa del nostro amore e il limpido
Cavallo del nostro coraggio, in cui abbiamo visto
La locusta canora dell’anima sgusciata,
E tutto ciò che intendiamo o desideriamo dire.
Domandaci, domandaci se con la rosa senza mondo
I nostri cuori ci deluderanno; vieni a domandare
Se ci sarà un’altezza o una lunga durata
Quando gli annali di bronzo della quercia si chiuderanno.
Non so nemmeno se poter definire questo intervento coerente, strutturato o semplicemente la comunicazione-forse niente altro che lo sfogo- per una urgenza avvertita a partire da una dinamica narrativa. Temo sia percorso da una certa vena insopportabilmente omiletica, ma questo forse è anche dovuto in parte a due delle voci che intendo farvi dialogare con Tolkien e, nello specifico, con l’inizio e la conclusione, per così dire, dell’incontro di Merry e Pippin con Barbalbero l’Ent, ossia il romanziere-poeta-contadino Wendell Berry, autore di “Jayber Crow” e “Manifesto del contadino impazzito” e il pastore protestante Eugene Peterson, che ritradusse la Bibbia in americano contemporaneo in quel classico moderno che è “The Message” e nella sua altrettanto vasta produzione ha offerto autentiche gemme come “Eat this book” che cita un altro Inkling, il C. S. Lewis di “An experiment on criticism” quale uno dei grandi maestri novecenteschi dell’autentica arte del leggere, al pari di Steiner o Barth. E anche del leggere vorrei provare a parlare.
Siamo su un crinale difficile, ritengo questo lo si possa affermare senza timore di smentita e senza che questo debba farmi intruppare nella schiera dei laudatores temporis acti, sotto la pressione degli strumenti della società di comunicazione di massa che minacciano di schiacciare così tanto della natura stessa dell’esperienza culturale e artistica, ossia anche, inevitabilmente, delle basi di ogni comunicazione autentica, giacché la poesia è, come spero di mostrare un poco, il linguaggio stesso dell’intimità, dell’approssimarsi e coinvolgerci col mondo e ciò e chi lo abita.
Storie e poesia aiutano proprio a recuperare questa dimensione, senza dichiarazioni programmatiche, immettendoci in essa, semplicemente facendoci accorgere di quanto sta già accadendo in noi. Per questo in esergo ho citato la scena dal romanzo di Forster in cui i due protagonisti si guardano da lontano e poi colmano quella distanza con un movimento fisico, giacché è proprio tale esperienza che oggi viene distorta e smussata da quegli stessi mezzi che parrebbero amplificarla. Niente di nuovo, probabilmente ogni epoca non fa che fronteggiare le medesime sfide come se fossero ultime e apocalittiche, certo è che, come direbbe Gandalf questo è il nostro tempo e questo è il male o parte del male del nostro mondo. Si tratta di realtà-più ancora che tematiche- così importanti e dalle implicazioni ramificate, che per molti anche qui presenti -suppongo- costituiscono il fulcro della propria vita emotiva e immaginativa, per quanto al riguardo oggi ci si possa sorprendere, senza neppure sapere bene come, a una sorta crocevia con troppe direzioni e che nel subissarsi di immagini e informazioni conduce solo a una sorta di inerzia paralizzante e angosciata, come sotto lo sguardo del basilisco, comunque sterile.
Parole, immagini, storie, le esperienze a esse connesse, come Fantasia, Racconto, Mito, sono oggi sottoposte una duplice riduzione, quella di chi “ a destra” le imbraccia e le brandisce per usarle contro qualcun altro per difendere privilegi più o meno espliciti, per arroccarsi nella protezione della propria misura sul mondo, una visione che in realtà della dinamica profonda di quelle parole-esperienze non sa che farsene, e quella di chi “a sinistra” al massimo ne fa un gradevole orpello brandizzato, ennesima parte del medesimo orizzonte consumistico che in fondo ne rigetta a sua volta il moto e le implicazioni più autentiche.
Io invece vorrei provare a ripercorrere una dinamica immaginativa di Tolkien- in uno di quelli che poi sono diventati gli emblemi della sua specificità, del quid che egli ha aggiunto al panorama collettivo, ossia l’incontro con gli Ent. Ciò proprio per affrontare quelle due riduzioni solo apparentemente opposte, nella convinzione già espressa da E. M Forster che la tradizione autentica sia la capacità di parlare con gli antenati, non di parlare al posto loro, non di ripetere ciò che forse hanno detto ma di parlare con loro, qui e oggi. Tuttavia per arrivare agli Ent occorre fare un lungo passo indietro. Non avere fretta, ci esorterebbero loro. Fretta e indolenza sono due facce della stessa medaglia, opposto della attività creatrice, del movimento autentico.
II. Disse-Vide
Nella Genesi Dio dice e poi vede. Solo a Lui è possibile. La parola precede, per così dire, la visione, con la quale si scandisce fase per fase nei vari giorni il compiacimento dell’Autore che rimira quanto compiuto come un artigiano soppesa una sedia o maneggia una spada. E Dio vide che era cosa buona.
Sarebbe suggestivo tracciare un percorso discendente sui ritratti d’artista che in Tolkien da Iluvatar giungono giù giù fino a Bilbo, Frodo e Sam, il quale conclude, per così dire, il Libro Rosso che Tolkien al pari di Manzoni ed Eco non avrebbe che ritrovato e tradotto, ennesimo subcreatore della lunga fila che addirittura si finge mero filologo e copista. Dal Creatore medesimo- nella sua alterità irraggiungibile e meramente specchiata-rifranta negli altri, ai subcreatori, immensi nella portata del loro operato- e del loro orgoglio- come Feanor agli umili-humus, terra e umorismo, giardinieri come Sam e- perché no?- Aragorn il cui primo gesto regale dopo la guarigione degli ammalati sarà piantare un albero nuovo a Gondor. La dinamica, il moto profondo è in fondo sempre lo stesso. Alla parola-intuizione, detta o udita- comunque anzitutto ricevuta sempre e poi a sua volta trasmessa, filtrata in operazione concreta che sia canto, gemma, libro, recinzione e potatura- segue una visione che implica un movimento verso qualcosa che attrae e suscita una reazione che è sempre una compromissione tra due identità specifiche, tra due alterità.
Come notò Wendell Berry Tutta l’arte che si eleva al di sopra della competenza insiste sull’irriducibilità dei suoi soggetti, dei suoi materiali e delle sue opere finite. Crea cose che hanno un valore intrinseco in sé e non sono intercambiabili con altre. Per un falegname semplicemente competente, un’asse può essere praticamente uguale a un’altra. Ma per un bravo falegname o ebanista, ogni tavola è unica. Più un falegname diventa un bravo artista, più è consapevole dell’individualità delle tavole e delle differenze tra di esse. Lo stesso che accade ai primordi del tempo si verifica anche nella chiamata di Bilbo all’avventura. Non c’è differenza di fondo tra le vastità stellari e la piccola finestra di Casa Baggins.
Ed egli parlò loro, proponendo loro temi musicali; ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. Ma a lungo cantarono ognuno da solo, o solamente pochi assieme, mentre gli altri ascoltavano; ciascuno di loro penetrava infatti sol- tanto quella parte della mente di Ilúvatar da cui proveniva e nella comprensione dei propri fratelli essi crescevano solo lentamente. Tuttavia, semplicemente ascoltando pervenivano a una comprensione più profonda, e accrescevano l’unisono e l’armonia fra loro….Ma quando gli Ainur ebbero guardato questa dimora in una visione ed ebbero visto i Figli d’Ilúvatar levarvisi, ecco che molti dei più possenti tra loro indirizzarono tutti i propri pensieri e tutti i propri desideri verso quel luogo. (Il Silmarillion)
Mentre cantavano lo hobbit sentì vibrare in sé l’amore per le belle cose fatte con le proprie mani, con abilità e magia, un amore fiero e geloso, il desiderio dei cuori dei nani. Allora qualcosa che gli veniva dai Tuc si risvegliò in lui, e desiderò di andare a vedere le grandi montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la spada al posto del bastone da passeggio.(Lo Hobbit)
III. Giardinieri vs Corregidori
La creazione è cultura, nel senso proprio di coltura, non a caso a vertice del purgatorio dantesco, polo rovesciato della selva oscura, c’è il giardino dell’Eden, perfetta integrazione di natura e sguardo umano, un’operazione di giardinaggio che coinvolge e cambia entrambi i poli, creatore e creato. Come Adamo a principio della storia, anche noi oggi, ogni giorno, ci scopriamo giù messi nel giardino (Gen.X), per conservarlo, forse una delle parole più insozzate del vocabolario moderno tanto dai movimenti reazionari che la impugnano che da certi progressismi tecnologici che la bistrattano. Natura non è l’opposto di cultura, la cultura autentica che per Pasolini consentiva di ritrovare quella medesima purezza e intensità di approccio -contrapposta semmai alla mera società cui riduciamo le nostre interazioni con noi stessi gli altri il mondo- è il compimento della natura medesima, insidiata piuttosto da uno sguardo ben diverso seppure apparentemente simile, fatto invece di controllo e imposizione previa, dall’ astrattezza geometrica di un disegno che non è davvero coinvolto con quanto già esiste. Come in Cent’anni di solitudine di Marquez, ricordate? Il corregidor arrivato a Macondo senza rumore e il cui primo decreto prevedeva che tutte le case fossero dipinte d’azzurro:
«In questo paese non comandiamo coi fogli» disse senza perdere la calma. «E che sia chiaro una volta per tutte, non abbiamo bisogno di nessun corregidor perché qui non c’è nulla da correggere.» Davanti all’imperturbabile don Apolinar Moscote e sempre senza alzare la voce, José Arcadio Buendía fece un dettagliato resoconto di come avevano fondato il villaggio, come si erano divisi la terra, come avevano aperto le strade e introdotto le migliorie di cui c’era stato via via bisogno, senza aver dato fastidio ad alcun governo e senza che nessuno desse fastidio a loro. «Siamo così pacifici che non siamo morti nemmeno di morte naturale» disse. «Come vede, non abbiamo ancora il cimitero.» Non si lamentò che il governo non li avesse aiutati.
Al contrario, era contento che fino allora li avesse lasciati crescere in pace, e sperava che continuasse così, visto che loro non avevano fondato un paese perché il primo che capitava venisse a dirgli cosa dovevano fare. Don Apolinar Moscote si era messo una giacca di drill, bianca come i pantaloni, e non perse nemmeno per un attimo la finezza dei suoi gesti. «Di modo che se lei vuole restare qui, da cittadino qualunque, è più che benvenuto» concluse José Arcadio Buendía. «Ma se viene a creare disordine obbligando la gente a dipingersi la casa d’azzurro, può prendere le sue carabattole e tornarsene là da dove è venuto. Perché la mia casa sarà bianca come una colomba.» Don Apolinar Moscote impallidì. Fece un passo indietro e strinse le mascelle per dire in tono un po’ afflitto: «Desidero avvisarla che sono armato.»
Saruman assume tante facce, e Alce Nero nel suo memoriale ricordava ancora le profezie degli sciamani capaci di smascherarlo:
In altri tempi eravamo felici nel nostro paese e di rado pativamo la fame, perché allora i bipedi e i quadrupedi vivevano assieme come parenti, e c’era abbondanza per loro e per noi. Ma arrivarono i Wasichu, e fecero piccole isole per noi e altre piccole isole per i quadrupedi, e queste isole diventavano sempre più piccole, perché tutt’intorno cresce la marea divorante dei Wasichu; ed è sporca di menzogne e di cupidigia. Molto tempo fa mio padre mi disse quel che gli aveva detto suo padre: che c’era uno stregone Lakota, chiamato Beve Acqua, il quale aveva sognato quel che sarebbe avvenuto; e ciò molto prima dell’arrivo dei Wasichu.
Sognò che i quadrupedi ritornavano alla terra e che una razza strana intesseva una ragnatela tutt’intorno ai Lakota. E disse: “quando questo avverrà, vivrete in case quadrate e grigie, in una terra sterile, e accanto a quelle case grigie e quadrate morirete di fame”. Dicono che sia ritornato alla Madre Terra non molto dopo questa sua visione; fu la tristezza a ucciderlo. Adesso se ci pensate vedete che voleva alludere a queste case col tetto di terra, nelle quali viviamo, e che tutto il resto era vero. A volte i sogni sono più savi che la veglia.
Tutto questo ci porta proprio agli Ent e al loro incontro con Merry e Pippin.
IV. Il Verbo nel vicinato
I due hobbit in fuga incontrano il gigante primordiale, l’antico pastore di alberi e ne conseguirà una svolta imprevista per l’intera vicenda del romanzo, ossia il destino del mondo in quell’era antica. Anche qui, nell’introduzione dell’uomo-vegetale, quello che potrebbe sembrarci un contrasto tra mondo naturale e culturale è in realtà un intrico ben più ancestrale e complesso. C’è profonda differenza tra autenticità, autentica naturalezza e mera spontaneità, come dovremmo ricordarci nel profluvio a cascata delle nostre reazioni istintive nell’era dei social e della lora violenza, della loro diffusa ottusità compiaciuta. Non esiste natura senza cultura, cioè senza un linguaggio che anzitutto ci parla, ci avvolge e ci dà forma, educa anziché essere meramente parlato, impugnato, utilizzato. Noi siamo questo spazio-tempo messo a fuoco dalle relazioni di linguaggio- questo luogo linguistico potremmo dire Non c’è autocoscienza senza questa trama di relazioni, i patti speciali così come li chiamava Dante, al quale noi italiani dobbiamo la scelta fondamentale di scrivere in volgare proprio per affidarsi interamente a questa relazione primaria con la lingua concreta, inconscia e naturale, laddove invece i linguaggi artificiali-al suo tempo il latino scientifico- parrebbero offrire prestigio, visibilità, successo internazionale.
Così come non c’è conoscenza del mondo, appunto senza storie e poesie, storie che ci vengono trasmesse e che a nostra volta trasmettiamo, integriamo, ampliamo col contributo della nostra personalità, della sua “tinta”. L’immaginazione è proprio- tra le altre cose- questo sguardo creativo o quantomeno subcreativo che coglie qualcosa di preesistente, ne ammira la bontà come Dio nei giorni della Genesi e gli conferisce un posto che non è arbitrario ma cerca di rispettare, di rendere ragione d’una vastità che ci supera. C’è sempre così tanto altro nel mondo, da quando apriamo gli occhi, agitiamo le dita dei piedi ancora sotto le coperte a quando alla sera li chiudiamo nuovamente stesi in quella quotidiana parabola che va dal sorgere al declinare, al morire, al cedere ancora una volta quanto ci è venuto addosso e ha sollecitato la nostra reazione.
Cosa vuol dire infatti vedere se il reale non viene colto come presente e altro, non come mero oggetto da cui cavare qualcosa, fosse pure un pensiero ispirato? Come notava ancora Wendell Berry Per mia convinzione ed esperienza, dirò che l’immaginazione prospera sul contatto, sulla connessione tangibile. Per avere un rapporto responsabile con il mondo, gli esseri umani devono immaginare il loro posto in esso. Per avere un posto, per vivere e appartenere a un posto, per vivere di un posto senza distruggerlo, dobbiamo immaginarlo. Con l’immaginazione lo vediamo illuminato dal suo carattere unico e dal nostro amore per esso. Con l’immaginazione riconosciamo con simpatia i suoi membri, umani e non umani.
Umani e non. Dunque ecco Barbalbero, per come ci viene presentato nel ricordo degli hobbit.
Dietro sembrava esserci un pozzo enorme, colmo di secoli di ricordi e di lunghe, lente, ininterrotte riflessioni; ma in superficie scintillava il pre- sente; come sole luccicante sulle foglie esterne di un grande albero o sulle increspature di un lago assai profondo. Non so, ma sembrava che qualcosa cresciuto nella terra, dormiente, se vogliamo, o solo cosciente di sé come un qualcosa tra la punta delle radici e la punta delle foglie, tra la terra profonda e il cielo, si fosse svegliato all’improvviso e ti soppesasse con la stessa lenta attenzione prestata ai suoi problemi interni per un’infinità di anni.
Il dialogo con gli sconcertati Merry e Pippin prende l’avvio dalla domanda fondamentale, primordiale. Come ti chiami? che è ben più di un mero Cosa sei? Qual è il tuo vero nome? La realtà fuori di noi, in questa dinamica conoscitiva, ha l’aspetto di chi è guardato, direbbe l’Eliot de I Quattro Quartetti, ricambia il nostro sguardo e suscita a sua volta l’identità dell’interrogante, lo svela come partecipante in una relazione e in tale egli si palesa o ripalesa a se stesso. Quante volte una poiana che volteggia in cielo, un profumo inaspettato, uno schiaffo (fisico o morale) ci riespongono a tutto questo rispetto al pigro sonnambulismo in cui ci trasciniamo? Nominare qualcosa o qualcuno è sempre una relazione intima, rifletteva Eugene Peterson. Chi sei tu? costringe a mettere in gioco il Chi sono io?
“Un Ent?” disse Merry. “Che cos’è? Ma tu come ti chiami? Qual è il tuo vero nome?” “Uuh be’!” replicò Barbalbero. “Uuh! Quanto ci sarebbe da raccontare! Non corriamo. E le domande le faccio io. Voi siete nel mio territorio. Che cosa siete voi, piuttosto? Non riesco a inquadrarvi. Non mi sembrate presenti negli antichi elenchi che ho appreso da giovane. Ma ormai è trascorso tanto di quel tempo, magari hanno stilato nuovi elenchi. Vediamo un po’! Vediamo! Come faceva?
Apprendi ora la tradizione delle Creature Viventi! Noma prima i quattro, i popoli liberi:
I più antichi di tutti, gli elfi;
Nano lo scavatore, buio il suo alloggio;
Ent nato dalla terra, antico come i monti; Uomo il mortale, signore dei cavalli.
I nomi come le identità non sono un chiodo pianto nel muro ma un processo, non un mero accumulo di dati ma uno sviluppo, che una poesia- non a caso presente da subito in quel primo scambio di battute- aiuta a cogliere sempre meglio d’una semplice descrizione o analisi: Il mio nome non fa che crescere e io ho vissuto molto, molto a lungo; sicché́ il mio nome è come una storia. I nomi veri narrano la storia delle cose cui appartengono nella mia lingua. Ed ecco forse l’inaspettato: all’origine di tutto questo, persino della coscienza che si sarebbe facile giudicare più primordiale, presente da così tanto tempo che sarebbe facile definire da sempre, c’è comunque – prima ancora – un’operazione poetica, creativa, espressiva cui essa stessa deve qualcosa, in una lunga catena di scambi. Tutto parte dagli Elfi, ovviamente, che hanno svegliato gli alberi e li hanno educati a parlare e ad apprendere la lingua delle piante.
Ennesima pennellata sulla natura “artistica” ossia subcreativa della magia elfica, che non violenta la realtà ma contribuisce semmai a farla pienamente sbocciare. Il linguaggio è forse più antico dell’inconscio stesso, come si domandava di recente il Cormac McCarthy di Stella Maris?
V. Finestre con scuri all’interno
Ca va sans dire, tutto questo già esprime una differenza radicale con la conoscenza per mera quantità di Saruman, basata su qualcosa che ci è fin troppo familiare, una nube che oggi è così diffusa da parere confusa con la stessa aria, inevitabile, persino necessaria, fondata su astrazioni per afferrare e controllare. Un esercizio della mente rigorosamente a distanza, aggirato e scartato a priori quel movimento concreto fisico, quella determinatezza, quella contaminazione e l’obbedienza che deriva a ciò che un rapporto, una storia, suscita in noi. Nelle parole di Eugene Peterson, Ogni volta che passiamo dai nomi personali a etichette astratte o a grafici o statistiche, siamo meno in contatto con la realtà e diminuiamo la nostra capacità di occuparci di ciò che è meglio e al centro della vita. Eppure siamo incoraggiati da ogni parte a fare proprio questo.
È stato giustamente notato da più voci che i malvagi più significativi in Tolkien non si muovono o tendono a farlo il meno possibile delegandolo ai propri servi e strumenti (Sauron nella sua torre, pressoché coincidente con essa, Saruman nella propria do Isengard a sua imitazione, Denethor sempre più ripiegato nelle proprie stanze in cima a Minas Tirith, e Smaug stesso che vola-striscia fuori da Erebor solo perché gli hanno pestato la coda). Le figure più radicalmente corrotte e potenti non si muovono perché il movimento è comunque una passione che manifesta una qualche interdipendenza, una com-passione che essi hanno creduto di compensare con la potenza quantitiva della loro forza di attrazione e controllo, l’immagine stessa della torre che nella sua altezza pare forare le condizioni spazio temporali cui sono vincolate le esistenze “a terra”. Forse è stato notato più sporadicamente come ciò si manifesti anche nella totale assenza di con-vivialità, che invece è uno degli eventi che maggiormente costellano la narrazione tolkieniana nelle vicende dei personaggi principali, dal compleanno di Bilbo in apertura alla cena notturna dei quattro hobbit con Gildor per proseguire negli innumerevoli altri passaggi fino alla conclusione del romanzo stesso.
Quante decisioni vengono prese a tavola ne Il Signore degli Anelli, quanti rapporti si saldano ben al di là del mero scambio di informazioni, una dinamica di indubbio sentore evangelico-l’intera attività di Cristo è scandita da pasti condivisi, dalle nozze di Cana all’Ultima cena- ma le cui fondamenta risalgono ancora più indietro alla cultura tanto ebraica- basti pensare all’episodio delle querce di Mamre- che greca, coi numerosi banchetti a giocare sempre un ruolo dirimente tanto nell’Iliade che nell’Odissea: e dopo che ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere…Nelle parole di Barbalbero sull’Istari corrotto: Gli ho raccontato molte cose che da solo non avrebbe mai scoperto; ma lui non mi ha mai ripagato con la stessa moneta. Non ricordo che mi abbia mai raccontato niente. E non fece che peggiorare in tal senso; la sua faccia, da come la ricordo – non la vedo da un bel pezzo – diventò come certe finestre su un muro di pietra: finestre con gli scuri all’interno.Ora credo di capire che cosa ha per la testa. Sta macchinando per diventare una Potenza. Ha una mente di metallo e d’ingranaggi; e non gl’importa delle cose che crescono se non nel momento in cui gli servono.
L’involuzione di Saruman, la sua saggezza di un tempo che si trasforma in mero accumulo di forza e scompone a prisma, esprime una conoscenza- persino una spiritualità verrebbe da dire- totalmente incentrata sul soddisfacimento narcisistico del sé immediato cui la realtà deve piegarsi ed eventualmente accorrere, senza le inconvenienze dell’autentica esperienza creatrice, dello scoprirsi partecipi . In una celebre lettera di Tolkien – che non si smetterà mai di analizzare a sufficienza – questi parlava della sua radice come desiderio di Potere, di rendere la volontà più rapidamente efficace, e quindi alla Macchina (o Magia). Con quest’ultima intendo ogni uso di piani o espedienti (attrezzi) esterni al posto dell’uso delle proprie forze o dei propri talenti innati; o anche l’uso di quei talenti con l’intento corrotto di dominare: demolendo il mondo reale, o forzando altre volontà. La Macchina è la nostra forma moderna più ovvia, anche se più strettamente collegata alla Magia di quanto sia solitamente ammesso. Non ho usato il termine “magia” in modo coerente, e in effetti la regina elfica Galadriel è costretta a protestare con gli Hobbit che usano quella parola indifferentemente sia per i dispositivi e le azioni del Nemico, sia per quelli degli Elfi. Non l’ho usato coerentemente, perché non c’è una parola per distinguerli (dato che tutte le storie umane dimostrano la stessa confusione). Ma gli Elfi esistono (nei miei racconti) per dimostrare la differenza. La loro “magia” è Arte, liberata da molti dei suoi limiti umani: più facile, più rapida, più completa (realizzazione e visione in corrispondenza perfetta). E il suo scopo è l’Arte, non il Potere; la sub-creazione, non il dominio e la tirannica ri-formazione del Creato.
Come notava sempre Wendell Berry: Una parte immensa di questo danno è stata fatta negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando i macchinari e le sostanze chimiche della guerra industriale sono stati rivolti contro la terra per rendere la produzione “efficiente” secondo gli standard più dubbi e per sostituire gli uomini delle economie della terra. Non ho dubbi che i dualismi tra anima e corpo, tra cielo e terra, troppo presenti tra i religiosi, siano stati dannosi sia per le persone che per il mondo, perché questa divisione ha reso facile negare le necessarie protezioni alle cose materiali. Per contrasto “Il Verbo si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi” affermava il Vangelo di Giovanni. Il già citato Eugene Peterson lo tradusse con l’audace E si è mosso nel vicinato, il neighbourhood dei parcheggi e delle tavole calde e villette a schiera e baite sul lago, nel suo caso. La parola autentica si fa carne solo nella prossimità concreta, storica, locale.
Tutto ciò, per quanto resti sfondo comune di ogni nostro pensiero e funzionamento, costituisce un’enfasi accordata a un piano completamente diverso nel concepire la comunicazione rispetto all’intera impostazione della meccanicizzazione consumistica cui ci stiamo abituando come un’aria che non si possa fare a meno di respirare, una frenesia senza tempo né luogo che annulla la distanza e si affida interamente alla velocità delle reazioni, all’astrattezza generica per intercettare il maggior numero di possibili interessati-acquirenti, al soddisfacimento immediato, alla condivisione indiscriminata, senza limiti o criteri eccetto ultimamente quelli commerciali. Baudelaire l’aveva già notato nelle vertine dei negozi di Parigi e nell’avvento della pubblicità.
Adesso sono la nostra vita e comunicazione stessa a essere in vendita, e quelle che vengono spesso spacciate anche per solidarietà intellettuali e culturali sono solo cerchie di mutua previa approvazione, un flusso infinito di tag e rilanci, nella segreta disperazione che fare arte e ritrovarsi a godere di essa non sia abbastanza. Nell’era dei social, con uno slittamento semantico tanto sottile quanto radicale, i testimonial arrivano a credersi attivisti. Tutto ciò, in parole povere, è una bugia. Velocità, distanza, astrazione, utilizzo immediato: in una recente battuta dello scrittore fantasy-sci-fi Richard K. Morgan, se l’umanità quantomeno occidentale e consumistica dovesse morire di colpo, lìepigrafe perfetta sulla sua lapide sarebbe un semplice motto: Just Eat.
VI. Azioni
Invece, alla luce di tutto questo che ho provato a tratteggiare per sbalzi, le stesse scrittura e lettura si palesano nella loro natura più autentica come un movimento, un’azione, uno scambio che costa qualcosa, un impastarsi reciproco tra storia, autore e lettore. Come ha scritto Hayden Carruth in Toward the Distant Islands, The Iliad, the Odyssey, the Book of Genesis, These were acts of love, I mean deeply felt gestures, which continuously bestow upon us What we are. Ci dicono qualcosa di noi facendoci proprio la medesima domanda degli hobbit a Barbalbero e viceversa: Come ti chiami tu? Ovvero Dove sei tu, qui dentro?
Amicizia è dunque a sua volta un atto essenzialmente immaginativo, un innestare un rapporto nelle storie che già ci avvolgono e ci parlano, tatuarle, nominarle in noi, ricordarsi di sé è non dimenticarsi di loro come nota lo stesso Ent ampliando la poesia citata nel primo scambio di battute, molti eventi addietro:
Sentirò la loro mancanza. Abbiamo fatto amicizia in così breve tempo che ho il sospetto di essere diventato frettoloso… come se tornassi virgulto. Il fatto è che sono la prima cosa nuova che vedo sotto il Sole e la Luna da molti, molti anni a questa parte. Non li dimenticherò. Ho messo il loro nome nel Lungo Elenco. Gli Ent lo ricorderanno.
Ent nati dalla terra, antichi come i monti, grandi camminatori e bevitori d’acqua;
affamati come cacciatori i piccoli Hobbit, la gente ridanciana, il piccolo popolo,
resteranno amici fino a che le foglie si rinnoveranno.
Come si chiedeva ancora Wendell Berry, dunque, L’immaginazione è solo un talento, come una buona voce, la capacità di “inventare” o “pensare” o “farsi venire delle idee”? O è, come la scienza, un modo di conoscere cose che non possono essere conosciute in altro modo? Abbiamo molte ragioni per pensare che sia un modo di conoscere cose non altrimenti conoscibili. Come suggerisce la parola stessa, è il potere di farci vedere, e di vedere, inoltre, cose che senza di essa non sarebbero visibili. In uno dei suoi aspetti è il potere che ci permette di provare empatia. Con i suoi mezzi possiamo vedere cosa significa essere Ulisse o Penelope, Davide o Ruth, o cosa significa essere il proprio vicino o il proprio nemico. Grazie ad esso, possiamo “vedere noi stessi come gli altri ci vedono”.
VII. Il vero incontro è sempre ricordato
Per questo, come in un racconto o una poesia, ogni incontro autentico connette a sua volta passato presente e futuro. La memoria è profezia, anticipazione del futuro medesimo, sua penetrazione nell’arco tracciato di una storia che si sviluppa pagina dopo pagina o verso dopo verso tra gli spazi bianchi. Anziché isolare singole stringhe sconnesse, senza conseguenze, compromette anche il tempo, lo coinvolge e indirizza nella sua dinamica. Ci proietta in una dimensione in una via di sviluppo organico che supera di gran lunga ciò che sappiamo trarne, come vantaggi, restituzioni emotive, intuizioni, conferme, lezioni edificanti persino. Tutta spuma di mare, buona o cattiva, ben intenzionata o superficiale ed egoica. Ancora una volta, siamo agiti da esso, plasmati, impastati. La perdita di memoria, del senso di un arco che consente, implicito ma forte, un appuntamento con se stessi è l’altra faccia della luna della nostra perdita dello spazio concreto presente, nelle relazioni e nel linguaggio, giacché il linguaggio stesso, che già ci precede, è memoria e diventa memoria anche di noi stessi, come un appuntamento che siamo in grado di assumerci e a cui tenere fede. Pure questo in conclusione ce lo ricorda una poesia, o meglio un alieno poeta a uno sconcertato terrestre, altro incontro bizzarro come quello dei due mezzuomini col Pastore di alberi:
Un piacere è un piacere completo solo nel ricordo. Tu, Huomo, parli come se il piacere fosse una cosa e la memoria un’altra, invece sono tutt’uno. I séroni potrebbero spiegartelo meglio, ma non meglio di quanto potrei fare io con una poesia. Quello che tu chiami ricordo è l’ultima parte del piacere, come il crah è l’ultima parte di una poesia. Quando noi due ci siamo incontrati, l’incontro, in sé, è durato un attimo, è stato un nulla. Ora, nel nostro ricordo, sta diventando qualcosa. Ma noi ne sappiamo ancora pochissimo. Quello che sarà nel mio ricordo il giorno in cui io mi stenderò a terra per morire, e quello che opera e opererà dentro di me ogni giorno fino ad allora, questo è il vero incontro. L’altro è stato solo l’inizio. Tu dici che ci sono poeti nel tuo mondo. Non vi insegnano queste cose?” (C. S. Lewis, Lontano dal pianeta silenzioso)
Edoardo Rialti scrive per “L’Indiscreto” e “Il Foglio”. È traduttore per Mondadori delle opere di R. K. Morgan, G. R. R. Martin, J. Abercrombie. Ha curato opere di Shakespeare, Wilde, C. S. Lewis. È autore delle biografie letterarie di C. Hitchens e J. R. R. Tolkien.






