
Avete intercettato Vivere mille vite (effequ), il bel saggio di Lorenzo Fantoni che è anche una “storia familiare dei videogiochi”? Nell’introduzione, tra le altre cose Marina Pierri scrive che, nel gaming come altrove, «[…] abbiamo il disperato bisogno di una mascolinità che non dimentichi i sentimenti; che lasci spazio alla nostalgia o alla malinconia; che pratichi l’affetto come forma e fonte di gioia, non di imbarazzo; che ricordi da dove viene per avere una nozione chiara di dove sta andando».
La conversazione che ho condotto qualche tempo fa con Stefania Sperandio, caporedattrice di SpazioGames, e Fantoni, appunto, s’è interrotta sul più bello, o così m’è parso: per questo sono tornata a disturbare tutt’e due. Per capire meglio, di più.
Titoli pluripremiati come The Last of Us – Part II fanno tanto per riscrivere gli immaginari: ho avuto la fortuna di trattare l’argomento nel ReWriters Mag 3/21, e precisamente qui. Ma sembrano quasi farlo malgrado la percezione di chi gioca.
D: Quanta responsabilità ha la tematica dell’inclusione nell’accoglienza negativa che ha ricevuto proprio TLOU II, a ridosso dell’uscita? L’abuso del sistema di voto, nella recensione di un gioco, è più un problema legato al mondo videoludico in generale o al fatto che la community è stata presa in contropiede? Ho ancora negli occhi i meme disgustati a proposito delle… ascelle di Abby, verosimilmente non depilate. Lì verrebbe da chiedersi: hey, dude, che rapporto hai con l’altra metà del cielo, che poi metà non è?
FANTONI: Molto probabilmente, nessun rapporto. O magari hanno rapporti gestiti in maniera distorta. Magari dei risentimenti taciuti; magari, nella vita di tutti i giorni persone del genere non manifesterebbero mai niente di simile, e poi quando sono online tirano fuori questa roba qui.
Ma purtroppo il discorso è molto più ampio: alla fine certe cose non sono mai legate al fatto che quella data persona pretende quel videogioco lì in quella maniera specifica. Sono visioni del mondo distorte, ed è un peccato vedere la degenerazione di quella che doveva essere una generazione di rottura col passato e che invece finisce col comportarsi peggio dei nonni. Non è un bello spettacolo.
In più, senza dubbio il numerino del voto fa gioco a tanti. Fa gioco ai PR che possono avere una metrica valida da portare, agli sviluppatori che ricevono bonus proprio in base ai voti, a Metacritic e ai siti che riportano il votino e finendo a loro volta su Metacritic, polarizzando e generando discussioni.
 Personalmente non ho niente contro i voti: certo non mi piacciono molto, preferisco dare consigli un pochino più ampi. Se proprio devo scegliere un metro di giudizio tranchant preferisco il “compralo subito / aspetta che sia in sconto / non comprarlo mai”, se proprio devo scegliere. Poi comunque molte persone guardano il voto e vedono confermati o meno i loro pregiudizi, quindi o commentano “Bellissima recensione” oppure “Questa cosa va contro i miei pregiudizi, quindi il recensore è una merda”. Le recensioni spostano veramente poco, eh. Io preferisco le discussioni a posteriori sui videogiochi, come ora: quando sono usciti da un po’, li abbiamo già giocati tutti e se ne può parlare in altro modo. È bello recensire le cose, ma purtroppo è diventata una specie di performance in cui anche il giornalista diventa parte di una sorta di atto teatrale in cui lui ha il privilegio di dire la sua e così via. Credo che siano importanti. Temo che i voti non li scardineremo; io per fortuna cerco di non utilizzarli, però torniamo sempre lì; ai click. Qualcuno ci deve campare. Purtroppo se se ne fa un discorso economico ogni riflessione crolla.
Personalmente non ho niente contro i voti: certo non mi piacciono molto, preferisco dare consigli un pochino più ampi. Se proprio devo scegliere un metro di giudizio tranchant preferisco il “compralo subito / aspetta che sia in sconto / non comprarlo mai”, se proprio devo scegliere. Poi comunque molte persone guardano il voto e vedono confermati o meno i loro pregiudizi, quindi o commentano “Bellissima recensione” oppure “Questa cosa va contro i miei pregiudizi, quindi il recensore è una merda”. Le recensioni spostano veramente poco, eh. Io preferisco le discussioni a posteriori sui videogiochi, come ora: quando sono usciti da un po’, li abbiamo già giocati tutti e se ne può parlare in altro modo. È bello recensire le cose, ma purtroppo è diventata una specie di performance in cui anche il giornalista diventa parte di una sorta di atto teatrale in cui lui ha il privilegio di dire la sua e così via. Credo che siano importanti. Temo che i voti non li scardineremo; io per fortuna cerco di non utilizzarli, però torniamo sempre lì; ai click. Qualcuno ci deve campare. Purtroppo se se ne fa un discorso economico ogni riflessione crolla.
SPERANDIO: Penso che nel caso specifico di TLOU II siano valide tutte e due le cose, il sistema in generale e le aspettative in particolare. Però il fenomeno di review bombing via Metacritic l’abbiamo visto anche a danno di altri giochi. Pensa a Death Stranding, nel 2019. Attorno a Hideo Kojima si è formata e scontrata una coppia di fazioni, perché i suoi fan sono estremamente appassionati, al punto che spesso sono acritici; per loro una cosa fatta da Kojima non può avere difetti, a prescindere. E i detrattori sono ugualmente violenti in senso opposto. Quindi le votazioni su Metacritic si limitavano a rimbalzare tra 0 e 10. Gli utenti si stavano letteralmente scannando per dibattere sull’autore. La parte più deprimente era vederli leggere una recensione e poi scrivere: “Ma su Metacritic ha la media del 4.” Perché?!
Conta sia la tossicità del modo in cui si pone la community (“La mia voce vale 1, ma io te la faccio sentire come se valesse 10!”), sia l’espressione del puro gusto personale, non informato. Non se ne può fare una crociata: non ti è piaciuto TLOU 2? Ok, questo non vuol dire che chiunque altro lo debba buttare, che si debba abbattere Neil Drunkman, che si debbano mandare minacce di morte alla doppiatrice di Ellie, eccetera.
Da una parte queste persone vogliono far sentire moltissimo la loro voce. Dall’altra, siccome — esattamente come funziona in ogni altra branca della narrazione — qualsiasi titolo che si allontani dal canone delle aspettative spaventa il consumatore, certi videogiocatori finiscono per fare un danno al videogioco e non se ne accorgono.
Nel caso di Death Stranding, la prima domanda che mi facevano quando ero sotto embargo era: “Non dirmi niente, voglio solo sapere una cosa: ma si spara?” Io ero allibita. Non è che ti interessa; non è che chiedi: “È bello? È brutto? Me lo consigli?” No, vuoi solo sapere se si spara. Per dire: se Metal Gear Solid II fosse uscito in questa epoca, se lo sarebbero mangiato vivo. Proprio per una questione simile a quella di TLOU II.
La community chiede a gran voce che i videogiochi si elevino in qualche modo, ma ogni volta che poi esce qualcosa di diverso sembra arrivare la risposta per cui i videogiochi devono stare al posto loro. Allora ci facciamo male da soli… La parte tossica della community non ha avuto problemi a addentrarsi in questo tipo di dinamiche. Lo aveva già dimostrato tempo addietro, senza scomodare GamerGate e quant’altro. Ci sono dietro idee politiche specifiche, nel caso di TLOU II si è visto chiaramente.
D: Proprio in modo palese. Certo l’eventuale deriva tossica si segnala molto più velocemente, oggi. E possono trovare spazio anche scelte radicali, impensabili fino a qualche tempo fa. Lorenzo, che idea possiamo farci in merito alla decisione di Druckmann di usare strumentalmente TLOU II come gigantesca riflessione sulla violenza, di genere e non solo — Ramallah docet?
FANTONI: The Last of Us II non è il primo gioco che lo fa, ma è il primo che lo fa a un livello così mainstream. Molti giochi anche e soprattutto indie esplorano quella parte di narrazione che arriva fino a farci sentire i cattivi della storia in modo molto efficace. È chiaro però che farlo in TLOU II è tutta un’altra cosa, e ne abbiamo visto appunto i risultati: le persone fanno resistenza, per certi versi.
 È un po’ lo stesso discorso che va fatto anche con Death Stranding: ci sono ancora persone che vedono i videogiochi solo come un divertimento. E va bene lo stesso, per carità. Ci sono videogiochi che lo fanno. Così come esistono film soltanto comici o soltanto d’azione. Però non credo che si possa andare molto avanti nella riflessione di settore, se pensiamo che un videogioco debba solo divertire.
È un po’ lo stesso discorso che va fatto anche con Death Stranding: ci sono ancora persone che vedono i videogiochi solo come un divertimento. E va bene lo stesso, per carità. Ci sono videogiochi che lo fanno. Così come esistono film soltanto comici o soltanto d’azione. Però non credo che si possa andare molto avanti nella riflessione di settore, se pensiamo che un videogioco debba solo divertire.
È come dire che un film, appunto, debba solo intrattenerti o farti ridere, o che un libro, che so, debba e possa soltanto farti piangere. Sono strumenti in cui vengono inserite tante cose. TLOU II è anche divertente — c’è chi lo gioca come fosse Rambo, nei suoi ambienti sandbox — però alcune parti sono belle coltellate. Alla fine è particolarmente interessante proprio perché il personaggio di Ellie non ne esce benissimo.
D: Ecco, Ellie. Da Chun-Li di Street Fighter II a Lara Croft di Tomb Raider (e pure alla povera Lola Bunny, che non nasce come personaggio videogiocabile, ma lo diventa), fino al redesign realistico di Aloy in Horizon II, c’è spazio per un altro racconto dei generi, persino. Pensiamo al povero Lev e al deadnaming che subisce, finché non lo riscattiamo, almeno in parte, picchiando a sangue… i bigotti. Che ne pensi, Stefania?
SPERANDIO: Molti citano Lara Croft come personaggio femminile indipendente e forte, ma Lara Croft, quella prima Lara Croft, era un manifesto pubblicitario. Era come impiegare una modella bellissima per vendere qualcosa, che so, un hamburger: insieme all’effettivo valore dei giochi, è questo che ha fatto la fortuna del personaggio, all’epoca.
C’è un episodio che mi viene sempre in mente, in questi casi, e che mi fa un po’ ridere. Quando ero piccina, già fissata coi videogiochi, proprio per volermi male ero fissata anche con il calcio. A scuola passavo il tempo a scambiare figurine dei calciatori e a parlare di riviste della Playstation. Questa cosa ovviamente era percepita come stranissima. Era talmente strana che io ricordo una maestra che a un certo punto mi spostò fisicamente dal gruppo. Mi prese e mi mise da un’altra parte, dicendomi: “Stefania, vai a giocare con le bambine.” Nonostante siano passati tantissimi anni, me lo ricordo a perfezione! Ecco: quando accendevo i videogiochi mi accorgevo che, effettivamente, i personaggi femminili erano tutte strafighe. Avevo dieci anni e mi sentivo anche bruttina. Quindi mi dicevo: “Ok, non sono sicuramente io!” E anche: “Cazzo, è vero. Non c’è una donna che sia una, se non quelle che si mettono nei guai e devono farsi salvare. Da chi? Da un uomo. Noi femmine al massimo possiamo fare la spalla. Le comprimarie. Per fortuna c’è qualcuno che ci salva, perché siamo un pasticcio continuo”. Questo trovavo nei giochi: un trope antichissimo, ovviamente. La damigella in pericolo, il Cavaliere che la salva… Trope ereditato dalla narrazione classica e mai messo in discussione, per moltissimo tempo, dai videogiochi.
Oggi non è più così. Quindi al di là della strada che c’è ancora da fare, sono molto contenta della strada che abbiamo fatto. Nel 2013 Remember Me, dello studio francese Dontnod Entertainment (quelli di Life is Strange), non riusciva a trovare un’etichetta per farsi pubblicare perché aveva una protagonista donna e i publisher rispondevano: “Con le donne non vendete. Nessuno vuole giocare come donna. E poi in una scena del gioco questa protagonista bacia un uomo, e siccome i giocatori sono in maggioranza uomini si sentiranno molto in imbarazzo a vedere il loro avatar che bacia uno.” Era il 2013! Non è un periodo poi così lontano. Quindi se pensiamo ai passi in avanti fatti anche grazie a Remember me, che poi è stato pubblicato, e come la tendenza sta continuando — in questo 2021 pensiamo per esempio a Returnal, di Playstation, con la protagonista Selene — c’è evidentemente molta più convinzione.
Possiamo migliorare le sfaccettature di queste protagoniste, il modo in cui le rappresentiamo? Assolutamente sì. Però già il fatto che ce ne siano di più fa in modo che quelle giocatrici che come me da bambina pensano: “Ma il medium cosa mi offre, in risposta a chi mi fa sentire fuori posto?”, si sentano molto di più a casa: c’è Jesse in Control, Ellie in TLOU, c’è la nuova Lara. Ci sono tante produzioni importanti che piazzano una donna in copertina e ti dicono: “Se vuoi giocare, questa c’è!”
Cosa dobbiamo migliorare? Magari il modo in cui la viviamo! Dire “Ah! Un’altra protagonista! Basta! Ce le stanno imponendo! Non se ne può più” è un segno di scollamento dalla realtà: in realtà di protagoniste donne ce ne sono dieci su centoventi. Ci sono ancora resistenze, ovvio. Nel caso di TLOU II mi ricordo tantissimi che dicevano: “Che palle! Lo salto perché voglio giocare con Joel”. Cioè tu salti il gioco a pie’ pari, senza saperne nulla, perché c’è Ellie — e manco sai ancora di Abby…
 D: A proposito di Abby. Io ho lanciato il joystick a metà — Seattle, Day One — in pieno rage quit. Avevo pensato di mollare lì: e teoricamente io sono parte dell’ipotetico nuovo target, no?, a prescindere da quanti anni di gaming abbia sulle spalle. Credo di non aver mai provato una rabbia del genere.
D: A proposito di Abby. Io ho lanciato il joystick a metà — Seattle, Day One — in pieno rage quit. Avevo pensato di mollare lì: e teoricamente io sono parte dell’ipotetico nuovo target, no?, a prescindere da quanti anni di gaming abbia sulle spalle. Credo di non aver mai provato una rabbia del genere.
FANTONI: Ma è giusto. I videogiochi da sempre ci fanno provare emozioni molto forti. Io me ne sono accorto da ragazzino: passi molto tempo con quei personaggi, ti affezioni. Si crea un legame differente rispetto a quello che scatta con un libro o un film, è molto più sottile. E senza dubbio TLOU II, anche con un certo gusto, fa delle scelte molto forti dal punto di vista narrativo. Per certi versi ci ricorda anche che a volte idealizziamo certi personaggi, come appunto Joel, che, beh… È brutto dirlo, ma ha avuto ciò che si meritava. Aveva fatto ammenda per i suoi peccati: però, voglio dire, i morti sono morti. Tanti a causa sua. Non è uno a cui semplicemente, che so, hanno riesumato i tweet con cui faceva battute sagaci da ragazzino edgy. È uno che ha ammazzato, ucciso, derubato, deciso di comportarsi in un certo modo; anche in un contesto particolare, senz’altro. Ma alla fine vien fuori che comunque la vendetta non porta da nessuna parte. Avrei preferito avere più scelta su ciò che, come giocatore, posso fare nel finale? Sì. Però alla fine ha senso anche rispettare la visione autoriale che si nasconde dietro il gioco. Io l’ho trovato comunque un bellissimo esercizio di empatia condotto nella maniera più crudele possibile. Questo va detto. Certo ha settato una barra piuttosto alta, Druckmann. Cosa farà dopo, per spiazzarci? Un gioco di guida?!
 D: Guida sicura, senz’altro. Perché Druckmann mira biecamente a farci diventare cittadini migliori! Era il suo piano all along. A proposito di piani diabolici: come ti è venuto in mente, Stefania, introversa sotto copertura qual sei, di diventare un piccolo grande simbolo scrivendo quello che hai scritto, qualche mese fa?
D: Guida sicura, senz’altro. Perché Druckmann mira biecamente a farci diventare cittadini migliori! Era il suo piano all along. A proposito di piani diabolici: come ti è venuto in mente, Stefania, introversa sotto copertura qual sei, di diventare un piccolo grande simbolo scrivendo quello che hai scritto, qualche mese fa?
SPERANDIO: Ti stupirò: ho buttato fuori quel flusso di coscienza non perché la faccenda mi togliesse il sonno, ma per segnalare lo stato delle cose. Tipo: “La situazione, ora come ora, è questa. Dobbiamo lavorarci.” E per me era talmente ordinario, quello che raccontavo, che non ho capito come abbia fatto, il post, a diventare virale. Non c’era l’intento di scardinare nulla: anche perché, come ben sai, con questo tipo di tossicità più ci provi e meno ci riesci. Ma il giorno dopo mi ha sconvolta il numero di risposte, di condivisioni, di persone che dicevano: “Anch’io!”, di uomini che dicevano: “Dobbiamo fare qualcosa!” Non c’era niente di eccezionale, per me, in quel che denunciavo. E questo è molto triste. Mi riferisco ovviamente al fenomeno per cui, se esce un nuovo video, uno puntualmente si sente in dovere di commentare: “Sei cessa. Metti solo la voce, che così forse ti si può ascoltare”, oppure un altro dice: ”Spero tu sia single, voglio vedere solo video tuoi su SpazioGames. Dimmi dove abiti.” Ci sono questi due estremi. E il lavoro effettivo non lo commenta nessuno.
Invece il post è servito a far prendere coscienza a molte persone che non avevano idea che la situazione fosse questa. Ho colleghi che ogni tanto mi scrivono: “Santa pazienza, mi dispiace tanto, Stefania. Non so come fai”. Sono colleghi maschi. Immagina cosa mi scrivono le colleghe. Quindi è stato utile da quel punto di vista, ma non è stata un’idea del tipo: “Adesso spacchiamo tutto. È ora di mettere le cose in piazza”. A me sembrava fossero già in piazza.

D: Lorenzo, metterei tutto questo in relazione con lo sfogo che faceva l’autrice Eleonora Caruso qualche tempo fa: riassumendo, in merito a Twitch la comprensibile posizione diventa “anche se m’invitano forse è meglio se non ci vado più”. Anche qui, volendo cercare di essere propositivi e mai giudicanti, quale pensi che sia l’approccio più efficace per disinnescare il meccanismo di base?
FANTONI: Guarda, io parto da una prospettiva privilegiata: faccio presto a dire “Eh sì, dovreste farvi vedere di più”. È facile dirlo da parte mia, tutto sommato se parlo di videogiochi, fumetti o simili nessuno verrà mai a farmi davvero le pulci. (Hai presente, no?, c’è quest’idea assurda per cui se parli te di videogiochi magari arriva uno a dirti, a prescindere, “Ma hai giocato a… questo, questo, questo e quest’altro? Perché sennò non puoi parlare”. La pretesa di competenza al maschile è difficile — a meno che non si sia in ambiti proprio precisi, specifici. Nel settore dei videogiochi, un po’ in generale, è sempre pieno di gente che non vede l’ora di dirti che ha giocato e visto più cose di te, che ha iniziato a giocare prima di te… Certo con me cascano male, ho iniziato con l’Atari, spesso li frego. Però è così.)
Quello che posso dire è che è chiaro che è un equilibrio complicato. Chi ha piattaforme interessanti deve muoversi. Io per esempio con N3rdcore pagherei per avere più gente diversa da me che scriva, parli, vada su Twitch: è chiaro che chi ne ha la possibilità dovrebbe aprire e gestire spazi tranquilli, sicuri, moderati in cui le persone possano esprimersi senza sentirsi attaccate.
È una cosa a cui tengo particolarmente: leggevo, qualche tempo fa, un discorso molto interessante. Lo sviluppatore di Obsidian diceva che nel mondo dello sviluppo dei videogiochi dovremmo includere sempre persone diverse da noi, perché proprio da questi incroci nascono cose interessanti, però aspettare che arrivino da sé è sbagliato. Spesso da persone privilegiate non ci si rende conto che, per chi non lo è, arrivare in uno spazio in cui normalmente non saresti stato presente perché non invitato non è così automatico né facile. La prima cosa da fare è creare spazi adeguati a tutte le persone. Non sopporto il ragionamento “Eh, ai miei tempi questi problemi non c’erano, adesso le persone sono fragili, appena hanno un confronto con qualcuno si fanno male”. Io sono assolutamente contro l’idea che il bullismo, le parolacce, la gente che ti dà contro, ti fortifichi. Non è assolutamente vero. Io il bullismo l’ho subìto e non mi sento assolutamente più forte per averlo subito.
Forse per qualcun altro va così: forse a qualcuno l’essere preso a randellate tutto il giorno aiuta. Però non dev’essere questo il metro per giudicare tutti quelli che incontriamo in giro. Quindi per me certi spazi, anzi tutti gli spazi, le persone se li devono prendere, se possono, perché è un loro diritto. Mi rendo conto che non è facile prenderselo. La cosa migliore è fare gruppo, fare quadrato e, se si ha la possibilità, fare massa, per quanto mi rendo conto che se uno vuole fare grandi numeri sia una scelta antieconomica: se vuoi campare coi grandi numeri, oggi, dovresti fare polemica su certe cose, non renderle piacevoli e disponibili a chiunque.
Dal canto mio ti dico che, fosse per me, punto a rendere N3rdcore molto più inclusivo e diverso: diverso da me, diverso da tutti quelli che conosco. Le cose più belle che ho letto a proposito dei videogiochi le ho lette da gente che normalmente non ne scrive, o comunque non rientra nello stereotipo di chi se ne occupa. Prendetevi questi spazi. Chi ha gli spazi, al contempo, deve aiutare gli altri ad avere più rappresentazione. In ogni modo.
Domitilla Pirro è nata a maggio del 1985 e crede che le parole portino fortuna. È giornalista pubblicista iscritta all’Ordine di Roma e direttrice creatività&sviluppo di Fronte del Borgo della Scuola Holden di Torino. Con Sote’ ha vinto la quinta edizione del concorso letterario 8×8; suoi racconti sono usciti su Repubblica, Linus, abbiamo le prove. Con Francesco Gallo progetta Merende Selvagge e La Fionda Factory, ventaglio di offerte narrative per umani di varie dimensioni. Con Sara Benedetti insegna il Buco Nel Cervello, piano di riprogrammazione di genere.
È docente del laboratorio di scrittura creativa per donne operate organizzato dalla Susan G. Komen Italia e la Scuola Holden.
È in debito eterno verso Marcello Fois, suo docente di Racconto&Romanzo durante il biennio in storytelling, che l’ha assistita nella stesura del primo romanzo. Sarebbe pure laureata in Legge, ma fa finta di no.





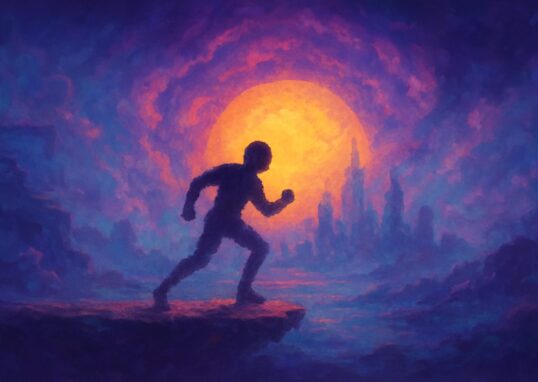

Basta vittimismo.