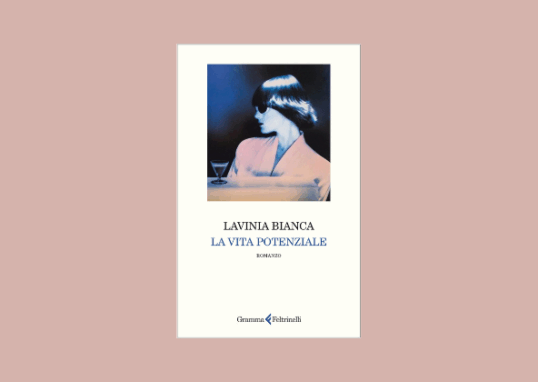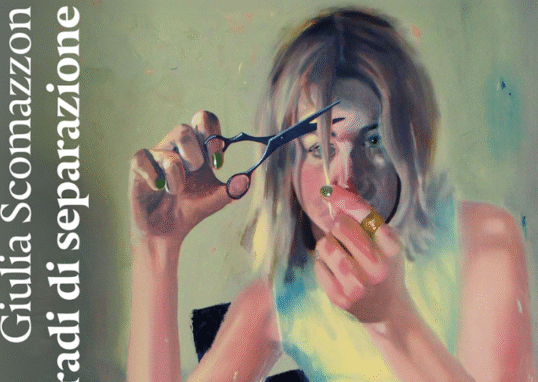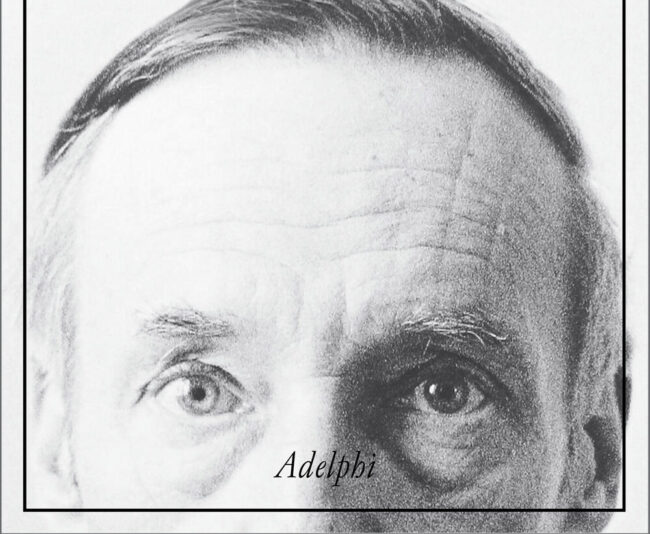
di Franco Cimei
La Calcolatrice Meccanica è un testo del 1985, edito quest’anno in Italia da Adelphi che raccoglie diversi saggi, articoli e lezioni di William S. Burroughs pubblicati nell’arco dei primi trent’anni della sua carriera di scrittore.
Il titolo del volume deriva dall’invenzione del nonno dell’autore: la Calcolatrice Meccanica Burroughs, messa a punto nel 1894, che si diffuse in tutto il mondo facendo la fortuna della sua famiglia. Si potrebbe tentare una decodifica del titolo sulla base della miscellanea di testi presenti nel volume ma come accade in molta della produzione di Burroughs (Pasto Nudo, La Macchina Morbida, La Febbre del Ragno Rosso) i titoli sono tanto altisonanti quanto fuorvianti se si prova ad attribuirgli un significato chiarificatore.
In questa miscellanea ritroviamo tutte le ossessioni dello scrittore nato a San Louise nel 1914: la droga, il sesso, la parapsicologia. Un ulteriore tema, che Burroughs non aveva mai toccato in modo tanto esplicito e saggistico, emerge come filo conduttore di tutto il libro: è il potere mistico e mistificante delle parole, tanto che potremmo definire questa raccolta un eclettico manualetto sulla parola in sé, sia essa un virus, una fonte di reddito, un veicolo per comunicare con i morti o con presunte entità aliene.
Nei quarantatré saggi che compongono il volume la parola viene sviscerata come un corpo su un tavolo autoptico per comprenderne i processi vitali, le capacità riproduttive, le tendenze predatorie, come fossimo di fronte a uno dei tanti organismi alieni non identificati che è comune trovare nella produzione di Burroughs.
Troviamo nelle prime pagine una sorprendente presa di posizione politica nei confronti del plagio: “Vedete, mi era stata inculcata l’idea delle parole come proprietà – <<le proprie parole>> – e di conseguenza una profonda ripugnanza per il peccato nero del plagio […] Voglio dire, in un racconto di Jack London uno scrittore si spara quando scopre di aver plagiato, a sua insaputa, il lavoro di un altro scrittore. Non aveva il coraggio di essere scrittore. Io per fortuna ero fatto di tutt’altra pasta, più soda o quantomeno malleabile”.
La parola, che qui è considerata un organismo biologico autonomo, non soffre il recinto borghese della proprietà. È sulla convinzione cha la parola sia un essere vivente e più precisamente un virus, che si basa la tesi più popolare e controversa del pensiero di Burroughs; la ritroviamo anche in questo testo: “la parola chiaramente reca con sé l’unica caratteristica distintiva di ogni virus: è un organismo senza alcuna funzione interna se non quella di replicarsi”.
Con il susseguirsi dei saggi lo sguardo di Burroughs sulla parola incomincia a moltiplicarsi e sovrapporsi, dopo l’analisi politica (parola come proprietà) e quella biologica (parola come virus), arriviamo all’occhio dell’antropologo – Burroughs si è laureato in antropologia ad Harvard – della parola come operazione magica: “lo scopo [della scrittura] era, in origine, cerimoniale o magico, sicché l’opera, una volta scissa dalla sua funzione magica, perde di vitalità. Ossia, quando qualche tribù si mette a fare bambole per turisti, è finita. Ed è questo che fanno i bestseller: intere valli di bambole e denti di squalo per turisti”.
Proseguendo nella costellazione caleidoscopica della sua analisi della parola, Burroughs non disdegna neanche lo sguardo dell’imprenditore, sa che la parola può essere impacchettata e venduta in un libro e che libro vuol dire soldi e così in La bella e il bestseller, uno dei saggi tratti dalle sue lezioni di scrittura creativa al City College di New York, troviamo diversi consigli su come ottenere il successo editoriale: “È buona norma non aspettarsi mai che il grande pubblico faccia esperienza di qualcosa che non vuole esperire. […] Ci sono certe formule per scrivere un bestseller o sbancare il botteghino. […] La formula del film dell’orrore comporta in una certa misura l’estorsione: si paga per non vedere qualcosa di veramente orribile, si paga per vedere i simpatici ratti di Willard [il riferimento è a Willard e i topi, film horror di Daniel Mann del 1971] e non per vedere i ratti che si mangiano i genitali di un neonato urlante”.
Infine veste anche l’occhio del critico letterario militante che disprezza il ristagno artistico del romanzesco e annuncia l’avvento liberatorio del cut-up (la tecnica con cui Burroughs ha scritto molte sue opere mescolando parti eterogenee di testi diversi): “La scrittura è ancora confinata nella camicia di forza rappresentativa e sequenziale del romanzo, una forma tanto arbitraria quanto il sonetto e tanto lontana dagli attuali fatti della percezione e della coscienza umane quanto la forma poetica quattrocentesca. La coscienza è un cut-up; la vita è un cut-up”.
Non sorprende vedere oscillare la prosa di William S. Burroughs tra la razionalità più tagliente e il delirio acido – è questa la cifra stilistica dominante nelle sue opere narrative – ma vederlo costretto nella gabbia formale dell’articolo culturale o della lezione accademica ci da una prospettiva nuova sulle potenzialità della sua prosa e anche sul peso troppo spesso ingombrante attribuito alla sua biografia.
William è il rampollo di una ricca famiglia dell’alta borghesia americana che dopo gli studi ad Harvard spende le sue giornate sperimentando qualunque tipo di droga, la dipendenza dalla morfina lo accompagnerà per tutta la vita e diventerà centrale nella sua produzione artistica. Nel 1943 conosce Kerouac e Ginsberg e diventa lo zio strambo della beat generation, con Ginsberg viaggerà nel Sud America per sperimentare gli infusi psicoattivi delle popolazioni indigene, che secondo lui indurrebbero poteri telepatici. Nel 1951 fugge dal Messico dopo aver ucciso sua moglie tentando di emulare Guglielmo Tell sparando ad una mela che lei teneva sulla testa. Si rifugia a Tangeri, in Marocco, dove compone l’opera che lo renderà celebre come scrittore: Pasto Nudo.
La vita e il talento di Burroughs finiscono spesso per essere appiattite sull’aneddotica sulla sua tossicodipendenza, sulla censura per oscenità dei suoi libri, o sulle sue fantasiose tesi parapsicologiche, nascondendo così una profonda autoconsapevolezza artistica e l’importanza del suo percorso di sperimentazione formale sulla lingua e sulle forme della narrativa.
Nella Calcolatrice Meccanica troviamo espressa la consapevolezza che il personaggio Burroughs avesse ormai finito per divorare il suo autore, nel resoconto di una lezione universitaria scrive: “Scoprì che l’immagine di <<Wiliam Burroughs>> che si erano fatti i miei studenti c’entrava poco con la realtà. Erano delusi perché in aula indossavo giacca e cravatta; si aspettavano, presumo, che mi presentassi nudo come un verme con indosso uno stap-on. Nel complesso, un’esperienza scoraggiante”.
È questa una sensazione comune per chiunque si accosti a questo libro provenendo dalla lettura dei testi di fiction dell’autore, mentre qui si rimane sorpresi quando la paranoia acida della sua scrittura lascia intravedere uno scrittore consapevole del suo stile, del mercato editoriale e perfettamente padrone delle sue sperimentazioni formali. Scavando più a fondo nel testo compaiono anche i suoi riferimenti letterari e le sue letture preferite: Hemingway, Conrad, London, Fritzgerald, Joyce, Proust e Greene mescolati ad oscuri autori di science-fiction (Kuttner, Foster, Stableford, Stone) o ai già citati bestseller come Il giorno dello sciacallo di Forsyth o Lo squalo di Benchley.
Erede del modernismo novecentesco, figlio della borghesia più nichilista e autodistruttiva, sperimentatore semantico ed anticipatore dei pastiche linguistici del post-moderno, Burroughs è stato uno scrittore e un intellettuale frammentario e grottesco che solo nella dispersione centrifuga dei suoi testi brevi, che qui troviamo raccolti, sembra trovare un ritratto comprensibile ma quanto mai perturbante, come il collage dei connotati incollati insieme per trovare il volto di un indiziato di cui si conosce solamente il nome.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente