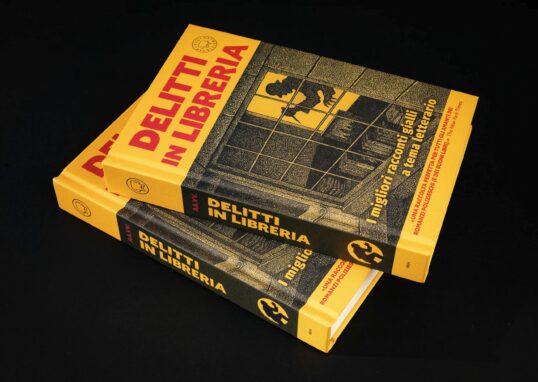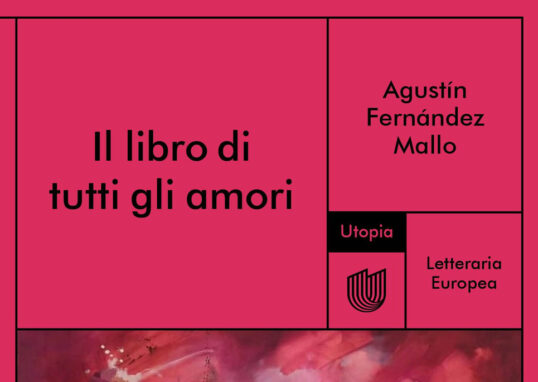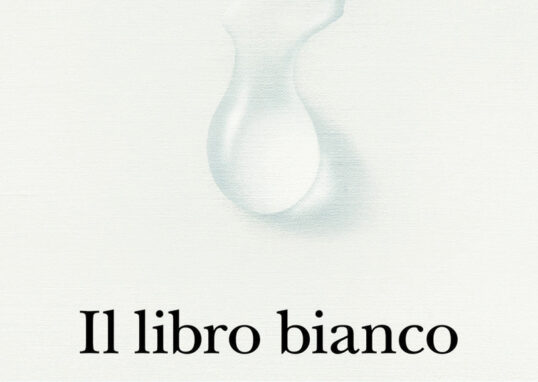Qualsiasi cosa esca dalla penna di Sandro Veronesi ti strega. Non ha nemmeno più a che fare con la storia che decide di raccontare, con un possibile intento dietro alle parole (se mai si possa scrivere con un intento: non funzionerebbe) e neppure con il momento storico in cui il libro viene alla luce o con il lancio del romanzo che viene fatto dall’editore. Sandro Veronesi trasforma in letteratura ogni volta l’urgenza che lo muove, in qualche modo mitigandola e facendola così capace sempre (e sempre di più) di raggiungere sensibilità diverse e mondi così variegati da costituire un universo dai confini dilatati: i suoi lettori sono tanti, tantissimi, di tutti i tipi.
Comandante, la sua ultima fatica uscita di recente per Bompiani cofirmata da Edoardo De Angelis, regista, ha una genesi che Veronesi stesso racconta nell’introduzione. Si tratta infatti di una ricostruzione romanzata di un’esperienza di guerra fatta nel 1940 da Salvatore Todaro, comandante di un sommergibile, il Cappellini, e da tutta la sua ciurma.
A pungolare Veronesi a scrivere di Todaro, uomo capace di disobbedire alle regole dei superiori per onorare una più alta regola, quella della moralità interiore, o anche “solo” della deontologia del marinaio (che non lascia morire uomini in mare), sono una serie di coincidenze. Le stesse che fanno sì che il libro esca a doppia firma e che tra poco vedremo il film, di Comandante, per la regia di Edoardo De Angelis appunto, o che l’idea sia nata quando troppe volte sentivamo discutere sui telegiornali se le navi di migranti dovessero essere riaccompagnate indietro e i naufraghi lasciati annegare (Todaro li ha salvati i nemici – i nemici! – dal mare), o che il contatto con De Angelis e la storia di Todaro siano arrivati come un link sul cellulare della moglie.
Non importa dunque come all’autore venga la necessità di scrivere: quando lo fa, la storia e il modo in cui la racconta diventano universali. Dà voce a tutti, Veronesi, nel suo romanzo, e sceglie la prima persona ogni volta. Parla Todaro, l’uomo prima del comandante, quel “comandante mago” che attraverso le sue intuizioni (quasi delle visioni, invero) guida i suoi uomini, parla Rina la moglie che l’ha visto andar via ingabbiato in un’armatura di metallo dopo un incidente che le aveva fatto sperare che il marito abbandonasse la vita militare, parla Anna l’infermiera innamorata di Giggino il cambusiere, parla Giggino, parla Marcon sfregiato dall’acetilene che tutti credono compagno di sventura di Todaro sull’idrovolante, e ancora Schiassi, il marconista che sceglie, se può, di sintonizzarsi, oltre che sul canale di notizie su quello che manda una colonna sonora che allieta le ore interminabili della traversata, parlano Stumpo e Mulargia, i sardi, parla Stiepovich, l’eroe ch’è quasi conterraneo di Todaro (lui di Venezia, il comandante di Chioggia) e che con lui condivide una lingua in grado di avvicinarli e allontanare il resto.
Veronesi si cimenta quindi nel pastiche con il dialetto – o nel dialetto vero e proprio – ma soprattutto parla la lingua delle storie: la fantasia del possibile che innerva di senso l’esistenza. La vicenda di Todaro che prende a bordo del suo sommergibile quei Belgi che hanno sparato contro di loro (e ucciso un uomo), e che invece di essere neutrali trasportavano pezzi utili al nemico inglese, è una storia vera e per quanto l’autore abbia conosciuto la moglie e la figlia del protagonista, sfogliato album di fotografie, letto lettere e compreso i fatti, ha dovuto inventare come sempre inventano gli scrittori quando costruiscono il mondo che raccontano, fatto di piccoli pezzi la cui somma è una storia ben più grande, e profonda, di quella con la S maiuscola.
Cosa pensavano e cosa sentivano gli uomini sott’acqua nel Cappellini quei giorni di ottobre del ’40? Le domande che sono il sottotesto del romanzo non sono forse poi così dissimili da quelle che si fa, per esempio, il protagonista del racconto “Profezia” (in apertura della raccolta Baci scagliati altrove), che è Veronesi, messo di fronte alla malattia senza speranza del padre e alla volontà di aiutarlo a morire, così come i pensieri affastellati nella mente di Pietro Paladini, seduto sulla panchina davanti alla scuola, nel celeberrimo Caos calmo con cui ha vinto lo Strega (per poi rivincerlo con Il colibrì), in un certo qual senso hanno la stessa matrice di quelli delle anime in attesa nel sommergibile. Vita e morte sono i due estremi di qualsiasi narrazione, e si toccano. Quando la vita è così forte come a volte succede, non si ha paura di morire. O quando la morte può accadere da un momento all’altro allora la vita, anche quella piccola, diventa intensissima.
Qui, in Comandante, ci sono pagine bellissime fatte di lunghi elenchi di pietanze: Todaro ordina a Giggino di “nominare tutte le leccornie che s[a] cucinare, di tutt’Italia […] senza smettere mai” per tenere alto il morale della ciurma, anche se in cambusa ci sono solo gallette, carne in scatola e poco altro. “Il brodo di verdure, il brodo di pollo, il brodo di gallina, il brodo di cappone, il brodo di carne, il lesso, il lesso rifatto alla francesina, il picchiapò, la trippa legata con le uova, il fegato di vitella alla militare, il castrato alla finanziera, le animelle alla bottiglia, la coratella, la zampa al burro, la lingua in salmì, lo sformato di semolino, lo sformato di riso e rigaglie, la teglia di riso patate e cozze, il sartù di riso, i pomodori al riso, gli arancini di riso, i supplì, la pasta imbottita, le quenelles, ossia le polpette di vitella e rognone inventate da un cuoco francese che aveva il padrone sdentato, il polpettone di baccalà, le uova sode alla cilentana, le uova farcite, le braciole ripiene, il coniglio in umido, lo stufato di lepre, la faraona ripiena, il piccione ripieno, il timballo di piccione, la fricassea di pollo, il pollo al marsala, alla contadina, in salsa d’uovo, il pollo disossato, lo stracotto, il peposo, il paciugo, la cassouela, il fricandò, il sanguinacci, ‘a polenta cu’ e salsicce, la frittata di maccheroni, la frittata di scammaro, le frittate in tutti i modi, la peperonata, la parmigiana di melanzane, le melanzane in tutti i modi, le frittelle di pane, di mele, di riso, di polenta, gli spaghetti colle vongole, colle cozze, coi naselli, colle acciughe, colle seppie, all’insalata, le pappardelle colla lepre, gli gnocchi di patate, gli gnocchi di polenta, gli gnocchi di semolino, le zite alla Sangiovanniello, i cavatelli col puleggio, i fusilli con veluozzi, la tirata di maccheroni al pomodoro, il pasticcio di maccheroni, i maccheroni stufati, i maccheroni al ragù, alla siciliana, alla bolognese, alla francese, ossia col groviera, i maccheroni in tutti i modi, il risotto ai ranocchi, alle cozze, alle telline, ai funghi, ai piselli, alla milanese, le tagliatelle al ragù di prosciutto, la pasta e fagioli, la pasta e ceci, la pasta e patate, la pasta e patate colla provola…” tutto questo fa il paio con la battaglia, la paura, i siluri, la morfina. Con la “roboante bellezza: la bellezza che conosce solo il mariner che muore in mar, quando la battaglia si decide, nel grigio, nel bianco, nel blu, e contiene il sollievo e contiene la morte. Quella bellezza che conosce la guerra, quale essa sia, e parole non ci appulcro”.
Veronesi ci fa attraversare la vita nell’istante in cui si compie, e infine ci commuove con semplicità, quella di Todaro che scrive alla moglie: “Rina carissima, oggi è un giorno fausto. C’è un eroismo barbaro e ce n’è un altro davanti al quale l’anima si mette a piangere: il soldato che vince non è mai così grande come quando si inchina davanti al soldato vinto. Oggi noi e i nostri nemici, insieme, ci siamo salvati”.
Valentina Berengo, veneziana, giornalista culturale, scrive di narrativa su quotidiani e riviste online, tra cui «Il Foglio», «minima&moralia» e «Il Bo Live», il magazine dell’Università di Padova. È tra i fondatori di Scrittori a domicilio e di Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere, ideatrice della rassegna letteraria L’anima colta dell’ingegnere ed editor della collana di saggistica divulgativa dell’Università di Padova I libri de Il Bo Live. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, Freschi di stampa e altri, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Latisana per il Nordest. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.