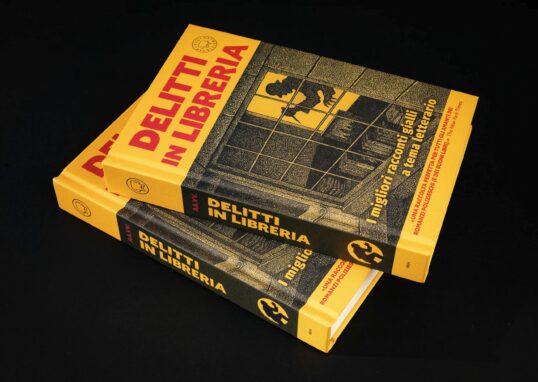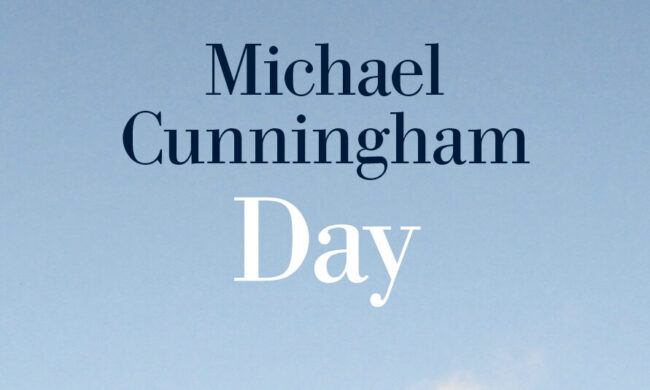
Day, l’ultimo romanzo di Micheal Cunningham (celeberrimo autore de Le ore, con cui ha vinto il Pulitzer), vuole abitare la contemporaneità. Quella fatta dei cambiamenti che quasi sempre fingiamo, soprattutto nei libri, non siano stati pervasivi al punto da rovesciare il mondo: la pandemia, l’onnipresenza dei social, la comunicazione smozzicata e svuotata dei messaggi, che producono un rumore capace di coprire solo in apparenza il frastuono della solitudine che la letteratura magistralmente inscena.
Cunningham, dopo nove anni di silenzio, vuole strappare il velo di Maya. Lo fa però in modo non convinto, o, forse, con troppa delicatezza, cifra che non gli è in effetti nuova. Mette sulla pagina un giorno intero – la mattina in cui ancora era tutto come prima, il 5 aprile del 2019, cui segue un pomeriggio stravolto, esattamente un anno dopo mentre il virus infuria, e finisce alla sera del terzo anno – e in questo scarto di prospettiva ritroviamo gli stessi protagonisti, alle prese con gli stessi tormenti con cui li abbiamo conosciuti.
Ci sono soprattutto loro: Isabel e Dan, moglie e marito in crisi, e ad orbitargli intorno Robbie, fratello di Isabel da sempre innamorato del cognato, quindi i figli della coppia, Nathan e Violet, non ancora cresciuti, e infine una seconda “quasi-famiglia”, fatta da Chess, il piccolo Odin e Garth, il padre biologico, omosessuale come Chess, che s’accorge non solo di amare il figlio (da cui aveva promesso di tenersi lontano) ma anche la madre. Su tutti aleggia Wolfe, personaggio immaginario nato dalla fantasia di Isabel e Robbie, che vive su Instagram e dà modo ai fratelli di esprimere la propria complicità, viscerale al punto da dimostrarsi un legame più forte di quanto non siano le unioni frutto della scelta.
Day è un romanzo sulla fine dell’amore, o sul suo vacillare, ma soprattutto sul lento e stabile restare nelle situazioni sospese che infine costituiscono la più granitica certezza: “Forse un giorno ti sconvolgerà scoprire quanto sia difficile demolire la narrativa del matrimonio. Non sai, non ancora, quante vite ha quella stronza”.
Day è un romanzo sull’incapacità di dare forma tonda al desiderio, annacquato dalla moltitudine di deviazioni dell’esistenza: “Robbie sa cosa intende quando Isabel dice di desiderare qualcosa di più grande. Conosce a menadito il suo linguaggio interiore. Qualcosa d’altro. Qualcosa di meno usuale. Qualcosa di commisurato alla propria capacità di desiderare ciò che aleggia al limite estremo del campo visivo. Un caos di affetto e bonarie litigate. Una vita domestica più complice e insieme più scalmanata. Una lampada alla finestra, stelle che il vento sballotta tra gli alberi”.
Day è un romanzo sul tempo, sulla scansione delle emozioni contrapposta ora all’infuriare degli eventi, ora al ticchettio della vita quotidiana: i figli, il succo di frutta, i post su Instagram, il cane da portare al parco. “Come fai, come fa una persona qualsiasi, a sapere quand’è che dal ci stiamo lavorando passi all’è troppo tardi? […] Oppure, più precisamente, arriviamo all’è troppo tardi in continuazione solo per tornare al ci stiamo lavorando prima che arrivi l’è troppo tardi, per l’ennesima volta?”
Eppure non si capisce se siano i personaggi a essere arresi e tiepidi, o la convinzione dell’autore nel vederli sulla scena così, incapaci di imprimere svolte. Parlano, ma non si capiscono realmente, surfano la vita nel tentativo di fare fronte alla distruzione che si manifesta invece come destrutturazione graduale, anche quando è improvvisa, e nella sostanza ci riescono.
Come Violet, che ha appena imparato a scrivere e si convince che la “g” sia una lettera perniciosa e allora non la usa più, nemmeno in quelle missive per lo zio Robbie ch’è lontano, bloccato dal lockdown in un altro continente, nella neve; o come Robbie stesso, incatenato nel suo gioco di fotografie, che Cunningham descrive a parole, e relative didascalie: la vita di Wolfe, che però è rubata dall’etere ed è fatta di immagini che non collimano mai con la vita che si tocca – la stagione è sbagliata, un dettaglio al limitare dell’inquadratura svelerebbe l’inganno, ma va bene lo stesso, funziona –; oppure Chess e Garth, che hanno fatto un figlio insieme, per lei, convinti ciascuno che la propria omosessualità li difendesse dal pericolo di intersecarsi troppo, e che invece si scoprono legati.
“Per me – scrive in una mail Robbie alla sorella – è sempre stato evento + evento + evento = qualcosa. Non fraintendermi io ADORO gli eventi, adoro indossare un outfit nuovo e vedere cosa succede, ma un periodo di tregua non mi dispiace affatto”.
Forse è proprio di questo di cui parla Cunningham in Day: della sospensione. Voluta o meno. Accettata o imposta. Della fine che non arriva e non è neanche troppo temuta, come un tuffo in un lago ghiacciato. Sembra dire che si può stare, tutto sommato. Restare. Si può “stare alla finestra col vestitino giallo, il vestito che […] le ha comprato un giorno in cui non ha applaudito solo il vestito ma anche la bambina che lei era, dentro il vestito. [Si] può stare alla finestra, indossando il vestito, per ricordar[e] questo mondo che […] sta lasciando per un altro mondo”. Ma basta restare?
Valentina Berengo, veneziana, giornalista culturale, scrive di narrativa su quotidiani e riviste online, tra cui «Il Foglio», «minima&moralia» e «Il Bo Live», il magazine dell’Università di Padova. È tra i fondatori di Scrittori a domicilio e di Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere, ideatrice della rassegna letteraria L’anima colta dell’ingegnere ed editor della collana di saggistica divulgativa dell’Università di Padova I libri de Il Bo Live. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, Freschi di stampa e altri, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Latisana per il Nordest. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.