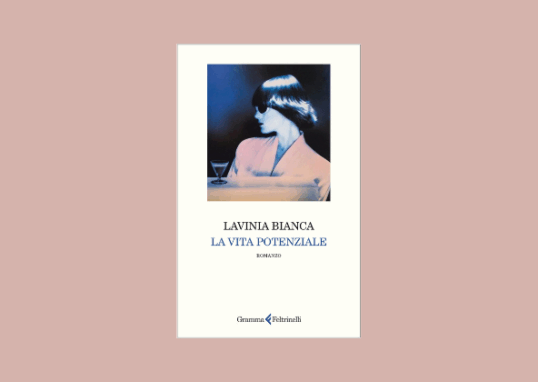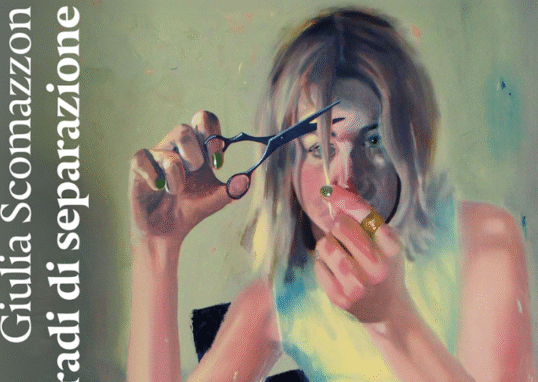Nell’intento di leggere qualcosa che non è mai stato scritto, Georges Didi-Huberman principia il suo saggio Scorze (Nottetempo, 2014) nel descrivere l’atto di posare su un foglio tre piccoli pezzi di corteccia. Tre brandelli rimossi da una betulla in Polonia possono diventare, così, lettere di una scrittura che precede l’alfabeto, tre brandelli di tempo, “un pezzo di memoria non scritta” che il filosofo tenta di leggere a partire dalla riflessione sulla scelta delle betulle nel dare il nome a Birkenau.
“Nella parola Birkenau, la desinenza -au designa precisamente il prato dove crescono le betulle; è dunque una parola che indica il luogo in quanto tale. Ma può anche – può già – essere una parola che designa il dolore stesso […]”.
La valenza del ritorno di Georges Didi-Huberman rappresenta un tentativo di vedere nonostante tutto, nonostante la cancellazione di ogni cosa.
“Ho guardato gli alberi come si interrogano dei testimoni muti. Ho cercato di non volerne troppo a quei poveri fiori crudeli. Ho reinscritto quel luogo, strada facendo, nella mia storia famigliare, i miei nonni morti qui, mia madre che perse ogni capacità di raccontare tutto questo, mia sorella che ha amato la Polonia in un’epoca in cui non potevo capirlo, mio cugino che non è ancora pronto, immagino, a questa specie di ricongiungimento frontale con la storia.”
Georges Didi-Huberman prova a guardare come un archeologo: è attraverso “un tale sguardo – una tale interrogazione – su quello che vediamo che le cose cominciano a guardarci dai loro spazi e dai loro tempi sepolti.”
L’immagine dell’archeologo rimanda indirettamente alle riflessioni di Walter Benjamin che in Scavare e ricordare (in Opere complete, V. Scritti 1932-1933, Einaudi, 2003) sosteneva che chi cerca di accostarsi al proprio passato sepolto deve comportarsi come un individuo che scava, senza avere il timore di tornare continuamente a un identico stato di cose e di “disperderlo come si disperde la terra, di rivoltarlo come si rivolta la terra stessa.”
Il rapporto tra memoria e spazio fisico è da anni al centro di contributi critici di natura diversa, tra cui spiccano le opere di Martin Pollack nell’interrogarsi, in particolare in Paesaggi contaminati. Per una nuova mappa della memoria in Europa (Keller, 2014) su quel che si nasconde dietro la presunta innocenza del paesaggio e sull’opportunità, suggerita da Alberto Cavaglion in Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni (Add, 2021), di gestirne la soglia per elaborare in modo collettivo strategie di decontaminazione a partire dal concetto di limite, “sui nostri limiti conoscitivi, sull’impossibilità di comprendere di fronte all’estremo”.
L’intera produzione letteraria di Edith Bruck pare indagare senza riparo tale soglia, nel meditare sull’impossibilità del ritorno a luoghi associati all’orrore e alla perdita e sul relativo freno provato per estensione per un paese e per chi vi è nato. La deportazione a tredici anni, la prigionia nei campi di concentramento nazisti e la privazione della famiglia e dell’infanzia sancirono una ferita non rimarginabile, pur nel rifiuto dell’odio. Per studiare tale contrasto interiore, con L’amica tedesca (La nave di Teseo) Bruck riesuma una storia risalente alla metà degli anni Settanta per ragionare sulla valenza di legami sorprendenti, capaci di far vacillare certezze.
Come racconta nella postfazione di Michela Meschini, il manoscritto rimase a lungo in un cassetto dopo il rifiuto ricevuto da un editore che lo bollò come “un romanzo per lesbiche”. Nel solco della riscrittura del vero, Bruck si insinua tra le pieghe di un rapporto affettivo complesso e intenso dalla prospettiva della protagonista Erika, suo alter ego, che rievoca il primo incontro folgorante con Lena a Roma nel 1975. La giovane donna tedesca riteneva Erika dotata di una peculiare sapienza affinata dalle sofferenze patite come orfana e sopravvissuta al campo di concentramento che le permisero negli anni di soffermarsi, come giornalista, scrittrice e documentarista, su storie di disuguaglianze, esclusione sociale e solitudine.
Lena amava con ardore la vita, al contempo era turbata da un senso di inadeguatezza e vergogna per il passato di violenze sessuali subite come “bambina buttata via”. Sua madre – fervente nazista che sino alla sua morte celebrò Hitler con una sua foto sul comodino – ebbe tre figli da tre militari di passaggio e li diede in adozione perché con il suo impiego al cinema non poteva mantenerli. Non mostrò mai vicinanza e affetto a sua figlia e respinse le sue richieste di aiuto per gli abusi subiti da tutti i patrigni avuti nelle svariate famiglie affidatarie nelle quali visse.
L’amica tedesca è una storia di riscatto e di emancipazione, un esempio di riscrittura di un destino personale sulla base di un impulso verso la vita, con un’eliminazione delle figure maschili – associate indistintamente al trauma delle violenze dell’infanzia e delle perversioni a pagamento nell’età adulta – in favore di una rete di relazioni femminili basata su mutuo aiuto e affetto, con un’apertura al buddismo e all’arte figurativa nella ricerca di una nuova armonia interiore naturale. L’inaugurazione della mostra di Lena a Monaco, usata come pretesto per esorcizzare, con la partenza, un terrore remoto e pulsante, rappresenta un ulteriore trauma per Erika nel prendere atto dell’impossibilità di un reale ritorno.
“Più che mai dovetti constatare che la memoria dominava sovrana annullando il tempo, la distanza dal mio vissuto, quando il mio cuore da bambina dietro la finestra sbarrata con il filo spinato di un vagone era diventato un grumo di sangue, un feto terrorizzato. […] Anche la ragione, la realtà ben diversa erano impotenti di fronte a un vissuto irrazionale e inspiegabile a chi non l’ha provato sulla propria carne e anima”.
L’opera si interroga sul rapporto con la Storia da prospettive diverse, da quella di Lena come vittima della fede nazista della madre; da quella di Erika – “Un sopravvissuto forse è peggio di un annientato, non è né eroico né un merito essere rimasti vivi, anzi…”–; da quella del marito Emanuele, che cerca nella solitudine una via di purificazione da una vita consumata in un paese deludente e in subbuglio.
La difficoltà di Erika a lasciarsi andare corrode anche i momenti spensierati e giocosi fatti di rose rosse e pane caldo, di attese alla stazione e di baci, di gioia ingenua per l’esistenza stessa, condivisi con Lena in una nuova quotidianità con una complicità al limite dello stordimento. Tra le righe si susseguono interrogativi sul significato della libertà in relazione al peso della verità, dell’azione, del mutamento, dell’impegno, di un’idea di leggerezza effusa da chi ha serbato un dolore insostenibile.
“Mi chiedevo perché era così difficile la semplice verità individuale, collettiva, mondiale. Perché bisogna scavarla nella profondità forse irraggiungibile che ci costringe a rimanere sulla superficie di ciò che ci abita? C’era da smarrirsi di fronte alle menzogne anche quelle gratuite, insignificanti, quotidiane”.
L’opera si rivela anche un’acuta indagine sulla complessità delle relazioni, sulle barriere erette nell’impossibilità di emanciparsi dall’impronta famigliare, sulle possibilità insite nell’anarchia coniugale, sul peso dei vincoli affettivi e sulla difficoltà, vissuta da ogni figura narrata, di ascoltare un desiderio personale al di là di condizionamenti sociali e culturali. Aspetti che la protagonista finisce per indagare nei suoi reportages incentrati sull’illusione della libertà e sul ricatto generati da una società patriarcale e misogina, retta su ipocrisie e valori vacui, come quella narrata nel lavoro giornalistico sulle agenzie matrimoniali che procacciano spose dall’Est.
“Non sapevo per chi avessi più pena, per queste figure poco appetibili alla ricerca della loro merce o per le donne in fuga verso l’ignoto sognando il ricco scintillante libero occidente, per poi finire magari in una periferia da dove scappare via chissà per dove, prima o dopo i sei mesi di permanenza obbligatoria.”
Gli interrogativi sulla dolorosa rielaborazione del tempo in relazione a un trauma remoto rimandano idealmente a quando sostenuto da Christa Wolf in Trama d’infanzia (e/o, 1992) in merito a un passato destinato a non morire mai che porta chi lo vive a cercare inutilmente di sentirlo come estraneo, osservando il rifiuto dell’espressione, il “disgusto della parola” che spinge a “fornire dati provvisori, evitare le affermazioni, mettere sensazioni al posto dei giuramenti; un metodo per tributare alla faglia che attraversa il tempo l’attenzione che merita.”
Con L’amica tedesca Edith Bruck consegna un dolente elogio del margine, un tributo a una storia personale resa portatrice di innumerevoli altre storie di dolore e riscatto, per preservare il valore della memoria e mostrare la necessità di un suo esercizio attivo e critico, idealmente in linea con quanto scriveva Italo Svevo in un passaggio memorabile di un suo racconto incluso in Novelle (Mondadori, 1986): gli esseri umani sono spesso incapaci di una reale consapevolezza, a illuminarli può essere l’avvenire dei ricordi, poiché “il lavoro di memoria può muoversi nel tempo come gli avvenimenti stessi”.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.