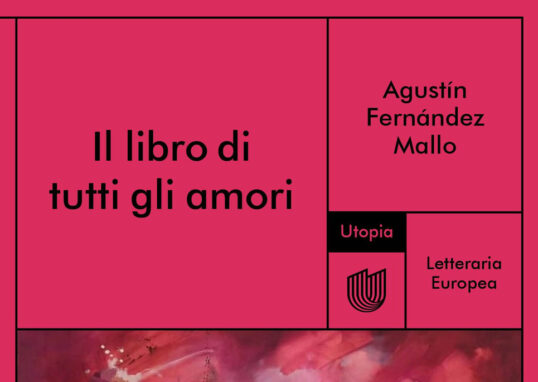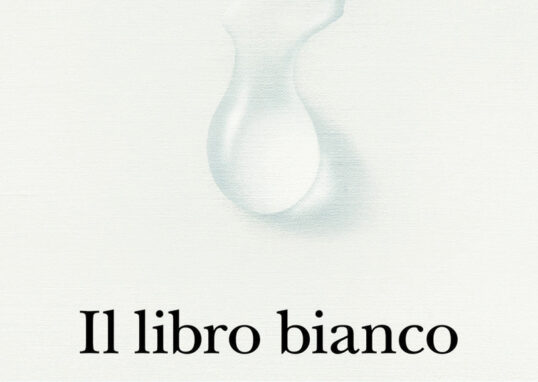Si interroga sulla possibilità di guarire dalla propria infanzia Régis Jauffret quando si rende conto che l’unica difesa da un dolore antico nel ricordo di un padre assente, avido e anaffettivo può compiersi attraverso l’invenzione. Tra le centinaia di personaggi che per decenni una delle voci più rilevanti della letteratura francese contemporanea ha generato, ne mancava uno: Alfred Jauffret. Il pretesto è fornito da un documentario trasmesso nel settembre 2018 – La polizia di Vichy – in cui lo scrittore riconosce chiaramente il palazzo di Marsiglia dove trascorse l’infanzia. Una sequenza di pochi secondi svela l’arresto di suo padre da due uomini della Gestapo. Un avvenimento ancor più sconvolgente perché ignoto a tutti i parenti e amici più vicini. L’enigma porta l’autore ad approfondire la vicenda: ricercare la verità per comprendere che ruolo assegnare a quel padre e provare a immaginare di dipingerlo come un eroe e riabilitarlo nel ricordo.
Quel che prende forma con Papà, (traduzione di Tommaso Gurrieri, Edizioni Clichy), è un tenero e spietato ritratto reale e immaginario di un uomo rimasto estraneo agli altri e a sé stesso. Chiuso nella bolla della sua sordità dovuta a una meningite a 9 anni, segnato nelle ambizioni affossate e nell’incapacità di trasmettere emozioni, assume contorni artefatti agli occhi di un figlio che vive quel padre come calato dall’alto, senza un passato, privo di infanzia e di ricordi da condividere.
Il suo ego ormai atrofizzato, da egoista indurito, santo sordo, martire bipolare, volgare animale ridotto a respirare il proprio fiato chiuso dentro il proprio carapace.
La costruzione a tavolino di una famiglia, l’incontro tra due persone che condividono un’urgenza cieca di procreare culminata con la nascita di Régis – resa come una sorta di blasfema e deviata trasfigurazione della natività –, mostra le crepe di una cornice fragile.
Jauffret delinea quell’“impossibile solitudine dell’essere umano” in un romanzo che si rivela una sorta di memoir sul solco della finzione –“Si è necessariamente lacunosi quando si cerca di inventare la propria vita” – costruito da un intreccio che è l’esito di singoli avvenimenti che si rincorrono mantenendo un’autonomia propria per comporre un mosaico di frammenti.
Interpella il passato, consapevole dell’impostura che cela quel “mondo autonomo in cui esistono universi interi che non sono mai divenuti presente” e della natura ingrata della propria memoria. La percezione dell’impossibilità di assegnare veridicità al ritratto di una “persona ancorata nel reale” e di restituirne “l’interezza degli elementi che lo costituivano” segnala nell’opera la consapevolezza che di quella figura non si potrà che fare uno schizzo ingannevole o renderla un personaggio letterario.
Il passato, questa necropoli. Manipolare i resti degli istanti, semplici ricordi di cui si cerca di servirsi come chicchi di grano per far rifiorire una realtà da tempo sbiadita.
Il fulcro risiede nell’indagine sull’infanzia, rimaneggiata sulla pagina nell’intento di profanarla e massacrarla. In quella grottesca rappresentazione si cela l’incontinenza generata dallo scrivere di sé stessi. “Alcuni istanti sono tenaci e la loro tenacia è ingiusta”.
A partire dalla personale inchiesta sul passato prende forma un’aspra riflessione sul rapporto discordante con la storia: dal silenzio attorno agli eventi – reali o presunti – accaduti a suo padre nelle immagini del suo arresto, alle ipocrisie e contraddizioni della società francese del Secondo Novecento.
La Liberazione ha fatto piazza pulita nei cervelli. Alcuni non avevano più interesse a ricordare. Era meglio fare un serio ordine interiore, gettare fuori bordo le retate di cui si poteva essere stati testimoni mentre si andava a fare la coda in un negozio [..]. Dopo l’annuncio dello sbarco ognuno ha ricostruito la catena dei suoi ricordi e ne ha costruito la storia. «Non gloriosa, di certo». Ma da trasmettere ai figli senza morire di vergogna.
La prosa attinge a un vasto repertorio di immagini, suggestioni, drammi e visioni per direzionare l’autobiografismo a un livello oggettivo e referenziale. Appare irrilevante conoscere la dose di invenzione e di verità che compone il tratteggio narrativo. A rappresentare una ricorrenza regolare sarà la costante apparizione dell’enigma dell’arresto, che l’autore usa per rintracciare un legame con i temi trattati: la malattia, l’influenza del disagio di un padre nella precarietà emotiva e relazionale di un figlio, la necessità di identificarsi in un ruolo per sopravvivere alla miseria dell’esistenza.
Non vorrei essere costretto a condannarlo senza rimedio, a farne un padre inutilizzabile, impossibile da redimere. Ho bisogno di quest’uomo, non posso accettare di vivere senza di lui lo scampolo di vita che mi resta. Progetto di restaurarlo sulle rovine della mia memoria, analizzando i minimi frammenti per cercare di riedificarlo senza tutti quei vizi di costruzione che gli hanno impedito di essere lui. Non si può avercela con qualcuno perché non è esistito. Alfred non esisteva molto, esisteva appena. Un merletto di papà, qualche filo intorno ai vuoti, alle mancanze, alle assenze, intorno alla delusione di non trovare nessuno invece di qualcuno.
L’interesse sociale nel narrare in particolare la vita a Marsiglia, i tipi umani che costellano l’immaginario infantile del giovane Régis, l’ambiente e le sue trasfigurazioni, si innesta nel modello del frammento per esplorare narrativamente l’appartenenza e il disagio. Ancor prima che per le vicende narrate, sono l’impianto stilistico febbrile, il costante ricorso a flashback inventati o reali, l’uso dell’elemento ironico come strategia per raffigurare il tragico e la tensione linguistica a conferire profonda attualità all’universo tematico-simbolico di Jauffret.
Una prosa che si muove tra continue immersioni e emersioni nella memoria personale per immortalare uno spaccato della società del presente, deformato dalle continue alterazioni del reale e dell’immaginifico.
«Siamo imbottigliati dentro di noi». Non siamo i soli a sovrappopolare l’interno delle nostre teste. Ci sono altri che ci circolano dentro, rinchiusi in ricordi blindati in modo trasparente e impenetrabile e puoi bussare, urlare, colpirli con sassi o pietre o incudini, nessuno ti risponderà.
Attraverso l’impasto lessicale denso e la scelta formale, con finti dialoghi che rimandano ai pensieri della voce narrante incasellati tra virgolette, Jauffret si interroga senza sosta su un passato oscuro per tentare di decodificare il suo tempo e collocarsi in sua funzione.
La bestiale e drammatica autoanalisi che prende forma nell’opera può compiersi solo condannando e giustiziando quel padre per cui per decenni un figlio provò un’inestinguibile sete. Esclusivamente annientandone la figura con cinismo e disincanto potrà compiersi una duplice espiazione, in relazione alle colpe di un genitore ritenuto indegno di tale titolo e a quelle di un figlio per l’affronto del disamore.
Alfred, non eri più nemmeno un uomo, solo un organismo, con in fondo alla conchiglia un ego devastato, infilzato nel cervello come una farfalla su un tappo di sughero, quella vita da pesce rosso nel vaso della tua esistenza miserabile attraverso il quale ti vedevo andare dalla cucina in cui ti riscaldavi il caffè fino alla poltrona dove sprofondavi per abbruttirti nella lettura dei tuoi necrologi, delle previsioni del tempo, degli articoli sulla ricostruzione dei quartieri settentrionali che ti riguardavano meno del mio dolore di averti perso da vivo, e tu che urlavi invece di parlare, che cantavi improvvisamente canzoni dell’epoca in cui ancora potevi sentire, rottame di papà, papà affondato, arenato in fondo allo stagno e io cercavo continuamente di dimenticarti, di piangere la tua morte, tu qui e là, tu che non te ne andavi mai, che eri sempre in casa, cane randagio, ma io non sono figlio di cane, di molosso, di cagnolino, di carlino, di bestia bella, immonda, saggia, eri mio padre sempre qui, sempre là, a volte, eppure, nonostante tutto, qualsiasi cosa fosse, di papà non ne avevo.
L’unico personaggio con cui non era ancora riuscito a fare i conti permette a Régis Jauffret di costruire l’inventario letterario di una nevrosi vissuta in età infantile e mai del tutto esorcizzata: in quel nodo drammaticamente insoluto risiede l’invocazione dell’artificio e della trasfigurazione della realtà per livellare quel doloroso disequilibrio. Il risultato si cela in una prosa che si muove per intermittenze, frammenti, e che non procede per avvenimenti concreti ma assecondando l’intricato groviglio interiore, lacerato dalle contraddizioni dell’incompiuto e dell’irrisolto. La pagina diventa allora la manifestazione immediata di quei tentativi di risvegliare un passato inesorabilmente disperso con l’ultimo salvifico travestimento.
«Abbandonare per un istante la ragione è una forma di meditazione». L’assurdo, pensiero libero da qualsiasi ostacolo, sport interiore, vortice, la coscienza divenuta derviscio rotante. Pensare è accettare di tuffarsi nel lago dei pazzi. Anche se si deve mantenere la forza di risalire a galla e di scuotersi come un cane bagnato.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.