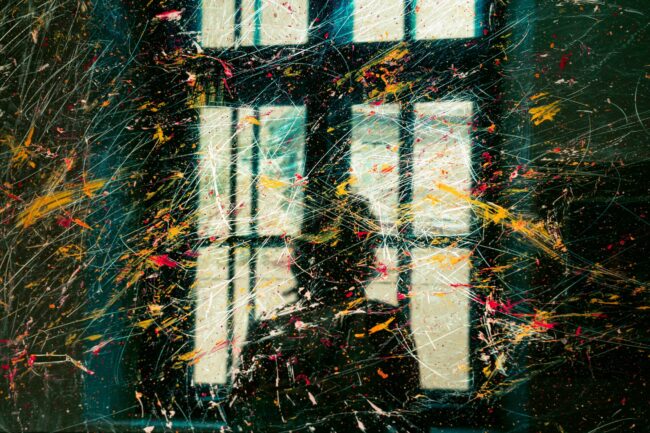
Leggendo una poesia di Roberto Bolaño, per il canale streaming di «Decamerette», ho involontariamente sostituito in piedi ci sono solo i cordoni / della polizia con in piedi ci sono solo i cordoni / della poesia, mi è parso da subito uno dei più bei refusi di sempre. L’idea di una nuova rubrica è nata quel giorno, un appuntamento che facesse l’esatto contrario di ciò che fanno i cordoni della polizia: avvicinare. Accorciare le distanze. Per ogni numero si parlerà di una, due o più poesie, di vari poeti, cercando un filo comune, facendo sì che versi lontani si tengano per mano.
*
Prendiamo un indizio, trasformiamolo in prova, dimentichiamocene, facciamo finta di niente. Allarghiamo il nostro sguardo, usiamo il campo lungo cinematografico, saliamo sul tetto di un palazzo in costruzione, da lì osserviamo la prospettiva di una vita, di una vita in un cantiere. Decidiamo cosa sia produttivo, cosa, invece, no. Infine, cosa sia amore, cos’è il limite. Scegliamo la nostra memoria preferita, il nostro ricordo, ma facciamo che venga dal futuro. La poesia ci aiuta a ricordare al contrario. Pensiamo a quanto l’oltre sia a portata di mano. Se ci sono porte le abbiamo già oltrepassate, dobbiamo soltanto venirlo a sapere. Dobbiamo informare noi stessi. Le case, i vestiti, gli armadi, cosa resta, cos’è andato, cosa è pronto ad accadere di nuovo.
È già accaduto, per nostra informazione, per nostra disperazione, per nostra ricostruzione. Dobbiamo cambiare posto, anche se non sappiamo come andrà a finire. Come andremo a finire, ma finire è già cominciare, spostarsi è già accomodarsi di nuovo. Prendiamo una prova, riportiamola a semplice indizio, dettaglio fuori posto, memorizziamola, rendiamola punto di partenza, di conoscenza. Pensiamo al fuori fuoco, appassioniamoci all’incertezza dell’inquadratura, all’ombra rimasta fuori dall’obiettivo, diamo un’occhiata a chi scatta. Anche il fotografo è paesaggio, pure lo spettatore è cinema, l’operaio è la casa che costruisce, il soggetto esiste nella forma che cambia di continuo, il poeta o la poeta – come si deve – sarà una lettrice e un lettore. Siamo lo sguardo, pare volerci dire Giuliana Pala, siamo la caduta costante ci ricorda Marco Carretta, siamo la sostanza dentro la forma e scivoliamo, ci mostra Letizia Polini, siamo ogni avvenimento e la sua negazione, ci racconta Marco Aragno. Prendiamo ognuno di loro e vediamo come. Dove.
*
«Filmiamo tutto, io lo faccio per te che devo farti vedere:
giro, faccio perno con i piedi puntati sulla buca
qualcosa dentro mi dice che non basta mai
decido che ci metto un saluto veloce: volto su di me
la fotocamera: sale un’onda, l’acqua si fa obliqua».
Filmiamo tutto, comincia così questa poesia molto riuscita di Giuliana Pala. Filmiamo suona come un ordine che include chi lo impartisce. Noi siamo (oppure niente), da soli siamo senza. Filmiamo, esorta Pala e aggiunge ciò che è più importante, ciò che è il segno del nostro tempo: tutto. Noi siamo il te che dobbiamo vedere, siamo l’oggetto del film, il soggetto, lo sguardo. Filmare tutto non basta, non basta mai, e allora chi scrive aggiunge qualcosa, un saluto, ma noi avvertiamo l’onda che chiude, e pensiamo all’acqua che si fa obliqua, crediamo a un grandangolo che la contenga tutta, che la documenti. Si tratta di una poesia molto riuscita, inclusa in Lunari (Excogita 2025, collana Distonia). Il libro ha a che fare con il piacere dello scrivere e con quello di ricordare. Solo che il futuro, il sogno, l’ignoto, sono cose da ricordare prima di conoscerle, prima che accadano.
Pala scrive di una memoria in divenire, di specchi che rimandano tutto e niente, di immagini che funzionano come funziona l’acqua: allargandosi, asciugandosi, facendosi invadente. L’immagine che sale e che scende. Quel tutto da filmare vuole fissare non solo l’istante e i soggetti di quella ripresa, ma i loro desideri a venire, i loro probabili mutamenti, le somiglianze che andranno perdute. In queste poesie un desiderio di quiete e di parole e cose che si generano a vicenda. La cosa non esiste se non nominata, la parola non suona se non trova un corrispettivo su cui posarsi. La raccolta di poesie di Giuliana Pala appare anche come un libro sulla vicinanza e sulla distanza, sull’importanza che diamo a ciò che possiamo trattenere, è – naturalmente – un libro di fasi e di frasi, lunari e frasari. Piccoli passaggi, suoni. «E tocca darsela a gambe», chiude un’altra poesia e ci ricorda quello che facciamo da sempre, in ogni occasione, anche mentre leggiamo queste poesie molto belle.
«2023
Arriva un pacco,
suo padre preme le bolle
come lui le parole.
Forza un pensiero di martello
fuori dalla sua testa.
Il pacco arriva dal passato.
È un pacco vuoto.
È un pacco di foto.»
C’è un pacco che arriva dal passato, c’è un passato che arriva dal passato, c’è un vuoto che arriva dal passato, c’è un niente che arriva dal passato, c’è ogni cosa che arriva dal passato. E lo sono le bolle da premere, lo sono le parole da schiacciare. E le parole sono bolle se proteggono, e le parole escono dalle bolle se non lo fanno. C’è un vuoto, una caduta costante che accompagna le poesie di Marco Carretta incluse nel suo libro Gli anni degli altri (Vydia editore 2025). Il vuoto incombente che troviamo in questa poesia, il pacco è vuoto pur essendo pieno di foto, ma ciò che lo riempie e lo svuota viene dal passato. È il passato, Carretta fa il contrario di Giuliana Pala, ma ottiene la stessa efficacia, anche in presenza dei suoi versi restiamo sgomenti. E lo sgomento pare essere l’unica cosa che ci rappresenti sul serio, che ci riguardi. Viene in mente una prosa stupenda di Mark Strand (Quasi invisibile, Mondadori, trad. D. Abeni), quella del cuore vuoto che con il peso della giornata sulle spalle non può far altro che continuare a svuotarsi, ovvero a riempirsi di un peso insostenibile. Carretta si domanda e si domanda: Come succediamo? Come accadiamo? Cioè esistiamo solo in quello che scaturisce da noi, che poi è già quello che non ci riguarda più. Ci piacerebbe non essere noi quelli che cadiamo, apparteniamo già alla caduta. Siamo tutti quanti in attesa di un pacco che non vorremmo ricevere, ma poi lo apriamo velocemente, troviamo le foto, non troviamo niente, troviamo noi stessi sbiaditi, troviamo chi ci ha preceduto. Forse non siamo pronti a sostenere il peso di tutto ciò, che equivale a non sopportate chi diavolo siamo. In un’altra poesia Carretta scrive «La città invece, / la città è discorso», e parla la città perché ci si va per vivere e il poeta lascia un sul serio? sospeso, beffardo e gravido d’attesa, di altro vuoto.
«Atti
materializzarsi con atti mancati o mancanti. gettarsi per sentire da che parte il corpo cede. sacro è fare. sacro è disfare. isolarsi in una casa posticcia – non sperdersi in piccoli microorganismi che sembrano vivi.
levigare le crepe dei guasti e illuminare il dente che porta la carie. nascondere è accarezzare i denti più sani.
coprire persino i bulbi oculari – puoi ancora fare placenta di buio nel punto più interno del cranio.
venire da ripensamenti di stati iniziali. il cambiamento è sotto. demordere sotto. dipendere da intrusioni roventi. cercare aureole calde in crostali vicine e convergenze. sovrapporsi per ispessire. sentire la pressione produrre calore su ciò che è sepolto. allinearsi in modo planare. tessere fondi sicuri – uno alla volta – sull’ultimo nascere».
Da quando ho letto questa poesia ci penso spesso, perché tutta la nostra vita è regolata da quell’incipit. È tutta una questione di atti mancati e mancanti. Le cose che non abbiamo fatto (che non facciamo), le cose non accadute (che non accadono, che avremmo voluto accadessero). Letizia Polini (Subsidenza, puntoacapo 2024) poi scioglie quegli atti, nel seguito di questa prosa breve, li recita e li diluisce nella forma in continuo mutamento di cui parla il libro. E la forma è linguaggio, è la forma è cedimento del corpo quando si disfa, quando si abbandona. Il corpo quando si accosta ad altri corpi, quando si isola. Il corpo quando si perde. Polini parla di guasti, di disfacimento, di chiusura dei bulbi oculari. Sottrarsi. Polini scrive di ripensamenti e del ripensarsi, di strati iniziali, sapersi nell’incipit, sapersi prima della parola. Demordere, dipendere, convergere, tessere. Una parola viene in mente ed è solitudine. Un dato di fatto emerge: dare senso alle cose. Ma quali, ma quando, ma dove? Polini ha scritto un libro molto interessante, un libro di azioni e di domande. Ondeggia tra lirismo e sperimentazione, e così che la forma scritta oscilla continuamente, quasi come danzasse. I significati di subsidenza, sia in geologia che in meteorologia indicano comunque qualcosa che si abbassa, che va verso il fondo. Polini sa che l’incombenza del tempo, i segni, i segnali, le ferite, le suture, tutto ci abbassa. Sedimentiamo sotto, scendiamo lentamente sotto il peso di una massa d’aria, di una massa di cose. Una massa di noi. In un’altra poesia leggiamo: «i frammenti dimostrano / il disordine nascosto». E siamo i frammenti, siamo il nostro disordine, finalmente rivelato.
«Tieni a mente le notizie sparse
gli avvenimenti minimi
i fatti relegati ai margini del viaggio.
Tieni a mente l’insetto che annega
nella goccia del finestrino
e scivola agli angoli della visuale
corpo affiorato mentre fissi il paesaggio
smarrito in un giorno di pioggia».
Gli avvenimenti minimi dobbiamo tenere a mente. Fare memorie delle cose piccole che stanno a margine del viaggio. Poi un’immagine bellissima, l’insetto che annega della goccia del finestrino. Se volessimo domandarci cosa deve fare la poesia potremmo usare – tra le molte altre – quest’immagine tanto delicata e potente, nonostante includa una morte, seppur di un insetto. Ma è soprattutto una questione di sguardo. Il paesaggio qui per Aragno si fonde, non è solo ciò che fissiamo, ma è anche ciò che partecipa, l’insetto che annega, il verbo smarrire che pertiene all’io, all’insetto, al paesaggio, alla goccia, alla vita. Marco Aragno (Sonder 2023, Pequod) offre una prova molto matura, di grande e semplice bellezza. Di nuovo un libro di sottrazione, di occhi che stanno vigili sopra le macerie, che riescono a scorgere un bagliore dove insiste solo un grande senso di perdita, un vuoto, non dissimile a quello di Carretta, una dispersione che s’accosta a quella di Pala, a quella di Polini. Marco Aragno è nato dove sono nato io, non genericamente, proprio nello stesso posto, e riconosco in lui il doppio binario quello della rassegnazione e l’altro della speranza. Tutto crolla ma qualcosa non cede, rimane, tra le nostre mani, in ogni dettaglio che sappiamo trattenere. E quella terra martoriata è presente, come nelle sue poesie precedenti, perché a quei luoghi apparteniamo, e ne abbiamo timore, pur provando una strana forma d’amore, un’altra che è un tremito, un perenne disagio nei confronti degli altri e di noi stessi. Sonder come scandagliare, e scandaglia Aragno fino in fondo al mare, alle discariche, al senso delle cose. Ci lascia molte domande. In un’altra poesia scrive: «Nessun terremoto o alluvione / o altro evento di rilievo / che potesse spiegare alla ragione / il crollo del nostro tempo». Già, verrebbe da dire, eppure con le poesie di Aragno tentiamo, proviamo a risolverci, a risollevarci.
Due autrici, due autori, giovani, con un sacco di idee, che seguono quattro strade diverse che ci ricordano, a modo loro, che la poesia non va per una sola strada, diversi sono i modi, i sentieri, le domande che genera, le risposte che non offre. Quattro indizi trasformiamoli in prove.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/






