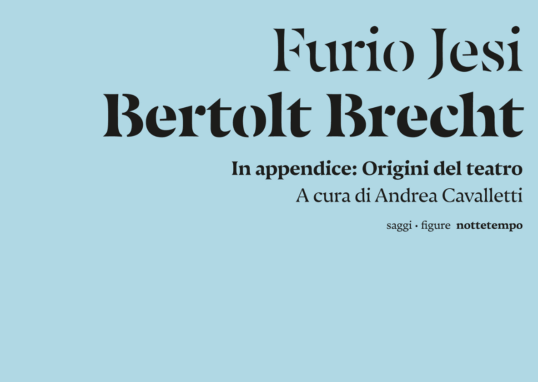(foto di Sara Lombardini)
Con “La valigia dell’autore” proviamo a creare un racconto e una mappatura della scrittura per il teatro in italia. Drammaturghe e drammaturghi italiani di questo primo quarto di XXI secolo si raccontano, riflettendo attorno al metodo, agli incontri essenziali, all’immaginario che hanno plasmato sul palcoscenico (G.G.).
Puntata n°12 – Sedici domande a Emanuele Aldrovandi, drammaturgo e regista, spazia con la scrittura dalla narrativa al cinema, ma ha scritto e scrive soprattutto per il teatro. Ha vinto il Premio Pirandello con Felicità, il Premio Tondelli con Homicide House, il premio Hystrio con Farfalle, il premio Fersen con Il generale. Le sue drammaturgie sono state messe in scena nei principali teatri italiani e tradotte in molte lingue.
Dove nasce la prima scintilla della tua scrittura teatrale, l’idea di partenza e l’incipit: in sala o sulla scrivania?
Ero in quarta Liceo, gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra all’Iraq e io avevo saltato lezione per andare a manifestare. Era primavera, c’erano bandiere della pace, capelli lunghi, rasta, magliette dei gruppi punk che avevo appena iniziato ad ascoltare, striscioni apodittici tipo “Fuck Bush” o “Le bombe intelligenti mettetevele in culo” e un furgoncino-soundsystem con musica a tutto volume.
Io e il mio compagno di banco avevamo deciso di non tagliarci la barba e i capelli fino alla fine della scuola – per protesta non ricordo contro cosa – e stavamo lì in mezzo a cantare, urlare e pogare.
Mi sentivo nel posto giusto.
A un certo punto, all’altezza di Corso Garibaldi – sono sicuro che fossimo lì perché mi ricordo gli alberi che coprivano il cielo e la loro ombra che dava un po’ di sollievo rispetto al caldo della via Emilia – a un certo punto dal furgoncino-soundsystem è partita Contessa, la canzone di Pietrangeli rifatta dei Modena City Ramblers, e tutti ci siamo messi a cantarla.
Quando è stato il momento del ritornello, “Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra”, io ho alzato la voce, come tutti quelli intorno a me, ma poi mi sono bloccato.
Un attimo.
Ferma tutto.
Siamo a una manifestazione per la pace e stiamo cantando che vogliamo la guerra? Che i nostri “nemici” li vogliamo veder finir sottoterra?
Mi sono guardato intorno, in cerca di una qualche forma di complicità con gli altri manifestanti, ma nessuno sembrava cogliere la paradossalità della situazione.
Qualcuno stava urlando “Bush muori bastardo!”
Improvvisamente ho smesso di sentirmi nel posto giusto. Ovviamente ero sempre convinto che fosse meglio stare lì che non a una manifestazione “pro guerra”, ma allo stesso tempo mi sentivo disallineato.
Fuori asse.
Sette anni dopo, al primo anno di Paolo Grassi, quando Serenella Hugony ci ha chiesto di scrivere una commedia di carattere, mi sono tornati in mente i pensieri di quel momento, in Corso Garibaldi, e ho avuto l’idea di un generale pacifista che per porre fine a una guerra decide di sterminare il suo stesso esercito.
Quello è stato il mio primo testo teatrale, Il generale, che poi ho riscritto tante volte, negli anni, e sto riscrivendo anche adesso per rimetterlo in scena nella stagione 2026/2027.
La scintilla non è scattata né in teatro né a casa davanti al computer, ma in un momento in cui, vivendo, mi sono sentito “fuori asse” rispetto al mondo che avevo intorno e in un certo senso anche rispetto a me stesso. Credo che più o meno sia sempre andata così: il mio desiderio di scrivere nasce dai dubbi.
Come funziona la parte di scrittura in solitaria? Dove scrivi? Quante ore al giorno? Hai una routine?
Non ho mai avuto una routine e ho sempre scritto ogni volta che potevo.
Ma devo essere solo e nessuno deve poter leggere sul mio schermo – motivo per cui in treno, di solito, anche quando avrei voglia di scrivere, finisco per leggere, telefonare o rispondere alle mail.
Per il resto, non mi do né limitazioni né obblighi di costanza. Ci sono stati anni in cui ho scritto tanto di notte e pochissimo di mattina, poi da quando è nata mia figlia la proporzione si è invertita, ma non sempre. Dipende dai momenti dell’anno, da dove sono e da cosa devo fare. Per esempio, adesso sono a Roma per uno spettacolo, sono le due di notte e sto rispondendo a queste domande, ritardando il momento del sonno, nonostante domattina mi dovrò svegliare presto e nonostante avrei un’altra scadenza urgente a cui lavorare.
Ecco, forse l’unica costante è sempre stata questa: non scrivere quello che dovrei. È come se la mia mente, in automatico, deviasse dall’obbligo e ricercasse il piacere.
Come funziona la revisione dei tuoi testi? Sono influenzati dal lavoro in sala? Riscrivi scene che vengono provate?
All’inizio andavo sempre alle prove. Ascoltavo i registi e gli attori parlare del testo, modificavo le scene da un giorno all’altro e devo dire, retrospettivamente, che sono stati i momenti in cui ho imparato di più. Non credo si possa davvero scrivere per il teatro senza aver fatto un lungo lavoro con gli attori e i registi, per capire come funziona il passaggio dalla parola scritta a quella agita: è una forma di competenza artigianale che non si può studiare e non si può apprendere “in teoria”.
Poi a un certo punto ho smesso di andare alle prove, se non saltuariamente, sia perché fortunatamente gli impegni erano maggiori, sia perché mi sono reso conto che avere l’autore vivo in sala porta spesso i registi e gli attori a voler cambiare tutte le cose che non riescono a far funzionare. E questa dinamica – piccolo cambiamento dopo piccolo cambiamento – può finire per snaturare un testo.
Se invece non ci sei, tendono a essere tutti più cauti nel ribaltare radicalmente le cose che hai scritto e comunque, una volta che tu vai, non so, alla generale, puoi sempre dire “Maledetti, così non funziona, non vi do i diritti!”
Scherzo, non l’ho mai fatto. Però mi è capitato di far notare che la direzione presa e le modifiche effettuate avevano trasformato il testo rendendolo meno efficace. E potevo farlo perché, da autore-assente, mantenevo un distacco rispetto al lavoro. Quando invece sei lì, in sala prove, tutti i giorni, diventi parte del processo di riscrittura, diventi una specie di dramaturg e se c’è una cosa che ho imparato in questi anni è che l’autore e la “specie di dramaturg” sono due lavori completamente diversi.
Non mi addentro nella definizione di cosa sia una “specie di dramaturg” per evitare di essere redarguito epistolarmente dalla mia ex-insegnante Renata Molinari (che comunque dubito leggerà queste risposte), ma di sicuro, nonostante le esperienze molto arricchenti dell’inizio, a fianco di registi e attori, mi sono sempre sentito più “autore” che “specie di dramaturg”.
Quando poi ho iniziato a dirigere i miei testi ho sperimentato una nuova modalità di lavoro. Mi rendo conto che non sia una gran “scoperta”, perché è poi quello che hanno sempre fatto gli autori del passato, da Shakespeare a Molière fino a Pirandello – e pure quelli che considero i contemporanei più interessanti, tipo Tiago Rodrigues, cioè far confluire il processo di scrittura all’interno di quello registico. La coincidenza dei due ruoli permette di mantenere un equilibrio per cui le “modifiche” rese necessarie dal lavoro di palcoscenico non stravolgono il testo, ma lo rendono più efficace e la regia non è l’applicazione esterna di un filtro che sceglie un singolo aspetto da mettere sotto la lente d’ingrandimento (questo approccio “critico” ha senso – forse – con i classici, molto meno con i testi appena scritti o addirittura “mentre li si scrive”), ma diventa l’emanazione scenica dell’idea che era alla base della creazione del testo.
Questa modalità mi ha permesso di lavorare maniacalmente su ogni singolo momento, per capire insieme agli attori quale fosse il modo più efficace per far funzionare una scena, per costruire l’ordine delle parole che compongono una battuta o per portare un determinato personaggio a un certo stato emotivo. È un lavoro fantastico e credo sia la sublimazione massima di quello che mi piace della scrittura teatrale.
Carta o computer? Che differenza c’è per te? Il mezzo influenza la scrittura?
Ho sempre usato il computer.
La carta solo quella dei quadernini tipo Moleskine, per appuntarmi i pensieri, le frasi degli amici e i “potenziali titoli”. Però a un certo punto – non ricordo quando è stato il passaggio definitivo – li ho abbandonati e ho iniziato a scrivere sulle note del cellulare, che ora sono una specie di scatola nera dei miei pensieri.
Ovviamente il mezzo influenza la scrittura: non ho idea di come sarebbe scrivere qualcosa di lungo e complesso su carta. Come farei poi con le riscritture? Come farei a spostare degli interi paragrafi avanti e indietro? Come potrei scrivere alla stessa velocità con cui penso?
Non lo so.
Hai dei rituali per la tua scrittura? Scaramanzie?
No, nessuna scaramanzia. Una cosa che faccio spesso, quando sto scrivendo un testo nuovo, è ripartire ogni volta a rileggerlo dall’inizio. Voglio dire, se ho scritto sette pagine, prima di mettere giù una parola sull’ottava, riparto a leggermi quelle sette. E così ogni giorno, ogni volta che torno sul testo. Capita spesso, quando magari sono già a metà lavoro, che per giornate intere non arrivo a scrivere niente di nuovo, perché mi fermo a mettere a posto parti precedenti. Quando racconto questa dinamica, le persone tendono a considerarla frustrante, a me invece piace. Rileggo e riscrivo centinaia di volte e la cosa incredibile è che non ho mai la sensazione di perdere tempo. Anche quando magari butto via trenta pagine e le riscrivo da capo. Mai.
Qual è il testo teatrale che nella tua carriera ha rappresentato il momento di svolta? E perché?
I miei genitori non volevano che mi iscrivessi alla Paolo Grassi, “Già hai fatto Filosofia che è una laurea inutile, a cosa ti serve adesso studiare per fare l’autore teatrale?”
Eh, mi serve perché ho scritto due testi, ma ci ho lavorato solo con attori non professionisti e ci sono delle cose che sento di non aver capito, che non funzionano, che non so come si fanno. E quindi ho bisogno di capire, di imparare, di fare pratica. E allora ho pensato che un’accademia, otto ore al giorno, tutti i giorni…
“Otto ore al giorno tutti i giorni?”
Eh, sì.
“A fare cosa?”
Non lo so di preciso, ma immagino… beh, cose che hanno a che fare col teatro.
“Perché?”
Eh, per capire come si fa.
“Cosa?”
Il teatro.
“E poi?”
E poi scrivo dei testi e qualcuno – magari anche io, ma non è detto e comunque non solo – li mette in scena.
“Li mette in scena?”
Sì.
“In un teatro?”
Sì.
“I testi che scrivi te?”
Sì.
“E pensi di camparci?”
Beh… avrei dovuto rispondere che non ne avevo idea perché in effetti no, non ne avevo idea. Però con l’incoscienza dei ventitré anni ho risposto di nuovo affermativamente: sì, mamma e papà, certo, questo sarà il mio lavoro.
Silenzio.
Dubbio.
Sbigottimento.
“Sono sicura che ti prendono. Quando ti metti in testa una cosa, riesci a farla”.
Beh, è una bella caratteristica, no?
“Lo sarebbe, se non ti mettessi sempre in testa le cose sbagliate”.
Dopo aver passato l’esame d’ammissione, ho chiesto ai miei genitori i soldi per l’iscrizione e loro: “Ok, però l’affitto a Milano non te lo paghiamo, se vuoi andarci fai avanti/indietro in treno”.
Quindi sveglia alle sei di mattina, in macchina fino al parcheggio scambiatore più vicino alla stazione di Parma – perché a Reggio ancora non c’era l’alta velocità e avendo fatto un paio di test empirici avevo verificato che andando a prendere il treno a Parma potevo svegliarmi dieci minuti più tardi – poi bicicletta dal parcheggio scambiatore alla stazione, treno fino a Milano Rogoredo, metro gialla fino a Porta Romana, di corsa per viale Bligny e alle 9:30 inizio lezioni in Paolo Grassi.
Alle 18:30 fine lezioni e tragitto opposto. Alle 22:30 a casa, cena frugale e poi a letto. In treno scrivevo la tesi di laurea – perché Filosofia è inutile e Lettere pure, ma comunque dovevo finire la specialistica – e ogni tanto, all’altezza di Piacenza, durante il viaggio di ritorno, piangevo.
Tre mesi dopo i miei genitori hanno constatato che non mollavo e hanno deciso con grande magnanimità di pagarmi l’affitto a Milano, “Però dal giorno in cui finisci l’accademia non ti diamo più neanche un euro, così capisci che hai sbagliato tutto e ti trovi un lavoro vero”.
Io li ho ringraziati e ho iniziato a pensare che avevo due anni e mezzo – non un secondo di più – per riuscire a guadagnare abbastanza, con il teatro, per non dover fare un altro lavoro, per non dovermi pentire amaramente di non aver investito tempo ed energie in nessuno piano B e soprattutto per non dover dare ragione ai miei genitori.
Durante l’ultimo anno di Accademia ho lavorato al mio primo spettacolo da professionista, una riscrittura dell’Isola del Tesoro di Stevenson, con la regia di Marco Maccieri, che aveva appena iniziato a insegnare in Paolo Grassi e mi portava via di nascosto dalle lezioni di Renata Molinari per tornare a Reggio a fare le prove. Poi in autunno, dopo il diploma, quando iniziavo a vedermela brutta, ho vinto il Premio Pirandello con Felicità, dodicimila euro, un sospiro di sollievo – posso andare avanti un altro po’ con l’illusione del teatro.
Ma nessuno sembrava interessato a mettere in scena i miei testi.
Era il 2013, mi sono chiuso in casa per tanti mesi e ho scritto, quasi contemporaneamente, Homicide House e Farfalle. Nell’autunno di quell’anno, con Homicide House ho vinto il Premio Tondelli e alla serata di premiazione, dopo un po’ di vino e tanta euforia, Fausto Paravidino mi ha detto “Goditi questa giornata, perché da domani continuerà a non fregare più niente a nessuno delle cose che scrivi”.
Fausto, ma sono le undici e cinquantatré.
“Va beh, allora goditi questi ultimi sette minuti”.
In realtà, nonostante il suo giusto monito, da quel momento è cambiato tutto, perché all’improvviso i teatri hanno iniziato a rispondermi alle mail. Non tutti, cioè in realtà molto pochi, e sempre con notizie sconfortanti – nella maggior parte dei casi dicevano “No, grazie” alle mie proposte – però mi rispondevano!
Tempo dopo Fabrizio Gifuni mi ha raccontato che Homicide House era nel suo gruppo di testi da leggere – i giurati se li dividono, essendo tantissimi – e che dopo averlo finito ha pensato “Bello, ma adesso come lo convinco Umberto Orsini a premiare una cosa del genere?”
Qualche anno più tardi ho avuto l’occasione di parlare anche con Orsini: dovevamo fare un progetto insieme e lui ovviamente non aveva idea di chi fossi. A un certo punto, a pranzo a Bologna, ho tirato fuori in modo fintamente casuale l’argomento Premio Tondelli e lui, senza esitazione: “Me lo ricordo, quando ero presidente di giuria”.
Ah, sì?
“Sì, sì, certo che me lo ricordo”.
Bene.
“Sono arrivati solo dei testi di merda”.
Ah.
Silenzio.
Cambio argomento.
Ma nonostante il giudizio lapidario del maestro, alla domanda su quale mio testo abbia rappresentato un momento di svolta, rispondo senza dubbio Homicide House, perché mi ha fatto pensare, per la prima volta, che forse i miei genitori non avevano ragione e che forse, ma questo non lo so con certezza neppure adesso, non avevo sbagliato tutto.
A quale dei tuoi testi sei più affezionato? E perché?
L’estinzione della razza umana, perché è stato il primo in cui sono riuscito davvero a fare quel lavoro di riscrittura con gli attori di cui ho parlato qualche risposta fa.
Eravamo chiusi alla Corte Ospitale di Rubiera, durante il Covid, non sapevamo neppure se saremmo mai andati in scena, e siamo stati per quasi tre settimane a tavolino, a leggere, rileggere, analizzare e cambiare ogni scena, ogni battuta. Dopo quei giorni, quando ho detto “Ok, iniziamo a fare memoria”, gli attori hanno chiuso i copioni e lo sapevano già tutto, il testo. L’avevano imparato nello stesso momento in cui, insieme a me, lo stavano riscrivendo, facendo proprie le battute, chiedendomi di invertire una parola, aggiungendo risposte quando sentivano di voler rispondere e tagliando i momenti che risultavano ridondanti. Con quell’esperienza ho messo a punto un metodo di lavoro che ora ritengo necessario e imprescindibile, e sono felice di averlo fatto con un gruppo di amici con cui poi siamo andati in tournée per tre stagioni, con quasi cento repliche, alcune disavventure dovute a una tournée a tratti piratesca e tanti momenti belli.
Quale dei tuoi lavori è stato il più difficile? E perché?
Ricordo con difficoltà, per motivi diversi ma allo stesso tempo simili, i primi lavori che ho fatto su commissione. Per fortuna ho quasi sempre avuto ottimi rapporti umani con le persone, ma non è detto che la sintonia relazionale coincida con una visione artistica condivisa.
All’inizio accettavo di fare tutto, perché volevo lavorare in teatro e non dover dare ragione ai miei genitori che lo consideravano solo un potenziale hobby, ma ho avuto mal di pancia, notti insonni e insoddisfazione ai debutti, non perché gli spettacoli fossero brutti – la “bellezza” non è comunque un criterio oggettivo – ma perché io non mi sentivo di corrispondere a quello che vedevo in scena.
Ora cerco di dedicarmi solo a progetti che ho voglia di fare e questa credo sia la più grande conquista lavorativa, quella che spero di non perdere mai.
La tua scrittura e il tuo metodo sono cambiati nel tempo? Come?
Il metodo cambia ad ogni testo. Posso partire dall’inizio, dalla fine o da un punto qualsiasi che ancora non so dove si posizionerà all’interno del testo. A volte conosco già i personaggi, altre scrivo le battute prima ancora di decidere a chi farle pronunciare. Può capitare che la struttura determini lo sviluppo o che lo sviluppo determini la struttura e così via, le possibilità sono infinite e con ogni testo riparto da zero. La cosa che è rimasta simile è la lingua: si è affinata col tempo, con la pratica scenica e col lavoro insieme agli attori, ma credo che sia abbastanza riconoscibile anche paragonando testi scritti a quindici anni di distanza, perché ha a che fare con il mio modo di parlare e pensare.
Cos’è per te oggi la drammaturgia? Di cosa deve occuparsi? Cosa la distingue dalla letteratura e dalla scrittura per il cinema?
No, per me l’arte non “deve” mai fare niente. L’arte “può” fare delle cose. E spesso “può” fare anche il loro esatto contrario. E va bene così.
Il teatro è la forma che conosco meglio, però ho pubblicato anche un romanzo e scritto/diretto tre cortometraggi e un lungometraggio, quindi posso azzardare un paragone del tutto soggettivo fra le tre forme.
La scrittura per il teatro e per il cinema a me sembrano molto simili, perché il secondo deriva dal primo e sia le drammaturgie che le sceneggiature sono opere “incomplete”, che esistono davvero solo quando incontrano altre persone e fanno parte di un processo di creazione condiviso. La letteratura invece può essere anche solitaria: uno scrittore può chiudersi in casa e creare un capolavoro, dopo essersi nutrito solo della propria vita e di altri libri che ha letto; nel teatro e nel cinema non credo che sia possibile.
Quali sono i testi teatrali di “maestri” che ti hanno influenzato o che hai amato di più?
Finale di partita e Aspettando Godot di Samuel Beckett. Li unisco perché li ho scoperti insieme, uno dopo l’altro, e mi hanno fatto pensare per la prima volta che il teatro non fosse solo un noioso passatempo per vecchi.
Tango di Sławomir Mrożek.
Romolo il grande di Friedrich Dürrenmatt.
Quali sono gli spettacoli importanti della tua vita di spettatore?
Finale di partita di Beckett con la regia di Massimo Castri. Mi ero appena iscritto alla Paolo Grassi e nel frattempo stavo facendo una tesi su Beckett all’Università di Bologna, ma non avevo mai visto in scena un Beckett che mi avesse convinto e iniziavo a temere che i testi fossero più belli letti che rappresentati. Quello spettacolo mi ha persuaso che a volte può essere anche il contrario.
I demoni da Dostoevskij, con la regia di Peter Stein, nove ore appassionanti che mi hanno fatto capire quanto il tempo e la noia siano relativi. A teatro e non solo.
Più recentemente Catarina e la beleza de matar fascistas di Tiago Rodrigues, perché quando l’ho visto a Modena, al Teatro Storchi, non riuscivo a smettere di applaudire e ho pensato: ecco, è il tipo di teatro che sto cercando di fare anch’io, dove scrittura e regia vanno di pari passo per raccontare qualcosa che è ancorato nel presente, ma allo stesso tempo non si “piega” su quel presente in modo cronachistico, ma se ne nutre per affrontare temi “verticali”. Cioè, io ci provo e non sta certo a me dire se ci riesco, lui ci è riuscito alla grande e da spettatore ero estasiato.
Cosa non deve mai fare un’autrice/autore teatrale?
Prendersi troppo sul serio.
Cosa non può mancare in un testo teatrale che consideri ben fatto?
Un momento che stupisca/spiazzi gli spettatori. O almeno, qualche spettatore. Anche solo uno.
Si può davvero insegnare a scrivere un testo teatrale? Fino a che punto?
Quando mi sono iscritto alla Paolo Grassi avevo il pregiudizio che non si potesse imparare a scrivere: o lo sai già fare o non lo saprai fare mai, mi dicevo. E ovviamente speravo di rientrare nella prima delle due categorie. Però allo stesso tempo mi rendevo conto che non ero in grado di restituire attraverso la scena le cose che avevo in testa; ad esempio, se una dinamica mi sembrava paradossale, non riuscivo a scriverla rendendone concreta e efficace la paradossalità, se qualcosa mi faceva stare male, non riuscivo a raccontarla in modo da far davvero percepire quello “stare male” agli spettatori. Mi sfuggiva qualcosa, come quando vedi una partita NBA, poi vai al campetto, prendi il pallone e ti rendi conto che il tuo corpo non sa fare quelle cose che la tua mente immagina. Quindi sentivo la necessità di sapere di più sull’artigianalità del teatro, quali fossero i codici, i metodi, le pratiche. Ma mi dava fastidio l’idea di ammettere che “avevo bisogno di imparare qualcosa di artistico” perché appunto avevo quel pregiudizio del “o lo sai fare, oppure no”.
Per convivere con la paradossalità di questa situazione – l’essere in un’accademia che per tre anni avrebbe cercato di insegnarmi una cosa che io m’illudevo di saper già fare – la mia mente ha messo in atto un auto-inganno di cui mi sono reso conto solo dopo: appena imparavo qualcosa, mi faceva dimenticare di averla imparata e mi faceva credere di averla sempre saputa. Questo a volte mi ha fatto essere un po’ arrogante – e mi dispiace per i miei insegnanti – ma mi ha permesso di impegnarmi il più possibile, sperimentando, senza rischiare di restare annichilito dalla vastità di cose che via via scoprivo di ignorare e muto di fronte alla grandezza degli autori del passato.
Ora riconosco questo auto-inganno e guardo al me stesso di allora col sorriso, perché credo che ci voglia una gran dose di incoscienza per buttarsi a fare qualcosa senza avere idea di come funzioni, ma penso anche che sia l’unico modo per provare a capirlo davvero. Gli “insegnanti”, in quest’ottica, sono più che altro dei compagni di viaggio più esperti, da cui farti aiutare, consigliare, guidare e dai quali distanziarti per trovare a un certo punto la tua “via del Kung Fu”.
Se vuoi aggiungi una tua riflessione.
No, va bene così.
Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.